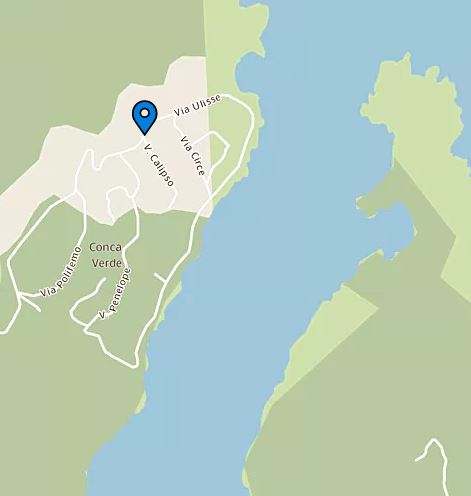ULISSE IN SARDEGNA
La Sardegna nell’Odissea
Navigando con Victor Bérard e Fred Boissonnas
nella costa nord-orientale della Gallura “con gli occhi” di Omero
Un caso culturale di grande fascino
INDICE
cliccare sui titoli
♦ Presentazione di Guido Rombi
1) 1901: IL PRIMO VIAGGIO IN SARDEGNA DI VICTOR BÉRARD
e il libro
♦ 1.1) LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE
Paris, Librairie Armand Colin, 2 v., 1902-1903
con allegate le
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
2) 1912: IL SECONDO VIAGGIO IN SARDEGNA DI VICTOR BÉRARD
CON IL CELEBRE FOTOGRAFO SVIZZERO
♦ UNO STREPITOSO REPORTAGE FOTOGRAFICO DELLA GALLURA COSTIERA
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
3) VICTOR BÉRARD E I SUOI VIAGGI RACCONTATI DAL FIGLIO ARMAND BÉRARD
♦ VICTOR BÉRARD ET LES NAVIGATIONS D’ULYSSE (ca. 1971
di Armand Bérard – Ambassadeur de France
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
4) RECENSIONE ELOGIATIVA DI LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE di V. BÉRARD
♦ LA GÉOGRAPHIE DE L’ODYSSÉE D’APRÈS L’OUVRAGE DE Mr V. BÉRARD
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
5) RECENSIONI IN ITALIA DI LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE di VICTOR BÉRARD
♦ Al primo volume 1903
♦ Al secondo volume 1904, di Giacomo Tropea
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
6) LE TESI DI VICTOR BERARD ANCORA OGGI OGGETTO DI STUDI E DIBATTITO
♦ 6.1) Per una geografia arbitraria: un modesto contributo alla geografia odissea
♦ 6.2) Reimmaginare il Mediterraneo con l’odissea, le mappe e la fotografia.
Victor Bérard, un geografo sulle orme di Ulisse
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
7) AUTORI CHE SI RIFANNO STRETTAMENTE A VICTOR BÉRARD
sul caso ULISSE IN SARDEGNA
(apportando delle modifiche e varianti interpretative)
PHÉNICIENS ET GRECS EN ITALIE D’APRES L’ODYSSÉE
Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1906
∼ ∼ ∼
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
8) Un interessante quadro di insieme dei viaggi sulla scia di Ulisse è in
L’ODISSEA COM’È: CANTI I-XII
di Mario Zambarbieri
Milano, Edizioni universitarie di lettere economia diritto, 2002
PRESENTAZIONE
Un caso culturale di grande fascino mal studiato e mal “usato” turisticamente
dalle Amministrazioni comunali e dagli operatori turistici, pertanto ancora tutto da scoprire e “mettere in scena” come merita
di Guido Rombi
Oggi (ma già dalla metà degli anni Novanta) un turista che vada a Palau, e molto probabilmente al porto, che è il punto più vivo e dinamico del paese, il vero suo centro, si troverà immerso in un dedalo di vie denominate via Ulisse, via Omero, via riva dei Lestrigoni, via dei Feaci, via dei Ciclopi, via dei Lotofagi, via della maga Circe, via Clitennestra, via degli Achei. Si troverà insomma dentro l’Odissea!
Poi, facendo un giretto costiero a Porto Pozzo (distante 20 minuti di macchina), gli capiterà di trovarsi indicata la Baia di Ulisse: la si trova segnata in tante attività ricettizie del luogo, hotel eccetera.
A qualche chilometro, in direzione Santa Teresa, il nostro turista svolterà per Conca Verde e, giunto al piccolo villaggio (del comune di Santa Teresa), si troverà in prossimità della spiaggia dentro un nuovo reticolo di vie “omeriche”: come a Palau anche qui via Ulisse, via Circe, via Calipso, via Polifemo, via Penelope.
La sera, ripensando alla passione dei sardi della costa gallurese nord-orientale per le avventure di Ulisse narrate da Omero nell’immortale capolavoro letterario l’Odissea, ecco che il nostro turista nel suo momento di relax decide di saperne di più, e al computer o sullo smartphone o sul tablet comincia a fare qualche ricerca e su Google: scrive Ulisse + Palau e poi Ulisse + Porto Pozzo.
PER LA RICERCA «PALAU + ULISSE» la risposta più diffusa, collegata a tanti siti di attività ricettizie, mutuata perlopiù dal sito dell’ufficio turistico, è che
«Secondo lo scrittore Victor Berard (sudioso di Omero) Capo d’Orso è l’unica località del mediterraneo che possa essere identificata con la terra dei Lestrigoni [sic !], quella terra cioè, in cui Omero colloca lo sbarco del navigante Ulisse alla ricerca del cibo e l’acqua per l’equipaggio e dove lo stesso condottiero greco conobbe una grave sconfitta. L’episodio è descritto nel libro X dell’Odissea, e narra che Ulisse sbarcò per approvvigionare le sue tre navi in una fonte detta ‘Artacia’(ossia ‘dell’Orso’) e mentre attingeva l’acqua vide alzarsi in lontananza, fra i monti, un filo di fumo, presagio di presenza di genti indigene.
Avvicinatosi a quel luogo incontrò una fanciulla di statura notevole alla quale cercò di rivolgere parola per comunicare, ma questa impaurita, prese a gridare per richiamare l’attenzione degli uomini. Costoro, di statura gigantesca, erano guidati da Antifate, re dei Lestrigoni. Erano un popolo d’antropofagi (cannibali) e fecero banchetto degli uomini d’Ulisse che riuscirono a catturare e con la loro grande forza fisica distrussero ben due delle navi gettandovi sopra dei macigni, perciò lo stesso Ulisse fu costretto a ritirarsi precipitosamente con l’unica imbarcazione rimastagli». https://palauturismo.com/contenuti/62204/roccia-orso
In altri siti sempre in quel di Palau si dice addirittura ««Secondo l’Odissea Ulisse arrivò a Palau con la sua flotta e ci trovò nei pressi un popolo chiamato i Lestrigoni, dalla fama di essere un popolo di cannibali».
Così in un sito di un Hotel 5 stelle, su Capo d’Orso: «Secondo Victor Berard, uno scrittore studioso di Omero, questo luogo potrebbe essere identificato con la terra dei Lestrigoni, giganti cannibali di cui si racconta nel decimo libro dell’Odissea. In cerca di provviste, Ulisse sbarca con le sue tre navi in una fonte detta “Artacia”, cioè dell’orso e QUI incontra una popolazione ostile che fece banchetto del suo equipaggio e distrusse due navi. Lo stesso Ulisse fu costretto a fuggire con l’unica imbarcazione rimastagli».
PER LA RICERCA «PORTO POZZO + ULISSE» troverà:
«Omero nell’Odissea descrive il fiordo di Porto Pozzo con il termine “La Profonda Ria”».
«La leggenda narra che nella profonda “ria” Omero immaginò l’incontro di Ulisse con i Lestrigoni di qui il nome “Baia di Ulisse”». [Sic! incomprensibile]
«Baia D’Ulisse, il leggendario nome della località di Porto Pozzo [sic!]. Si racconta infatti che in questo fiordo sia avvenuto l’immaginario incontro tra Ulisse e i Lestrigoni, popolo immaginario di giganti che Omero colloca in una terra identificata proprio con la Sardegna [sic!].
Quindi tenterà qualche sondaggio anche PER SANTA TERESA GALLURA: e qui solo una risposta, ma molto interessante! Un intervento alla Camera dei deputati di un parlamentare sardo, nel 1997, che criticando l’invito fatto dal sindaco a Vittorio Emanuele IV di partecipare alla festa di anniversario della fondazione del paese, disse:
GIOVANNI MELONI [PCI] : «… Questa cittadina celebra nei prossimi giorni, esattamente il 12 agosto, il quasi bicentenario della sua fondazione che viene fatta per i tempi moderni risalire alla Casa Savoia, ma che in realtà data ad un periodo molto più antico; vi sono addirittura degli studiosi che ritengono che l’episodio relativo ai lestrigoni e ad Ulisse si sia svolto nel fiordo di Santa Teresa, che si chiamava allora Lungoni.
PRESIDENTE [Luciano Violante]. Quelli di Porto Pozzo la pensano diversamente.
GIOVANNI MELONI. Quelli di Porto Pozzo forse la pensano diversamente, però la struttura dei luoghi sembrerebbe dare ragione ai teresini».
Simpatico siparietto che nel mostrare come la notizia di Ulisse in Sardegna, prima dell’era Internet fosse già conosciuta, dice come a Santa Teresa ci fossero dei critici che avrebbero voluto che invece lì fosse localizzata la scena omerica.
A questo punto al turista che, oggi, appassionato di cose culturali in senso lato, desiderava capirne qualcosa, non resta che ammettere di averci capito poco: solo di aver letto un guazzabuglio di brevi notizie incerte, contradditorie, oscure, e senza fonti, eppure capaci finanche di incidere nella toponomastica locale, a modificare magari, come a Palau, vecchie intitolazioni identitarie a vantaggio di quelle omeriche dell’Odissea: quindi tutte animate dal sicuro proposito di poter vantare dinanzi al mondo turistico internazionale che Ulisse fosse sbarcato proprio e solo lì.
E così, nel silenzio notturno dell’estate, tra grilli e civette e abbaiare di cani e ragli di asini al passaggio dei cinghiali, nella veranda affacciata alla macchia mediterranea, il nostro turista che per coincidenza è anche uno storico e autore di libri decide che il “Caso Ulisse in Sardegna” vada studiato e ricostruito per filo e per segno e presentato ordinato al mondo per far sì che altri non abbiano a trovarsi dentro la stessa incomprensibile matassa e possano raccappezzarcisi.
Al termine di un lungo e faticoso studio, fatto di ricerca e spoglio delle fonti, e di traduzione, il “nostro” decide di consegnare gli esiti a Gallura Tour che, dopo averli letti e approvati, provvede volentieri a pubblicarli nel lungo reportage sotto riportato, di cui qui anticipiamo il RESPONSO INEQUIVOCABILE:
Ulisse navigò tra Capo Testa e Capo d’Orso, e a Capo d’Orso approdò e mise piede a terra SOLO per approvvigionarsi di acqua, MA i Lestrigoni – i sardi che dovevano popolare l’immediato entroterra per tutta la costa e particolarmente quelli di San Pasquale e dintorni – di cui l’eroe aveva incontrato una fanciulla alla fontana, tesero l’agguato alla sua flotta NON a Capo d’Orso, MA a Porto Pozzo, distruggendo due delle tre navi, massacrando gran parte dell’equipaggio e costringendo l’eroe ad una rocambolesca fuga.
E poi a dirlo NON è l’Odissea, e NON la leggenda, MA sono degli studiosi, primo fra tutti il più illustre, il francese VICTOR BÉRARD.
Perciò praticamente tutte le “narrazioni” – e si ripete Tutte – che si trovano nel web riguardo Ulisse in Sardegna non sono corrette e quindi non vere.
Il sottoscritto presentatore – nonché turista sopraccitato – ha avuto fortuna a salvarsi dalle notizie “locali” su internet, del copia e incolla con condimenti aggiuntivi. La prima idea che mi feci quando scoprii “il caso” fu che fosse la “boutade” di un intellettuale buontempone e stravagante, che doveva averla buttata giù così, tanto per “fare rumore”. Venendo da tutt’altro genere di studi, quelli delle età storiche in cui la ricostruzione è più “raggiungibile” con evidenza e “prove provate”, il primo istinto intellettuale fu – sbagliando – del tutto negativo, prevenuto. Poi, però, la considerazione del mio assai scarso bagaglio in materia, fermo a vaghe reminiscenze liceali, lo spirito di capirci qualcosa di più – la curiosità! – mi hanno spinto ad affrontare il “caso Ulisse in Sardegna” con la giusta (imparziale) disposizione d’animo. E, dopo aver molto letto ricostruendolo, la mia personale idea è che per criticare Victor Bérard occorrerebbe avere un ricchissimo se non straordinario bagaglio culturale in più discipline collegate allo studio delle civiltà antiche: le sue tesi possono certo essere criticate ma soprattutto dovrebbero essere confutate producendo incontrovertibili prove degli errori delle sue invenzioni.
In questo dossier saranno proposte più voci: recensioni favorevoli e ferree critiche delle sue tesi (soprattutto quelle di una studiosa sua connazionale – Sophie Rabau – che sembra quasi sarcastica sulla sua narrazione e definisce il suo operato e metodo «geocriticismo», «geografia fantastica», nel Sessantotto si soleva dire “immaginazione al potere”, ma non fornisce una sola prova dei suoi certi errori). E’ anche da dire che Bérard non fu certo l’unico a cimentarsi nella ricostruzione dei viaggi di Ulisse, e al riguardo si propone al lettore qualche lettura per cominciare a farsi di suo una idea. In tanti ci si sono provati e altri ancora tenteranno. Quelle sulla Sardegna sono state riprese tra gli studiosi sardi “di rango” da Massimo Pittau, studioso e accademico della lingua etrusca, della lingua sarda e protosarda, e inevitabilmente anche appassionato cultore della storia e archeologia e geografia antica, ispirandolo chiaramente a dar vita al suo Ulisse e Nausica in Sardegna (ed. Insula, Nuoro, 1994). Di sicuro Bérard fu quello che più fece rumore, ma ciò in forza delle sue riconosciute competenze di studioso delle antiche civiltà, in specie dei fenici e dei greci, cui aggiunse – tra i primi a farlo – l’applicazione non solo degli studi di navigazione ma finanche la pratica della stessa: che intellettuale, che personaggio, comunque la si pensi!
Intendiamoci: niente da dire che su quel passaggio di Ulisse nelle acque di Palau e ad una fontana dalle parti di Capo d’Orso, si sia imbastita una chiara operazione di marketing turistico da parte del comune e altri operatori. Il rilievo critico è che si sarebbe potuta (e si potrebbe) imbastirla correttamente producendo un vero arricchimento culturale.
Altro rilievo critico: il grande sfruttamento turistico di Ulisse in Sardegna (o meglio dire di questa ipotesi storica), sarebbe però dovuto essere principalmente appannaggio di Porto Pozzo (e quindi del comune di Santa Teresa Gallura). E invece, salvo che per l’intitolazione delle vie di Conca Verde, località turistica nata recentemente su un lato della costa della lunga insenatura, questo non è successo. Porto Pozzo, il luogo più citato nella narrazione di Bérard è rimasto escluso dal marketing turistico collegato alla notizia. Salvo qualche maldisposta citazione che definisce Porto Pozzo la Baia di Ulisse, il comune di Santa Teresa Gallura così come gli operatori turistici non hanno investito sullo sfruttamento commerciale-turistico della notizia che lì – proprio a Porto Pozzo – per Bérard (e non solo) sia avvenuto il massacro della flotta di Ulisse da parte dei sardi Lestrigoni. D’altronde se non c’è la cultura a supporto non si può fare nessuna vera promozione turistica, non possono nascere idee e progetti. Ora la cultura a supporto c’è, grazie a Gallura Tour.
Sarebbe poi il caso che le notizie riportate nei siti – che sono tutte errate – venissero subito rettificate, a partire da quelli dei comuni. (Però quel che si deve evitare, a partire dai siti istituzionali, è un uso poco accorto di impegnative pagine culturali. Si può – e si deve! – anche fare marketing turistico nel corretto rispetto della cultura, sempre esigendo che quanto si pubblica in un sito istituzionale sia stato valutato molto attentamente).
Quel che conta è che d’ora in poi tutti coloro, sardi e continentali, residenti e turisti continentali e stranieri, se mai dovessero chiedersi perché questa toponomastica dell’Odissea a Palau come a Conca verde – Santa Teresa, lo sappiano in modo esatto e possano anche facilmente leggere alla fonte – grazie a Gallura Tour – cosa disse Bérard e, se interessati dal “caso”, spingersi oltre. E per i francesi che non sapessero di Victor Bérard e gli svizzeri che non sapessero di Frédéric Boissonnas (conosciuto come Fred e così di seguito sempre citato), ci sarà anche un po’ di soddisfazione.
A proposito: stride fortemente che dopo aver solo “sfruttato” (o piuttosto tentato di sfruttare) a fini di marketing la visione di Bérard, al celebre studioso francese ridisegnando la toponomastica urbana sulla base della fascinosa notizia di Ulisse da queste parti, al celebre studioso francese non sia stata dedicata una via, ben al centro del reticolo viario dedicato all’Odissea. Pur con errori, in alcuni siti lo si dice che “dietro” Ulisse e i Lestrigoni in Sardegna vi è un certo «studioso Bérard». Insomma, una via Victor Bérard a Palau, Porto Pozzo e Conca Verde, era e sarebbe un riconoscimento meritato, un atto dovuto! Così come meriterebbe altre apposite iniziative culturali-turistiche in suo onore, magari chiamando a partecipare anche i nipoti Étienne Bérard et Reine-Marie Bérard, autori di interessanti pagine biografiche e illustrate – L’eredità di Victor Bérard – per il libro Portraits de Victor Bérard. Actes du colloque international organisé à l’Ecole française d’Athènes (5-6 avril 2013, Athènes. Sophie Basch, 2015).
E una via e qualche iniziativa di plauso e riconoscenza meriterebbe senza dubbio anche il grande fotografo suo amico Fred Boissonnas, rimasto del tutto ai margini: praticamente sconosciuti il suo nome e le sue foto! Eppure SONO SUE le prime belle foto della Costa sarda da Capo Testa a Golfo Aranci vista dal mare!
Ecco: due vie disposte vicine intitolate a Victor Bérard e Fred Boissonnas, incastonate nella toponomastica urbana odisseica, potrebbero incuriosire i turisti francesi molto più di una via Calipso e dei Lotofagi: sarebbe una corretta e meritoria operazione culturale e insieme di marketing turistico.
Altre idee di marketing turistico all’attenzione dei due comuni insieme, e di intraprendenti operatori turistici e della nautica: e l’idea di una “Regata di Ulisse” da Capo Testa a Capo d’Orso, che potrebbe essere estesa fino a Castelsardo, sulla base delle osservazioni di Champault e fino a Porto Cervo sulla base di quelle aggiuntive di Massimo Pittau? Regata che potrebbe avere a corollario avvenimenti culturali (letterari – artistici – musicali – folclorististici con partecipazione di intellettuali internazionali e artisti e gruppi folk Sardi e Greci).
E mettere in scena nella baia di Porto Pozzo, magari nella parte prospiciente Conca Verde, l’assalto dei Lestrigoni a Ulisse e suoi uomini? In anni in cui si mette in scena di tutto, perché no? Ci sono così tanti operatori turistici che hanno imbarcazioni a vela da mettere a disposizione… poi si possono realizzare enormi massi finti in cartapesta, e magari in notturna fra falò e mortaretti dar vita alla scena odisseica.
Gallura Tour con questo imponente reportage ha fornito l’indispensabile supporto culturale e di idee. Ad altri fare il resto.
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
Infine, non si può non richiamare appositamente l’attenzione su delle pagine di grandissimo interesse anche per la cosiddetta storia locale che partecipa pure essa, nell’insegnamento della Scuola degli Annales, alla grande storia. Stiamo dicendo delle Note di viaggio, seppure curiosamente non evidenziate come tali (e così quindi riproposte). Un capitolo totalmente diverso e distinto dal resto del libro: appunti registrati in presa diretta nel maggio 1902, per l’esattezza dal giorno 18. Pagine imperdibili per i cultori di storia sarda e gallurese. Tante le scene che resteranno scolpite alla memoria dopo averle lette. Victor Bérard gira per tutta la costa da Golfo Aranci a Capo Testa in compagnia della moglie Alice Colin (è la figlia dell’importante editore Colin, impresa che passerà alla sorella e al cognato e che editerà la gran parte delle sue opere). Principalmente la perlustrazione è sul mare e dal mare, di cui fornisce le coordinate essenziali, con puntatine via terra laddove necessario, per esempio a Porto Pozzo per avere una conoscenza più circostanziata del luogo.
A Palau, non diversamente dalla gran parte dei luoghi di mare, non si faceva commercio di pesce, ma di carbone. Carbone che proveniva da Tempio e che veniva smerciato anche all’estero. Sono gli anni dell’energia a vapore, il suo alimento era il carbone, la richiesta altissima in ogni dove, anche in Sardegna. Davanti alle quattro locande (così tante?) non ci sono auto: «sulla strada, in fila, salgono e scendono solo carri a buoi, pieni di carbone o vuoti».Allineati sul porto nove grandi cumuli (vere “montagne di carbone”). I Bérard li fotografano, grazie ad essi abbiamo questa immagine inedita del porto di Palau dal mare, mai vista, la più nitida tra quelle inserite, che veramente sposa bene la descrizione. Si faccia attenzione alla didascalia della foto: «Il porto del carbone», così scrive Bérard.
Non mancano anche momenti avventurosi e palpitanti durante la “crociera” di studi che il francese descrive con buon senso dell’umorismo: mentre sono in navigazione subiscono l’alt e l’assalto alla barca dai gendarmi della capitaneria di La Maddalena. I coniugi vengono arrestati.
Ma forse il pezzo forte è per i cultori delle tradizioni locali: riguarda Antonio, il musicista itinerante, che armato di chitarra e mandolino, di ritorno dalle feste di San Pasquale dove ha cantato e suonato per 2 o 3 giorni di fila, chiede loro il passaggio barca per Santa Teresa Gallura. Cade sfinito in un sonno profono, al risveglio la navigazione prosegue fra canti e vino.
***1901: IL PRIMO VIAGGIO IN SARDEGNA DI VICTOR BÉRARD
dal suo libro
1.1) LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE (I Fenici e l’Odissea) – Tomo II
Paris, Librairie Armand Colin, 1903
Capitolo Ottavo: Aiolos e i Lestrigoni – Paragrafo II: I LESTRIGONI
QUI IL TESTO IN LINGUA FRANCESE
prima traduzione in italiano di Gallura Tour
(in lavorazione e suscettibile di piccole revisioni)
Da lì salpiamo al più presto, con il cuore spezzato: il morale dei miei uomini era aggravato dalla fatica del remo; grazie alla nostra follia non avevamo più la certezza del ritorno. Così per giorni e notti, senza sosta, navighiamo. Il settimo giorno arriviamo alla città alta di Lamos, Telepylos di Laistrygonia, dove il pastore chiama il pastore che entra, e il pastore che esce gli risponde. Là un uomo insonne otterrebbe entrambe le ricompense, lavorare come pastore e prendersi cura delle pecore bianche, perché i sentieri della notte e del giorno sono vicini. Siamo giunti a un famoso porto circondato da un ripido bordo di pietra: a destra e a sinistra, scogliere aggettanti si fronteggiano e avanzano a formare la foce: l’ingresso è molto stretto. Tutta la mia flotta entra in questo porto e ormeggia in fila: non il minimo moto ondoso, grande o piccolo; ma tutt’intorno alle navi, bianca calma. Io solo rimasi fuori e, proprio sull’orlo della stretta, legai la mia nave a una roccia. Poi sono salito su un ripido belvedere dove mi trovavo. Non si vedeva nulla: nessuna traccia di esseri umani o di bestiame; solo noi abbiamo visto il fumo salire dalla terra. Così ho mandato i miei uomini in esplorazione, per scoprire chi fossero i mangiatori di grano di questa terra. Due uomini, distaccati con un araldo che li precedeva, sbarcarono e, su una strada pianeggiante, per la quale, dalla cima dei monti, i carri discendevano il bosco della città, incontrarono una fanciulla, la forte figlia di Leistrygon, Antifate, che veniva a prendere l’acqua alle porte della città, e che scendeva alla sorgente dell’Orsa con la sua bella corrente.
Artakiè, la Sorgente dell’Orso, Άρτακίη, nota ai poeti e ai geografi successivi, non era situata nei mari occidentali. All’altro capo del mondo attico, sgorgava sulla riva del Mar di Marmara, nell’Isola dell’Orso, Άρκτων Νήσος [1]. L’Isola dell’Orso è diventata per i nostri naviganti attuali una penisola: la penisola di Artaki, poiché una striscia di paludi univa alla vicina costa dell’Asia Minore: in passato la città greca di Kyzique, costruita sull’isola, era unita da due ponti alla terraferma.
«La penisola di Artaki, dicono le Istruzioni Nautiche [2], chiamata dai turchi Kapou Dagh, è una considerevole massa montuosa, attualmente unita al continente da un istmo basso e stretto, largo un miglio; ma in origine era un’isola. Delle due grandi baie formate su ciascun lato dell’istmo, quella occidentale o Baia d’Artaki è la più utilizzata come ancoraggio, perché i venti di Nord-Est soffiano forte in tutte le stagioni su quella ad Oriente o Baia di Peramo…. L’antica Cizico si trova in pianura, ai piedi delle colline, che terminano con l’istmo paludoso. Oggi sul sito di questa grande e ricca città rimangono solo poche rovine».
In questa baia di Artaki, così protetta dai venti di Nord-Est, c’è un ancoraggio particolarmente favorevole, particolarmente comodo per i marinai primitivi: è addirittura l’ancoraggio tipico per loro, grazie a un piccolo promontorio staccato dalla grande isola, Mourad Baïr, grazie a due isolette che vi si affacciano, Towshan Ada e Zeitun Ada, e grazie a una sorgente abbondante, che era la nostra sorgente dell’Orso, Artakiè. Questo ancoraggio e la città vicina erano e sono tuttora la città dell’Orso, Artakè. Nella pianura di fronte alla terraferma e al confine con lo Stretto, Kyzikos era la città dei coloni greci. Ma altri marinai avevano frequentato queste acque prima degli Elleni e Artakè offriva loro un sito migliore per un posto di commercio.
Dobbiamo sempre ritornare alla nostra legge delle capitali insulari e all’esempio caratteristico di Rodi o Taso. La città di Rodi sullo stretto, di fronte al continente, nella pianura insulare, fu la capitale stabilimento dei coloni ellenici: Lindos, il cui promontorio si appoggia alla montagna e che punta verso il mare aperto il suo porto popolato da isolotti, era stata la stazione commerciale degli antichi navigatori. Sulla nostra Isola degli Orsi, Kyzikos occupava il posto di Rodi; è probabile che Artakè avesse ricoperto il posto di Lindos: da qui la fama di questa Artakiè fonte tra i primi eposologi e nelle antiche leggende argonautiche [3].
Erdek o Artaki è oggi un grande villaggio, in fondo a una piccola insenatura sabbiosa, «appena a Nord della punta Mourad Ber. Occupa il sito dell’antica città greca di Artakè e conta dai 4000 ai 6000 abitanti. Le provviste sono abbondanti; vi viene raccolto un vino bianco molto pregiato. Zeïtun Ada è un mucchio di roccia situato a circa 1/3 di gomena [60 metri]*** dalla città di Artaki; è aperto a molte fondazioni. Mourad Baïr o collina di Saint-Siméon è una punta [o meglio un’antica isola saldata alla terraferma] di forma conica, alta 103 metri e un tempo fortificata, poiché esistono ancora resti di mura e torri sul suo lato Nord, rivolto verso Est terra. Towshan Ada [è un isolotto] che forma con Mourad Baïr il canale Siméon… La baia offre un ancoraggio spazioso e tranquillo con qualsiasi tempo, eccetto i venti da Sud-Ovest. Ma questi venti da Sud-Ovest, tranne che in inverno, sono generalmente rari e vengono annunciati con largo anticipo da un abbassamento del barometro e da un aspetto minaccioso del tempo al Sud. Durante l’ancoraggio nel Sud-Est da Mourad Baïr, comunichiamo facilmente con la città di Artaki [4]. ***[Nota: la gomena, grosso cavo di canapa composto di diverse corde attorcigliate, in passato in marina era usata anche come misura di lunghezza nautica pari a un decimo di miglio marino, 182 metri].
Questa, penso, è un’ottima stazione per i primi conquistatori. E qui, sull’altra facciata, c’è l’insediamento dei coloni ellenici.
Kyzikos è, nella Propontide, unita al continente da due ponti: la città è alla fine dei ponti, nella pianura dell’isola, contro la montagna. Il monte è il Monte degli Orsi, Άρκτων Όρος, sopra il quale si erge il Monte Dindyme con un tempio della dea Dindyménè, fondazione degli Argonauti… Nella stessa isola dei Kyzikeniani, si trova il Monte Artakè, ricoperto di foreste, con un isolotto omonimo che si trova di fronte, e non lontano da lì incontriamo il promontorio Melanos… I Milesi fondarono Artake e Kyzikos [5] …
È a questa sorgente e a questa postazione dell’Orso che dobbiamo collegare la nostra avventura odissea?
Nei mari occidentali, oltre le Bocche di Bonifacio, si trova per i navigatori recenti un altro Promontorio dell’Orso, quasi altrettanto famoso:
«A Sud Ovest della Punta Palau la costa presenta alcune insenature poco importanti fino a Capo d’Orso. Questo promontorio termina con una montagna spoglia, alta 130 metri e che porta lo stesso nome, in cima alla quale sporgono rocce, disposte in modo tale da rappresentare quasi esattamente la forma di un orso, da qui il nome dato alla montagna e al promontorio».
Fonti. — Nell’angolo occidentale della baia di Palau, vicino al villaggio con lo stesso nome, c’è una sorgente dove si può attingere l’acqua. Questa sorgente rifornisce da tempo l’arcipelago della Maddalena; tuttavia a volte si secca [6].
Questa Fontana dell’Orso è tanto più importante da conoscere per i navigatori in quanto in questa regione granitica le sorgenti sono scarse o molto scarse. Le nostre Carte nautiche e le nostre Istruzioni non dimenticano mai di indicare i punti più piccoli di questa costa dove il navigatore può far scorta di acqua.
La costa, molto frastagliata, è costellata di isole, lunghe penisole e rade chiuse, che delimitano o bloccano un passaggio molto trafficato: è questa, nelle Bocche di Bonifacio, la sponda sarda di fronte alle isole di Caprera, S. Stefano, Maddalena e Spargi. Le enormi fortificazioni e l’arsenale, che gli italiani costruirono in questo passaggio, mostrano chiaramente quale ruolo abbia sempre avuto per le comunicazioni tra il mare orientale degli italiani e il mare occidentale dei francesi o degli spagnoli.
Questa è davvero l’entrata e l’uscita verso i mari italiani. Chiunque volesse possedere o sfruttare questi mari, aveva sempre bisogno di una stazione di monitoraggio in questo stretto. Oggi i piemontesi, padroni d’Italia, vi hanno puntato i loro cannoni e siluri: il governo italiano ha stabilito alla Maddalena grandi depositi di viveri e di carbone, macchine per la distillazione dell’acqua; ma il paese offrirebbe poche risorse alle navi straniere [7].
Durante le guerre napoleoniche, Nelson e i dominatori inglesi, dopo aver messo le mani su questa porta dei due mari, vi installarono permanentemente parte della loro flotta; sotto il nostro Capo d’Orso, la baia con una spiaggia sabbiosa in fondo si chiama ancora porto di Agincourt, per via della sosta che vi fece la nave inglese con quel nome; questo porto, riparato da isole, è sicuro e conveniente per navi di tutte le dimensioni [8].
Altra causa del grande repentino sviluppo che la Maddalena ebbe e della spiccata preferenza dei suoi abitanti per il mestiere di marinaio, fu la lunga permanenza che l’ammiraglio Nelson fece in queste zone con la sua flotta. Così, dice Valery, questa località divenne un ricco e vasto magazzino di merci inglesi durante il blocco continentale. Il punto preferito del futuro vincitore di Trafalgar era lo spazio di mare che separa la Maddalena dalla Sardegna, chiamato porto Il Parau o Agincourt. Fu lì che questo instancabile marinaio spiò gli squadroni francesi se avessero tentato una seconda spedizione in Egitto. Si dice a questo proposito che Nelson non scese mai a terra, perché aveva giurato di non lasciar la nave finché non avesse sconfitto i nemici. La sua continua permanenza sulla sua nave non gli impedì di fare elargizioni agli abitanti del luogo, che mostrano candelieri e una croce d’argento, con un Cristo d’oro, donati alla loro parrocchia da questo ammiraglio protestante [9].
Prima degli inglesi, i conquistatori francesi o spagnoli avevano fatto gli stessi tentativi su questo stretto. Ma, volendo bloccare le vie verso l’Egitto e i mari orientali, fu nei porti orientali del passo che Nelson si stabilì. I porti dell’ingresso occidentale erano invece i punti di attacco di francesi e spagnoli.
«Il porto di Longon-Sardo è noto alla storia dell’isola nel Medioevo, per via di una fortezza di cui si possono ancora vedere i resti. La prima menzione di questa fortezza risale all’anno 1588; con la pace stipulata tra la principessa Eleonora d’Arborea e il re d’Aragona, la fortezza fu ceduta a quest’ultimo. Nel 1589 gli Aragonesi lo fortificarono e, nel 1591, attirarono nuovi abitanti nel comune di Longon-Sardo. Nel 1592 gli Aragonesi rinforzarono il presidio, che l’anno successivo fu assediato dalle truppe arboree. Ruggero di Moncada fece revocare l’assedio nel 1594… Il 4 agosto 1410 Cassiano Doria conquistò Longon-Sardo. Nel 1419 dovette appartenere nuovamente ai Doria, perché fu loro tolto nel 1420 dalle truppe reali [d’Aragona]… Nel 1422 Longon-Sardo fu assediata e distrutta da una flotta genovese, che trasportò Genova parte gli abitanti. Allora il re ne ordinò la demolizione, che fu effettuata entro l’anno… Da allora questo luogo è rimasto del tutto spopolato.
Il 18 giugno 1802, un prete sardo fuggitivo, di nome Sanna, [occupò] momentaneamente la torre di Longon-Sardo. Questo Sanna venne dalla Corsica insieme ad altri congiurati con l’intenzione di rivoluzionare l’isola: presero di sorpresa questa torre dove sostituirono la bandiera francese con quella sarda. Ben presto furono attaccati dalle truppe reali.
Questo scontro diede al governo sardo la prima idea di insediare una popolazione su questo importante punto dove è facile arrivare dalla Corsica. Il Duca di Ginevra, nel marzo 1805, diede l’autorizzazione a costruire case nei pressi della torre Longon-Sardo. Nel 1808, quando questa popolazione era in crescita, il re Vittorio Emanuele I sancì l’erezione del borgo al quale impose il nome della moglie Maria Teresa d’Austria. Questo villaggio di Santa Teresa è percorso da strade parallele, disegnate in linea retta e che si incrociano ad angolo retto. [10].
Oggi, se i dominatori inglesi non hanno tentato nulla per ricollocarsi in questo corridoio, è perché l’alleanza italiana ne ha sempre garantito il libero utilizzo: nel deposito e arsenale italiano della Maddalena, le flotte inglesi credono di avere la certezza di trovare il rifugio e il sostegno necessari in ogni momento.
Durante l’antichità classica, questo stretto non era così importante: un po’ trascurato dai Greci e dai Romani, la Corsica e la Sardegna rimasero separate. Le grandi rotte commerciali del mondo classico correvano, sia a Nord che a Sud, lungo le coste della Provenza o quelle africane. Lungo queste coste passavano poi le grandi strade dall’Oriente all’Occidente, dai mari levantini ai mari occidentali.
Ma possiamo facilmente immaginare che, nel Mediterraneo primitivo, lo stretto fosse già quello che è oggi. Proprio di fronte ad Iperia con le sue vaste campagne, era già la rotta delle flotte verso i mari della notte, verso la misteriosa Calipso. Era anche la strada che, dall’isola di Ai-oliè, conduceva ai grandi golfi del Nord, alle località di Marsiglia o Monaco. Nell’antica onomastica dello stretto credo che sia rimasta per tutta l’antichità una memoria di questa prima epoca. Sul passo, l’estremità settentrionale della Sardegna mantenne sempre il nome di Capo della Notte, Έρεβάντιον άκρον.
«Έρεβάντιον άκρον, Capo della Notte, viene così chiamato in contrapposizione al giorno, cioè a mezzogiorno; questo nome corrisponde a quello di Mezza-notte che gli darebbero gli italiani e che potrebbe indicare il promontorio settentrionale dell’isola. Questo promontorio non può quindi essere collocato altrove che sulla Punta della Marmorata o sulla Punta del Falcone, che hanno la latitudine più alta di tutta la Sardegna». [11].
Non è solo l’opposizione tra il mezzogiorno e l’ombra della mezzanotte, tra il Sud e il Nord, che qui segna il Capo dell’Erebo: lasciando queste sponde, Ulisse volgerà le spalle al tramonto e andrà, attraverso il mare orientale, verso l’italiana Kirkè che è appena ad Est del nostro stretto, Kirkè «dove sono le case dell’alba con cori e albe». [12].
Torneremo su questo testo e lo esamineremo minuziosamente quando tratteremo di Kirkè. Ma questo spiega chiaramente, credo, il nome di Capo Erebus.
Ai piedi di questo promontorio sardo i sentieri passano dal giorno alla notte, dall’alba al tramonto. In un verso, il poema dell’Odissea ci dice la stessa cosa sulla terra dei Lestrigoni: molto vicini sono i sentieri della notte e del giorno.
Dal Caos nacquero Erebo e la Notte e, da questi, Aither ed Emera, dice Esiodo [13]: Erebo è, come vediamo, parente stretto della notte e del giorno.
Questo stretto di Sardegna è ricco di golfi e di comodi ancoraggi. Ma l’impianto di macchine per la distillazione nell’isola della Maddalena fu reso necessario dalla scarsità o dalla scarsa abbondanza di acqua.
Le Istruzioni indicano le fonti più piccole dove si può attingere l’acqua:
«Si può prelevare dell’acqua in fondo al porto, vicino al Campo Santo, ma quella che si trova vicino alla torre è di qualità superiore… L’acqua si può attingere dal piccolo ruscello che scorre in fondo alla baia… L’Isola di Caprera, più fertile della Maddalena, ha abbondanti sorgenti» [14], ecc.
Le vere e proprie fontane si trovano tutte nelle vicinanze dell’Orso.
Proprio ai suoi piedi si trova la grande sorgente di questa regione, la sorgente Palau, già descritta: forniva acqua all’isola della Maddalena prima dell’insediamento delle macchine distillatrici. Sull’isola opposta di S. Stefano le carte nautiche indicano un’altra fonte. Nella cala di Trana «c’è un’ottima sorgente alla quale possono attingere l’acqua le navi ancorate nel porto di Mezzo Schifo».
In tutti questi punti è l’Orso che deve fungere da guida. Perché le mille punte, rocce, scogli, isolotti e promontori di questa costa sarda e delle isole vicine presentano agli occhi del timoniere solo un’indiscernibile confusione. Il caos granitico che ricopre entrambi i bordi dello stretto renderebbe i punti introvabili allo straniero.
Ma, stando in cima alla sua montagna, stagliandosi molto chiaramente nel cielo e puntando lontano nel mare, l’Orso presenta a tutti gli occhi la sua sagoma facilmente riconoscibile; una volta scoperto, è impossibile dimenticarlo: «Il promontorio dell’Orso» – disse la Marmora [15] -, «è così chiamato per via di uno scoglio granitico che si intravede quasi alla sua estremità; guardato da un certo punto, dal lato de La Maddalena, presenta la forma di un orso e anche di un orso bianco, come possiamo convincerci dalla figura che ho ripreso io stesso dal punto sopra indicato».
La Marmora infatti dà la forma di questo promontorio: è un caos di graniti, sul quale sta in agguato un orso; con la schiena rotonda e il collo allungato, questo orso polare sembra annuire con la testa. La Marmora aggiunge:
«Questa roccia offriva già questa singolare somiglianza quasi duemila anni fa, perché Tolomeo, nella sua geografia, indica questo luogo sotto il nome di Άρκτου Άκρα, Promontorio dell’Orso; ciò dimostra quanto tempo impiegò [in passato] la massa di granito ad assumere questa forma a seguito della decomposizione della pietra, operata dagli agenti atmosferici, e quanto breve sia lo spazio di venti secoli per produrre un notevole cambiamento su questa roccia, che molto probabilmente è ancora così come la osservava al tempo del geografo greco. Tolomeo, infatti, già battezzava questo Promontorio dell’Orso». [16].
Queste zone dell’Orso non hanno solo acque, ma anche tutta una serie di ottimi ancoraggi, alcuni sulla costa sarda, altri sugli isolotti vicini, alcuni in porti aperti, altri in porti interni e anche in quasi lunghi vicoli ciechi. completamente chiuso. Questi ancoraggi chiusi sono la caratteristica di questa costa Nord-orientale della Sardegna. Dall’altro lato, l’isola è scarsamente provvista di ripari e addirittura, per centinaia di chilometri, ne è del tutto priva.
Questa costa Nord-Est, invece, non è che una serie di rifugi: da Porto Longone [Santa Teresa Gallura] che si apre nello stretto stesso, di fronte alla Corsica e a Bonifacio, al Golfo di Terra-Nova che si affaccia sul Mar Tirreno e riceve la posta di Civitavecchia ogni giorno, nove o dieci porti e baie si susseguono, quasi parallele, tutte penetrando profondamente nella massa delle rocce.
La baia di Arzachena si estende per più di due miglia e mezzo direttamente a Sud, dove termina in paludi… La baia delle Saline, situata un miglio a Sud di Capo Orso, è aperta verso l’Est, ma è in parte riparata dalla punta Rossa dell’isola di Caprera… La Punta Sardegna, liscia e salubre, forma una baia con sul fondo una spiaggia sabbiosa, che fu chiamata porto di Agincourt per la sosta che vi fece l’omonima nave inglese. Riparato dalle isole, è sicuro e conveniente per navi di tutte le dimensioni; lì il mare non è grosso e la tenuta è buona…. La Cala di Trana, caletta con spiaggia sabbiosa, è aperta a Nord e frequentata dai costieri: ha un’ottima sorgente. [17].
Man mano che si avvicinano alle Bocche e attraversano successivamente tutti i piccoli stretti insulari, le navi, provenienti dall’Oriente e dai mari italiani, incontrano ancoraggi che, sempre più sicuri, somigliano sempre più al profondo [lungo] porto di Lestrigoni.
Finora abbiamo avuto baie lunghe e ampie. Qui ora ci sono porti semi-chiusi o addirittura completamente chiusi. Porto Pollo è il primo di questi ancoraggi, profondamente nell’entroterra e circondato da un bordo di pietra, dove il mare è sempre più calmo, dove a volte troviamo una calma piatta:
Porto Pollo è una baia situata a Sud-Est della penisola di Cavalli; è di forma irregolare, lunga circa un miglio e larga quasi sette gomene [ca 1274 metri], all’imbocco tra i pericoli di Punta Cavalli e quelli di Punta Diego. Nella parte interna è presente un’isola e la larghezza del passaggio è ridotta a metà gomena [ca. 91 metri]. A Sud dell’isolotto l’ancoraggio è ottimo per le piccole imbarcazioni; le grandi navi possono ancorare all’interno dell’ingresso; sono in parte protette dai venti del Nord dall’isola vicina.
Più conosciuto di Porto-Pollo, Longon Sardo [Santa Teresa] ha la stessa forma:
L’ingresso di Porto Longo Sardo è a tre quarti di miglio dall’isolotto Monica; la sua larghezza, che è di un terzo di miglio all’ingresso, si riduce a una strettoia a metà strada. Il porto è frequentato da piccole navi che vi trovano ottimo riparo dove sono poco disturbate dai venti settentrionali. [18].
Le nostre marinerie occidentali adottarono questo ancoraggio di Porto-Longone o Longon-Sardo (ne abbiamo ripercorso la storia): sulla soglia occidentale dello stretto, fu per loro la prima ad offrirsi; Santa Teresa deve la sua fondazione e la sua importanza all’andirivieni delle flottiglie occidentali, contro le quali gli isolani dovevano difendere questo scalo. Nell’antichità, quando Santa Teresa ancora non esisteva, era la vicina baia di Santa Reparata a fungere da scalo per gli stranieri: i romani avevano lì la loro città di Tibula.
Questa baia di Santa Reparata si apre all’uscita occidentale dello stretto, tra una penisola staccata, Capo della Testa, e la grande isola:
Il capo sardo della Testa costituisce, con il capo corso di Fens, l’ingresso occidentale delle Bocche di Bonifacio: i due capi distano nove miglia. Capo della Testa è l’estremità di una penisola quasi circolare, collegata alla terraferma da una lingua di sabbia, e alta circa 50 metri: il fronte occidentale della penisola è formato da scogliere granitiche prive di vegetazione. La baia di Santa Reparata, che delimita a Sud la striscia di sabbia che collega il promontorio alla costa, è quasi circolare ed è profonda quattro gomene [ca. 728 metri]. Le piccole navi vi possono trovare riparo contro tutti i venti; sono esposti solo al moto ondoso che viene da Nord-Ovest quando il vento viene da quella parte. [19].
Prendete la Carta delle Bocche e vedete come, simmetrica a questa baia di Santa Reparata, c’è, dall’altra parte del Capo de l’Erèbe (punta Falcone), sulla soglia orientale dello stretto, un porto ancora più sicuro che, per i naviganti provenienti da Est, può avere un’utilità ancora maggiore: è, come dicono gli indigeni, il Porto del Pozzo, Porto Pozzo. La forma di questa porta, cinta da un alto coronamento, merita davvero questo nome.
Un miglio a Sud-Est di punta Marmorata, si trova vicino alla riva una collina conica chiamata Monte Rosso con la punta omonima, e un miglio e mezzo a Sud di punta Monte Rosso, la penisola delle Vacche [sporge nel mare] ed è collegata alla terra solo da una piccola lingua di sabbia.
Tra la punta Monte Rosso e la punta delle Vacche si apre un braccio di mare lungo e stretto, chiamato Porto-Pozzo, porto del Pozzo. L’ingresso non è largo due gomene [ca. 364 metri]. Ma il braccio si allarga un po’ all’interno e, alla distanza di 1 miglio e un quarto, ha tra i suoi due lati un terzo di miglio. È profondo [lungo] quasi due miglia. Sul fondo si trova un bacino di 14 metri d’acqua, ma che non è accessibile alle navi, a causa dei bassi fondali che lo separano dal braccio di mare. Anche se lì l’ingresso di Porto Pozzo è aperto a Nord non c’è mai molto mare dentro… All’ingresso del braccio di mare, la Roccia o Scoglio di Colombo si trova a una gomena e mezzo [ca. 277 metri] dal punto di terra più vicino [20].
Questa pagina delle Istruzioni di Regata è solo la descrizione in prosa dell’ancoraggio raffigurato nel poema dell’Odissea. Ecco i due punti proiettati nel mare e che formano una foce:
Ed ecco lo stretto ingresso, tra le due alte e ripide vedette, su una delle quali salirà Ulisse per ispezionare il paese.
In questo stretto frequentato da navi, anticamente infestato da crociere turche e moresche, gli indigeni conservano ancora oggi, sui loro promontori e sui loro isolotti, numerosi vecchie torri di guardia o vedette, Guardia Vecchia, Guardia del Turco, Guardia Moro, Guardia Maiori, a cui si aggiungono, contro lo spionaggio e il contrabbando, le nuove guardie della dogana e del semaforo, Guardia Preposti… Ed ecco il coronamento in pietra che, a destra e a sinistra, delimita il Pozzo di una cintura continua.
Questa pietra ripida è il granito privo di vegetazione, di cui prima ci parlavano le Istruzioni. Su entrambi i lati del porto, a destra e a sinistra, questo muro di granito si estende dall’ingresso fino al fondo, dove si interrompe improvvisamente. Il fondo del Pozzo è una palude, una laguna con una spiaggia sabbiosa, di fronte ad una pianura dove termina la comoda strada che scende dai monti.
A destra del Pozzo, la parete è alta 80 metri: è Punta Raja, la punta della Baia (vedremo che i Lestrigoni vivono di pesca). Sulla sinistra c’è Punta Macchia Mala, la Punta del Maquis de Malheur, alta circa 100 metri. Le due pareti, partendo dagli stretti, descrivono una curva simmetrica contrapposta, le cui rientranze e gradini sembrano combaciare esattamente tra loro. Il nome stesso di Porto Pozzo potrebbe servire come traduzione di tali nomi odisseici, porto profondo, porto dalle profondità lontane [in senso di lunghezza in superficie].
Lungo questa costa sarda possiamo trovare alcuni golfi simili; ma nessuno è così stretto e chiuso come questo. Aperta verso Nord-Est, da dove soffia quasi ininterrottamente la terribile Bora; situato sul bordo di uno stretto dove i venti e le correnti lottano e si oppongono; dominati da montagne da cui cadono improvvise raffiche improvvise e violente, questi golfi della Sardegna settentrionale, dice Pausania, che esagera un po’, non offrono alcun ancoraggio alle navi che costeggiano questa costa, παρέχεται κατὰ τοῦτο ἡ νῆσος πνεύματά τε ἄτακτα καὶ ἰσχυρὰ αἱ ἄκραι τῶν ὀρῶν πέμπουσιν ἐς τὴν θάλασσαν. [21].
Antichi viaggiatori e geografi diedero a questi luoghi una cattiva fama che i poeti hanno ulteriormente esagerato:
«Guardando a Nord, questa costa è fiera, irta di rocce, brusca, rimbombante di improvvise onde del mare; i marinai hanno marchiato queste montagne col nome di Fous, quæ respicit Arcton, enmitis, scopulosa, procax, vitesque sonora flatibus; Insanos infamat navita Montes». [22].
Non sempre le navi che sfuggono a queste raffiche e si precipitano nelle insenature di questa costa frastagliata vi trovano un rifugio riparato dalle onde. Abbiamo veduto che nella baia di Santa Reparata «le piccole imbarcazioni hanno riparo da tutti i venti, ma che sono esposte al moto ondoso di Nord Ovest, quando il vento viene da quella parte» [23]. Solo che, in verità, il nostro Porto Pozzo benché l’ingresso sia aperto al Nord, non ha mai molto mare al suo interno: la ristrettezza della sua foce e la Roccia delle Colombe lo difendono dalle piene. Solo in questo porto le navi di Ulisse potevano attraccare l’una vicina all’altra, in grappolo o in fila, senza rischio di collisione, rottura o danneggiamento reciproco: su 4 o 5 chilometri di lunghezza, solo il Pozzo può contenere un’intera flottiglia; «nessuna mareggiata grande o piccola; ovunque calmo come l’olio».
Questo, credo, è il porto di Laistrygonia, o meglio questa è Laistrygonia. Perché gli indigeni, che dall’alto delle rupi si affacciano a questo buco, gli danno il nome di Pozzo; ma i primi navigatori, credo, la chiamarono lo Scoglio Colombo, la Pietra Colombaia, Λάις, Λεύς o Λάάς Τρυγόνων o Τρυγονίη, Laistrugonon o Lais-trugoniè, a causa dello Scoglio della Colombaia che riconoscevano all’ingresso di questo porto, come la Roccia dell’Orso li aiutava a riconoscere, nella baia di Palau, la sorgente Artakiè.
Nell’antichità come in epoca moderna, i nomi degli uccelli hanno occupato un posto importante nell’onomastica delle coste sarde. La Sardegna è, tra tutte le isole, terra di uccelli. Uccelli terrestri, che emigrano ogni autunno dall’Europa all’Africa e ritornano ogni primavera dall’Africa all’Europa; uccelli marini, che vivono della pesca su queste coste ricche di pesci: uccelli di ogni tipo popolano gli stagni marini e le lagune; le loro innumerevoli colonie ricoprono le coste e gli isolotti costieri. Basta aprire un racconto di viaggio:
La Sardegna è dotata di numerosi stagni che comunicano con il mare, uscendo attraverso tagli artificiali, sia attraverso un ruscello che a qualsiasi canale. In genere sono molto pescosi. Nelle loro acque, dall’inizio dell’autunno, si radunano per svernare innumerevoli schiere di uccelli acquatici, tra i quali si possono osservare migliaia di anatre, cigni, gallinelle d’acqua, fenicotteri, garzette e talvolta anche pellicani [24].
L’isola di Mal di Ventre è ricoperta di lentischi e cisti. È completamente disabitata e solo occasionalmente funge da rifugio per i pescatori. D’altronde è popolata da conigli e viene utilizzata durante la stagione della deposizione da gabbiani, gabbiani, cormorani e procellarie, che vi depongono le uova in quantità così grande che li ho visti caricare, per così dire, le barche. Non dimenticherò mai una notte che trascorsi su quest’isolotto e che mi sembrò lunghissima: mi era impossibile chiudere gli occhi per il rumore terribile, un vero sabba, che continuava a far sentire intorno a me un centinaio di questi urlanti uccelli. [25].
Nell’onomastica corrente questi uccelli hanno dato il nome a Punta Falcone, vicinissima a Porto-Pozzo, a Capo Falcone sulla costa occidentale, al nostro Scoglio Colombo e, di fronte, a Secca Colombo.
Colombe e piccioni riempiono le grotte e gli anfratti delle scogliere, invadono le rovine e gli edifici abbandonati:
«una grotta vicina è così popolata di piccioni che, più di una volta, sono comparsi rapidamente dalla colombaia sulla nostra tavola…. La chiesa ora solo officia due volte l’anno; per il resto [del tempo], è abitato da una moltitudine di uccelli, come piccioni, corvicelli, rondini e altri uccelli…. Curiosa da visitare è la vasta grotta delle Colombe, una specie di colombaia naturale. Ma la sua posizione sulla punta del capo Sant’Élia non ne facilita l’accesso; benché fossimo sulla barca di un console con marinai esperti, il vento, nonostante i lunghi sforzi, non ci permise di entrare. La caccia all’astore è molto divertente: si effettua in barca e sotto le luci, gli uccelli abbagliati e sgomenti cadono in mezzo alla folla o rimangono impigliati nelle reti tese all’ingresso» [26].
Lo stretto soprattutto è, grazie alle sue coste rocciose e alle sue innumerevoli grotte, luogo di ritrovo delle colombe: nei pressi del nostro Scoglio Colombo, Λάας Τρυγονίη, i romani conoscevano il Capo delle Colombe, Columbarium promontorium.
Le colombe portano con sé i loro soliti nemici, sparvieri, falchi e altri rapaci. I falchi della Sardegna hanno goduto di grande fama. anche all’esterno: i re d’Aragona e di Spagna portavano falchi sardi per il ritorno dei loro falconieri [27]. Se abbiamo qui i nostri Mantelli da Falco, gli Antichi avevano la loro Isola dei Falchi o degli Sparvieri, Ίεράκων νήσος, Accipitrum Insula, e sappiamo che questi nomi greci e romani erano solo la traduzione di un originale semitico, E-nosim, come trascritto da Plinio. Questo E-nosim fiancheggia la costa meridionale della Sardegna.
Forma un porto profondo con l’Isola Grande e un’altra isola costiera che sottili ormeggi di sabbia collegano alla costa sarda. Tra questi stagni si estende una di queste lagune marine che i viaggiatori ci hanno mostrato, più in alto, ricoperta di uccelli acquatici, cigni, fenicotteri e pellicani. Per gli antichi questa seconda isola si chiamava Sulci, Solci, Σόλκοι, Σούλχοι, Σύλκοι: troviamo lo stesso toponimo in un ancoraggio sulla costa originaria, di fronte alle paludi e alla laguna di Tortolì. Gli Antichi erano concordi nell’attribuire a questo nome un’origine semitica: Σόλκοι πόλις έν Σαρδοΐ, Καρχηδονίων κτίσμα [28]. Nell’elenco degli uccelli impuri donatoci dal Levitico, accanto allo sparviero o falco, nis, nosim, compare un altro uccello marino, s.l.k, che la Settanta e la Vulgata rendono come strolaga o pellicano. L’assimilazione non è certa. Ma il solo nome ebraico – per non parlare del contesto in cui compaiono solo uccelli marini e rapaci – indica sufficientemente che si tratta di un uccello tuffatore [29]. Credo che i navigatori semiti avessero in Sardegna, accanto alla loro Isola degli Sparvieri, E-nosim, un’isola e porti dei Pellicani o degli Svassi, E-solkim: Sulci o Solci, trascrivono esattamente i Romani; Σόλκοι o Σούλχοι, dicono ancora più precisamente i greci, perché conosciamo l’alternanza di κ e χ per formare il semitico כ. Ma i geografi antichi non hanno conservato per questo cognome il doppietto, il che ne renderebbe certa l’etimologia. L’Odissea non ha conservato nemmeno per noi, per definire la Pietra Colombaia, l’originale semitico di cui Lais Trugonié era la traduzione.
Dietro la Pietra della Colomba, l’ancoraggio del Pozzo sarebbe stato perfetto se non si fosse avuto nulla da temere dagli indigeni. Sfortunatamente, questi isolani; – impareremo a conoscerli, – erano feroci montanari, cugini di primo grado o addirittura, forse, fratelli dei Ciclopi, più giganti che uomini.
I viaggiatori franchi ci hanno ampiamente raccontato a quali terribili pericoli ci si espone in un porto troppo ben chiuso, dominato da rocce strapiombanti e da alpinisti crudeli: ai piedi del Taigeto, nel Porto delle Cailles, de Saunier ha quasi vissuto l’avventura di Ulisse in questo Pozzo dei Lestrigoni.
Ma in tutto il Mediterraneo non so se si trovi una trappola per topi così pericolosa come questa. Il nostro Pozzo è lungo quattro o cinque chilometri. Una volta entrate, le barche possono uscire solo remando: non un soffio di vento arriva ad aiutarle; le uniche brezze da Nord-Est, che entrano per lo stretto canale, sono contrarie all’uscita. Attaccate dagli indigeni, assediate, travolte di sassi, le navi straniere verrebbero schiacciate prima di poter raggiungere il mare aperto: non una barca, non un uomo sfuggirebbe; tutto sarebbe schiacciato in questo porto così profondo [lungo].
I miei due uomini e l’araldo incontrarono la forte figlia di Antifate alla fonte di Artakiè. La fermarono e le chiesero chi fosse il re e chi li comandasse. Lei subito mostrò loro l’alta dimora del padre. Entrarono nelle nobili dimore. Trovarono una donna alta come una montagna e rimasero estasiati. Ma lei chiamò dall’agorà. L’illustre Antifate, suo marito, preparò per loro una morte crudele. Ne prese uno e ne fece il suo pasto. Gli altri due fuggirono verso le navi. Antifate gridò per la città. Migliaia di Lestrigoni forti si precipitarono da tutte le parti, con un aspetto più simile a quello degli uomini che a quello dei giganti. Dall’alto delle scogliere ci colpirono con enormi pietre. Poi si scatenò un tumulto rovinoso sulla flotta, con marinai uccisi e navi distrutte. Poi, arpionando i miei uomini come pesci, i Lestrigoni li portarono via per un disgustoso banchetto.
I primi navigatori dovevano quindi stare in guardia: i loro viaggi dovevano raccomandare prudenza; prima di impegnarsi troppo o addirittura di entrare in questa trappola per topi, consigliavano senza dubbio di esplorare il paese dalle vedette circostanti.
Dico trappola per topi perché questo paragone è il più familiare alla nostra lingua di uomini di terra. A volte prendiamo in prestito il paragone della trappola anche dalla pesca fluviale. Per esprimere la stessa idea, i marinai preferirebbero pensare a qualche metafora derivata dalla pesca marittima. Sulle coste della Sardegna, però, esiste una famosa attività di pesca che da sempre ha portato fortuna agli autoctoni e l’ammirazione degli stranieri: la pesca del tonno. Per questa pesca, le coste sarde sono oggi bordate da gigantesche nasse chiamate tonnare, tonnare o nasse.
Sembra che il nostro poeta odisseo avesse in mente questo paragone dei tonni – a meno che il suo viaggio non glielo abbia portato davanti agli occhi – quando ci descrive il massacro degli Achei in questa baia dei Lestrigoni. Lapidati, storditi, arpionati dai selvaggi, i nostri. gli Achei sfortunati vengono portati via come pesci.
Si tratta di pesci di grandi dimensioni: nel Mediterraneo solo i tonni vengono arpionati e portati via in questo modo. Quando Eschilo vorrà descrivere la flotta persiana schiacciata e i soldati persiani tramortiti, sventrati e trafitti nello stretto di Salamina, in un mare coperto di detriti e cadaveri, non troverà altro paragone che quello dei tonni nella tonnara:
Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως
κύκλῳ πέριξ ἔθεινον, ὑπτιοῦτο δὲ
σκάφη νεῶν, θάλασσα δ´ οὐκέτ´ ἦν ἰδεῖν,
ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν….
τοὶ δ´ ὥστε θύννους ἤ τιν´ ἰχθύων βόλον
ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ´ ἐρειπίων
ἔπαιον, ἐρράχιζον· οἰμωγὴ δ´ ὁμοῦ
κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα [30].
Non c’è viaggiatore in Sardegna che non abbia dedicato molte pagine e incisioni a questa commovente pesca del tonno. La Spagna ha le sue corride; la Sardegna ha le sue madraghe: lo spettacolo da entrambe le parti è altrettanto crudelmente barbaro e sanguinario. Se mettiamo la nostra descrizione dell’Odissea a confronto con le relazioni moderne o contemporanee, credo che il massacro dei tonni e quello degli Achei avranno molti punti di somiglianza:
Per incoraggiare questa pesca, il paese mantiene durante tutta la stagione due saggi, che stanno su due alti promontori in riva al mare, per osservare quando i tonni si avvicinano alla costa, perché a volte appaiono in così gran numero che “li vediamo” lì in stormi da due a tremila alla volta.
– Gli antichi parlano di queste camere della morte per tonni, che costeggiano le coste del Mare d’Occidente. Ulisse stava tutto il tempo su una di queste alte vedette:
Quando il tempo è bello, questi guardiani, avvistando da lontano i pesci sulla superficie dell’acqua, avvertono i pescatori e gli abitanti sventolando una piccola bandiera bianca. Non appena si vede questo segnale, tutti i bambini, correndo per le strade con grida di gioia, annunciano alla gente la cattura. Poi, tutti gli abitanti, i borghesi, i commercianti, gli artigiani e persino le truppe abbandonano le loro occupazioni, corrono alla marina e i comandanti accolgono sulle loro navi il maggior numero di persone possibile per aiutarli in questa grande pesca [31].
– Il re dei Lestrigoni cominciò a gridare in città e decine di migliaia di Lestrigoni accorsero da ogni parte alla sua voce.
La madraga o tonnara viene preparata in anticipo: è un recinto di rete piegato in più corridoi e diviso in diverse camere. Le barche circondano la banda di tonni e la spingono verso il fronte, poi verso l’ingresso della trappola. Vengono fatti entrare a remi, gridando e lanciando pietre:
Le nostre mandragole hanno sette scomparti. I tonni entrano prima nella gran camera, la cui porta o foratico è sempre aperta. Da lì i tonni entrano nelle altre camere, che trovano ugualmente aperte e che vengono chiuse quando ce ne sono abbastanza. Quando il raïs ritiene di averne a sufficienza per la sua operazione, apre la penultima camera, detta di ponente o del tramonto, nella quale trasferisce il numero di tonni destinati alla camera della morte, che è l’unica camera in cui la pesca deve essere effettuata con il nome sardo di mattanza, la mattanza. Il giorno successivo, se il tempo è favorevole e il mare calmo, il raïs si reca alla mandragola prima dell’alba e lì, per indurre i pesci a entrare nella camera della morte, getta tra loro una pietra avvolta in una pelle di pecora che, spaventandoli come una testa di Medusa, li costringe a entrare nella loro tomba…. Le barche piene di uomini per manovrarle e altre barche che trasportavano mercanti per comprare e curiosi per godersi lo spettacolo di una pesca così famosa, navigavano rapidamente, gridando di gioia e accelerando la corsa. Quando raggiungono la mandragola, tutti prendono posto intorno alla camera della morte…
Preparato il tutto, il raïs dà il segnale con la parola d’ordine Sarpa di cominciare a tirare fuori la camera della morte dal fondo del mare. La camera della morte sale lentamente e, man mano che risale, si restringe finché tutti i pesci sono quasi a pelo d’acqua. È allora che gli uomini, imbarcati sulle due grandi imbarcazioni ed armati di bastoni che terminano con un gancio di ferro, cominciano con l’ordine Ammazza! (Uccisione) dato dal raïs, per uccidere i tonni arpionandoli, poi li trascina con la massima avidità nelle loro barche. L’agitazione del mare, eccitato dalla violenza dei tonni che si trovano rinchiusi e schiacciati in uno spazio ristretto, attaccati da ogni parte e feriti a morte; le battaglie che i lavoratori sono costretti a condurre contro questi grandi pesci per vincere la loro resistenza; la superficie del mare sollevata in schiuma tinta di sangue che i tonni riversano dalle loro ferite: tutto ciò suscita l’ammirazione, le acclamazioni e le grida di gioia degli spettatori. Una volta terminata la pesca rimorchiamo le due grandi barche piene, che accompagniamo con canti e grida di gioia, alla mattanza di terra, cioè alla macellazione a terra, che viene effettuata in riva al mare in grandi sale coperte… Al tonno viene tagliata la testa, poi ogni pesce, per quanto enorme sia il suo peso, viene caricato sulle spalle di un unico facchino, detto bastagio, che lo trasporta al tancato, un grande magazzino dove il tonno viene appeso in file per la coda [32].
– Dall’alto delle rocce, i Lestrigoni iniziano a lanciare enormi quarti di roccia. Tra le navi si scatena un disastroso tumulto di uomini perduti e di barche spezzate; poi, trafiggendo i miei uomini come pesci, i Lestrigoni li portano via per un disgustoso banchetto.
Nel recinto, una vera e propria macelleria, c’è un altro spettacolo molto curioso, anche se un po’ disgustoso. Mi fermo qui, perché avrei paura di condividere con il mio lettore il disgusto che ho provato ogni volta che ho assistito alle operazioni della mattanza di terra, sempre più nauseanti man mano che la pesca si avvicina. A causa del caldo di questo Paese nei mesi di giugno e luglio e del sangue dei tonni che impregna il terreno, nonché di tutte le parti inutili del pesce che vengono buttate via, l’aria finisce per essere infetta e l’odore diventa insopportabile [33].
Il tonno si pesca o si pescava in tutte le coste della Sardegna: la pesca è molto abbondante e, nella stagione che va da aprile a luglio, le coste dell’isola sono frequentate dai tonni. Le navi che transitano lungo la costa durante la stagione di pesca di questo pesce devono fare attenzione a evitare le trappole: questi dispositivi potrebbero causare gravi danni e mettere in pericolo l’imbarcazione stessa [34].
C’è una stagione dell’anno in cui, fino a poco tempo fa, l’intera isola viveva esclusivamente della pesca del tonno:
Ogni anno, all’inizio di aprile, tutte le coste della Sardegna dove si sono stabilite le mandragole diventano luoghi di rumore, di affari e di arti, oltre che mercato di trattative. Da ogni parte arrivano navi con ingenti somme di denaro per rifornirsi di tonno sotto sale. I Sardi, curiosi di godere dell’inesprimibile piacere della pesca, vi giungono a frotte dall’interno del regno e sono accolti con generosità dai proprietari della pescheria, i quali regalano a tutti i forestieri non solo la tavola splendidamente imbandita, ma inoltre fanno dono a tutti, al momento della partenza, di un tonno proporzionato alla qualità della persona, anche se si tratta solo di un contadino o di un servo [35].
Ma le coste orientali della Sardegna, sul mare italiano, sono molto meno pescose di quelle occidentali sul mare spagnolo. In realtà madraghe e mattanze operano solo su questa costa occidentale, e le maggiori sono in due zone in particolare: a Sud l’Isola Piana, nei pressi dell’antica Isola degli Sparvieri, a Est nosim; a Nord il Golfo di Porto-Torres, che si estende dalle Isole dell’Asinara fino all’ingresso delle Bocche, fino alle vicinanze del nostro Pozzo.
Il viaggio semitico, che descriveva questa costa, deve aver descritto anche questa pesca. È probabile che le madraghe non fossero ancora state inventate. Queste erano le baie e i golfi senza uscita che allora fungevano da camere della morte. Le canoe degli indigeni cercavano di spingere lì i gruppi di tonni, che allora dovevano essere innumerevoli. Sembra che il nome stesso del tonno, θύννος, sia solo la trascrizione greca del semitico than o thun. La Scrittura usa quest’ultima parola nella forma tnannin per designare i mostri del mare. I tonni sardi sono talvolta dei veri e propri mostri, grandi come cetacei: «In Sardegna, quando il tonno pesa meno di cinquanta chili, viene chiamato solo scampirro, derivato da scomber, il nome generico della famiglia; da cento a trecento libbre è ancora soltanto mezzo tonno, mezzo tonno; quelli da mille libbre non sono rari». Il padre Cetti sostiene che a volte ne venivano prese milleottocento libbre (diciotto quintali).
Le Istruzioni Nautiche consigliano ai nostri marinai di vigilare sulle trappole, per paura che si danneggino: il viaggio dell’Odissea, per altri motivi, consigliava anche di evitare queste camere di morte. Conosciamo la prudenza di questi primi navigatori e la cura con cui non si allontanavano troppo dal mare aperto. Specialmente tra i popoli selvaggi non piace entrare nei porti profondi. Ulisse non segue il grosso della sua flotta fino al fondo del Pozzo; ormeggia la sua barca vicino all’ingresso, a una pietra.
L’estremità meridionale della Corsica, che sta sull’altra sponda dello stretto, di fronte al nostro Pozzo delle Sardi, è chiamata la Pietra Penetrante, Pertusato: «La scogliera è scavata nella sua parte inferiore; l’apertura che l’attraversa da un lato all’insieme è dotata di un arco a ponte» [36]. È proprio a Sud di questa Pietra Traforata che si apre un porto sardo, molto vicino al nostro Pozzo. Lo abbiamo descritto sotto il nome di Porto-Longone o Longo-Sardo. Il nome che porta oggi può sembrare legato alla sua forma lunga e stretta: questo nome deriva in realtà da un’altra causa e risale all’antichità, perché l’Itinerario Antonino fa menzione di questo ancoraggio a Longones. Longon, λογγών, era un toponimo molto comune in questo mare occidentale, sulle coste insulari della Sicilia, della Sardegna e dell’isola d’Elba. Era più un nome comune che un nome proprio. Longon designava, infatti, gli ancoraggi provvisti di pietre forate per l’ancoraggio delle navi. Siracusa e Catania avevano i loro longon o longones, λογγώνες, e gli scolastici ci spiegano che questi longones sono sia porti che pietre forate per ricevere gli ormeggi [37]. Il Longon di Sardegna doveva probabilmente il suo nome ad una pietra con un foro. Nei pressi del Pozzo, il viaggio dell’Odissea descrive senza dubbio questo rifugio della Roccia forata (da qui il dettaglio immaginato dal nostro poeta): era, dietro il Capo d’Erebe, il primo che si offriva ai navigatori impegnati nel cammino della notte.
Fonte dell’Orso, Pietra della Colomba, Porto Profondo, Guette, Camera del Massacro, Roccia scavata: sembra che questa costa sarda nelle Bocche ci regali tutti i luoghi e, allo stesso tempo, tutti gli episodi dell’avventura odissea.
È a questo Pozzo che Ulisse venne a sbarcare: con la mappa davanti agli occhi, possiamo seguirlo passo dopo passo.
Spinto forse dagli stessi venti meridionali, che già lo avevano riportato nell’isola di Aioliè e che tanto facevano infuriare Aiolo, Ulisse navigò sei giorni e sei notti prima di raggiungere Laistrygonia: vi arrivò il settimo giorno. Sappiamo quale posto occupa la settimana nelle misurazioni e nei viaggi semitici. È possibile che la settimana qui sia solo un modo di dire: oggi diciamo una settimana o giù di lì, senza associare a questo numero l’idea di otto giorni interi. Tra l’isola di Aioliè, che è l’uscita dallo stretto di Sicilia, e Lestrigonia, che è l’ingresso dello stretto di Sardegna, i viaggi fenici dovevano durare circa una settimana. In linea retta, in alto mare, al massimo seicento chilometri separano questi due punti. Ma i primi navigatori non seguirono questa strada rettilinea. Percorrevano le coste italiane, che risalivano verso Nord fino all’isola di Kirkè e, di lì, tagliando verso Ovest, arrivavano alle Bocche, oppure, da Stromboli a Didymè e a Ustica, seguivano prima il ponte delle Isole Eolie per raggiungere la punta meridionale della Sardegna, da dove seguivano poi la costa orientale.
In questo viaggio non sono più seicento i chilometri, ma otto o novecento almeno, che vanno contati tra Stromboli e le Bocche di Bonifacio. Con un buon vento continuo, le barche omeriche non avrebbero impiegato che una settimana per coprire questa distanza. Ma, da queste parti, i venti del Nord regnano incontrastati e, per giungere dai mari siciliani alle Bocche, bisogna lottare contro di essi e spesso ricorrere alla dura fatica del remo. Con questi venti contrari o sfavorevoli, una settimana passa velocemente: il più delle volte, sei giorni e sei notti bastano a malapena per percorrere questi novecento chilometri.
La flotta di Ulisse entra nel Pozzo. Una sola nave resta sotto le rocce dello stretto, sotto la ripida vedetta. Il porto e le aree circostanti sono deserte. I nativi non vivono sulla spiaggia. Secondo gli usi dell’epoca, la loro città alta è all’interno. La pirateria regnava allora sulle Bocche, come vi regnerà fino ai nostri giorni. Ci vorrà la pace romana per consentire l’insediamento delle città marittime di Tibula e di Torre Libyson su queste coste; la pace inglese ha oggi fatto rivivere questi ancoraggi sotto i nomi di Santa Teresa e Porto Torres. Ma, nell’intervallo di queste due paci, tredici o quattordici secoli di pirateria gotica, vandalica, araba, pisana, genovese, catalana, barbaresca e franca spinsero le abitazioni verso l’alta campagna. Appena un secolo fa, ogni primavera arrivavano ancora i corsari da Tunisi e Algeri. Il Nord Sardegna ha ancora oggi le sue grandi città, Tempio, Nulvi, Osilo, Sassari, ecc., lontane dalla costa, in cima a colline o montagne.
La città di Sulci sorgeva da tempo sul Mare del Sud, ai margini della pescosa laguna che separa la penisola di Sant’Antioco dalla terraferma. Sulci era famosa per le sue saline, la sua pesca e le sue reliquie di Sant’Antiochia. I pirati erano i più forti. Agli inizi del XVII secolo gli abitanti del Sulci dovettero abbandonare il loro territorio. Salirono con le loro reliquie a Iglesias. Ma si preoccuparono di stilare un contratto e di specificare che, ogni anno, il corpo del santo sarebbe andato in processione a rivisitare il suo antico dominio e che un giorno sarebbe sceso a stabilirsi di nuovo lì, quando i pirati scomparsi avrebbero permesso a Sulci di rinascere. Dopo la conquista francese dell’Algeria e la talassocrazia inglese, dopo aver represso nel corso del XIX secolo i pirati, Sulci risorse nuovamente sotto il nome di San-Antioco. Gli abitanti della nuova città reclamarono allora il loro santo. Ma i canonici di Iglesias si rifiutarono di cederle: queste reliquie, circondate dalla venerazione popolare, costituivano la loro migliore fonte di reddito. Ci volle un decreto reale per far rispettare il contratto e restituire il santuario [38].
Nel 1812 ancora, i tunisini devastarono il perimetro della Sardegna: le nostre isole delle Bocche di Bonifacio hanno ancora le loro guardie turche. Durante questi secoli di pirateria, sulle coste c’erano solo alcuni castelli, dove i conquistatori installarono una guarnigione e che gli indigeni assediarono, come questo Castello sardo, alla porta occidentale delle Bocche, che ha solo un nome sardo: Castel Sardo, su uno scoglio alla foce del Frisono, fondato dai Doria intorno al 1102, fu successivamente Castel Genovese, aragonese, fino a ricevere, nel 1769, il nome nazionale di Sardo. Questo luogo, forte solo della sua posizione sul mare, che, ad eccezione di uno stretto istmo, lo circonda da tutti i lati, non è per niente riparato [39].
Durante questi secoli di pirateria, sulle coste c’erano solo alcuni castelli, dove i talassocratici avevano posto una guarnigione e che gli indigeni assediavano, come quello dei sardi alle porte occidentali delle Bocche, che è sardo solo di nome: Castel Sardo, su uno scoglio alla foce del Frisono, fondato dai Doria intorno al 1102, fu successivamente Castel Genovese e Aragonese, fino a che non gli fu dato il nome nazionale di Sardo nel 1769. Questo luogo, forte solo della sua posizione sul bordo del mare che, ad eccezione di uno stretto istmo, lo circonda da ogni lato, non è stato riparato.
Al tempo dei pirati fenici la città di Lestrigoni non si trovava sulla costa. Ma una strada conduce lì dal mare. Approdati in fondo al porto, i due uomini e l’araldo di Ulisse trovano subito questa carrareccia, che dalla cima dei monti porta i carri dei taglialegna in città.
Oggi Sassari è la grande città dei Sardi sulla costa settentrionale della loro isola. Ad una ventina di chilometri dalla costa, in cima ad alte colline, Sassari è una Città Alta con ai piedi una scala, Porto-Torres. Le Istruzioni Nautiche descrivono le dimensioni e la città:
«Questo piccolo porto, di antica data, funge da porto commerciale per Sassari e il distretto con questo nome. La campagna intorno a Porto Torres è arida e offre alla vista solo erica e qualche palma sparsa. Una buona strada sterrata conduce a Sassari, a 20 chilometri, e da lì a Cagliari, a 270 chilometri; le comunicazioni tra queste città sono regolari e costanti. Una ferrovia di 20 chilometri collega Porto Torres a Sassari. Seconda città dell’Isola (36.300 abitanti), capoluogo di provincia, sede di un arcivescovado e di un’università, Sassari è alta 220 metri. È circondata da mura con torri, ha un antico castello, un palazzo governativo e altri stabilimenti pubblici. La famosa fontana in marmo Rosello si trova all’esterno, vicino alla Porta Macalla, a NE. della città» [40].
La Città Alta dei Lestrigoni, con il suo alto palazzo e le sue residenze nobiliari, con la sua fontana all’aperto dove le ragazze vengono ad attingere acqua, era in tutto simile a Sassari. Ma, seguendo questa legge di simmetria che ritroviamo sempre nei nostri studi topologici, non si trovava sulla stessa costa. Sassari, nella parte occidentale delle Bocche, è stata la grande città dei Sardi solo a partire dall’epoca aragonese:
«Il castello di Sassari fu costruito nel 1330 da Raimondo di Monte Pavone, primo governatore generale di Logudoro sotto gli Aragonesi; tra gli stemmi presenti sulla facciata di questo edificio, insieme allo stemma sbarrato dei re d’Aragona, ne notiamo uno dove è raffigurato un pavone» [41].
Fu per comodità degli Aragonesi, venuti dall’Occidente, che Sassari venne a trovarsi vicino al mare occidentale.
All’epoca delle nostre prime marinerie, i conquistatori arrivarono da Est: i Sardi avevano quindi la loro grande città sul lato Nord-orientale dell’isola, all’ingresso levantino delle Bocche, non lontano dal Pozzo che serviva loro da scala, e non lontano dalla Sorgente dell’Orso che fungeva loro da fontana.
La provincia sarda che confina con l’ingresso levantino delle Bocche si chiama Gallura. È una regione speciale, una provincia isolata, che difficilmente si integra con il resto della Sardegna: gli abitanti di questa provincia sono considerati i più intelligenti tra i sardi. Hanno vita più facile con certi studi, con la poesia e con le canzoni improvvisate. La loro lingua è più vicina all’italiano che al sardo; viene cioè dal dialetto corso, il che è del tutto naturale. Perché fino ad oggi la Gallura, priva di ponti e di strade, comunicava con più difficoltà con le altre province dell’isola che con la Corsica, da cui è separata soltanto da un piccolissimo stretto [42]. Lo stretto, infatti, grazie al ponte di isole, stabilisce un’intimità permanente tra la Corsica e la Gallura. Ma con il resto della Sardegna la Gallura fino ad anni recenti non aveva praticamente comunicazioni, a causa della barriera invalicabile dei Monti Limbara.
Questa barriera, che taglia la Sardegna settentrionale da Est a Ovest, dal Mar Italiano a quello di Spagna, dal Golfo di Terranova [Olbia] alle spiagge di Castel Sardo, è un muro granitico la cui altezza media supera i milleduecento metri. Verso Sud, verso il resto della Sardegna, questa muraglia precipita ripida nella valle paludosa di Terranova o nelle gole del fiume Coghinas, tanto che, da questo lato, essa costituisce un vero e proprio baluardo e come un fronte continuo di fortezza, delimitato da una fila di fossati: al lato di questo bastione, con grande fatica, gli italiani hanno oggi agganciato i tronchi della loro piccola ferrovia per raggiungere la Gallura nel loro porto di Terranova sul Mare Orientale.
Verso Settentrione, invece, verso le Bocche, i monti del Limbara scendono lungamente per cinquanta o sessanta chilometri di crinali, valli cave, catene secondarie, duomi isolati, massicci e pianure, insomma attraverso questa Arcadia di Gallura, di cui un fiume abbastanza importante, il fiume Liscia, porta le acque nelle vicinanze del nostro Pozzo. Come i suoi torrenti, anche la Gallura ha la sua naturale pendenza verso le Bocche. Fino ad anni recenti, fino all’istituzione della piccola ferrovia di Terranova [Olbia], era solo verso le Bocche che la Gallura indirizzava i suoi commerci e la sua rotta.
Quest’Arcadia ha ora la sua grande città proprio ai piedi dei Monti Limbara, a Tempio:
«Solo una trentina d’anni fa il villaggio di Tempio venne inserito tra le città della Sardegna. C’è da dire, però, che già per lungo tempo fu sede di un vescovo, di un intendente provinciale, di un comandante militare e di un tribunale e che, nonostante il nome di villaggio, fu sempre considerata per due secoli la capitale di tutta la maggiore regione della Gallura… Tutte le altre popolazioni di questa provincia, senza contare quelle degli isolotti vicini, sono sparse in stazzi o specie di ovili isolati, raggruppati sotto il nome di cussorgie». [43].
L’attuale capoluogo della Gallura è piuttosto distante dalla costa delle Bocche: più di quarantacinque chilometri. Tuttavia su questa costa ha i suoi due porti, Santa Teresa presso Porto Longone, e Palau o Parau ai piedi dell’Orso, di fronte alla Maddalena. Fino ad anni recenti, fino all’istituzione della piccola ferrovia di Terranova [Olbia], la Gallura rivolgeva il suo commercio e la sua rotta solo verso le Bocche. Grazie alla valle del Liscia, tutta naturale, alla quale l’uomo può solo adattarsi, è scesa verso questi porti:
«Partendo da Tempio per andare a Santa Teresa o all’isola della Maddalena, seguiamo prima un’unica strada fino a un luogo chiamato Luogo Santo, che è un cinque un’ora di passeggiata a cavallo lontano dalla città. Sono pochi stazzi raggruppati insieme, a formare un villaggio embrionale. Da Luogo Santo partono due sentieri, quello a sinistra che porta al borgo di Santa Teresa, e quello a destra che seguiamo per arrivare alla Maddalena. Entrambi attraversano un paese molto aspro e boscoso, il cui terreno è granitico. Durante questi due lunghi viaggi a cavallo di quattro ore, non vediamo nulla degno di nota» [44].
Il ramo di sinistra verso Santa Teresa raggiunge la costa delle Bocche proprio in fondo al nostro Pozzo: in realtà Tempio dovrebbe avere il suo approdo occidentale a Dispensa, [Porto Liscia] sulla spiaggia sabbiosa che termina a Porto-Pozzo. Il ramo destro verso la Maddalena raggiunge il mare di Palau: in questa insenatura di Palau si trova una sorgente dove si può ricavare acqua e che da tempo rifornisce l’arcipelago della Maddalena. Questa è la nostra Sorgente dell’Orso: il ramo di destra conduce quindi alla fontana Artakiè verso la quale scendeva la figlia del re dei Lestrigoni.
Al tempo dell’Odissea i due rami già esistevano. In fondo al Pozzo, l’araldo e i suoi due uomini trovarono il bivio di sinistra e lo risalirono. Al bivio incontrarono la forte figlia di Antiphatès, che scendeva alla fontana di Artakiè, dove i cittadini si riforniscono. La principessa mostrò loro la città. Andarono là… La città dei Lestrigoni era allora meno lontana dalla costa di quanto lo sia oggi Tempio. La città di Antiphatès doveva trovarsi vicino al bivio delle strade, in prossimità della sorgente. Il poeta odissea chiama questa città Telepylos. Commentatori e scoliasti hanno discusso molto sul valore e sul significato della parola. È un nome proprio? È solo un epiteto? Da parte mia, credo che Télépylos, come Nesos Lakheia o Nèsoi Thoai in questo stesso poema odissea, sia un nome proprio. […]
L’onomastica greca ci propone Pilo e le Termopili, che abbiamo imparato a conoscere bene: « Télé-pylos, dicono gli scolastici, è la città le cui porte sono lontane o molto larghe, oppure è la Porta abitata in qualche luogo lontano» [45]. Questo nome greco è oscuro: forse diventerebbe più comprensibile se trovassimo l’originale di cui non è che l’esatta traduzione. In questa regione nord-orientale della Sardegna, i geografi greco-romani conoscono una città di Erycion o Erycinon, Erucium. Non conosciamo la posizione esatta. Ma vediamo dal testo di Tolomeo che non era un porto: fu la prima delle città continentali, a partire dallo stretto [46].
I curatori del Corpus Inscriptionum Semiticarum hanno, credo giustamente, paragonato questo Eruc-ion o Eruc-inon sardo a tali nomi siciliani, Eryx, Eryc-é, Eric-inè, che sembrano avere la stessa origine [47]. Sulle coste occidentali della Sicilia, Eryx è una montagna dove il fenicio Astarte piantò il suo santuario e il suo nome Eruk’Aïm. Questo nome è un epiteto divino, che conosciamo dalle iscrizioni fenicie del luogo e che rientra in una categoria di titoli simili, Oz’-Aïm, per esempio. Il significato di questo epiteto divino è: Nostra Signora Durata della vita o Prolungamento della vita. Infatti la radice arak esprime le idee di lunghezza, estensione, distanza; le forme participio ed aggettivale erouk ed erek, sarebbero rese esattamente con longus o longinquus in latino, con makros o tèlos in greco. La Bibbia, come le iscrizioni di Eryx, ci dà diversi esempi di epiteti o sostantivi composti formati dall’aggettivo erouk o erek e da un complemento: mentre le iscrizioni fenicie dicono erek-‘aïm, vitæ longæ, nella Bibbia troviamo erek-naphes, long-animis, erek-iamim, long-ævus, erek-rouah, erek-aphim, ecc.
Credo che l’odisseo Télé-pylos ci dia il vero nome completo della sarda Eryc-ion: era la città dalle ampie porte, erouk’a-sa’arint. Questo nome completo fu abbreviato nell’uso comune e, soprattutto, di epoca in epoca. Quando i Fenici scomparvero e il vero significato fu dimenticato, il secondo termine fu abbandonato, come spesso accade nell’onomastica trasmessa. È addirittura possibile che, fin dall’inizio, questo secondo termine fosse il più delle volte omesso o sottinteso: la Bibbia ci parla di una città di Erek, e anche un’iscrizione fenicia della Sardegna invoca Astarte Erek [48]. In nessun altro modo Eruk’a Sa’arim è diventata Eruk’a tout court, da cui i greco-romani hanno tratto il loro Eruc-ion o Eryc-inon.
Le descrizioni dell’odierna Tempio spiegano chiaramente il significato di questo nome proprio:
«Le case di Tempio sono tutte costruite con lastre o meglio parallelogrammi allungati di granito, regolarmente spaccati con cunei di ferro. Questi pezzi venivano posti uno sopra l’altro e tenuti insieme a malapena da un mortaio di argilla e molto raramente dalla calce, perché questa sostanza era molto costosa, poiché doveva essere portata da molto lontano: unici luoghi della Gallura dove la natura ha posto pietra calcarea sono il promontorio di Figari e l’isola di Tavolara… Queste costruzioni sono molto solide. Le case di Tempio presentano all’esterno un aspetto molto particolare, ma un po’ massiccio [49].
«Questo ricco borgo di Tempio, come la maggior parte degli altri paesi della Gallura, è costruito interamente con pietre di granito durissime e lucentissime. Alcune di queste case alte, con un po’ di architettura, sarebbero palazzi degni di Venezia, di Roma o di Firenze» [50].
Tutta la Gallura è granitica, disseminata di enormi pietre che, nel corso dei tempi, gli uomini hanno accumulato per le loro costruzioni e monumenti. Pietre rialzate alte sei metri e che portano il nome di Perda-Lunga, Pietra Lunga; Tombe dei Giganti che portano il nome di Perda-Latta, Pietra Larga; Nuraghi che si distinguono dalle costruzioni ciclopiche, formati da poligoni irregolari, per i corsi regolari e orizzontali delle pietre che li compongono [51]: tutte le costruzioni della Sardegna primitiva offrono lo stesso aspetto di mura o di enormi blocchi. La porta dei nuraghi è solitamente molto bassa, tanto che a volte un uomo ha difficoltà ad entrarvi se non a pancia in giù; ma la difficoltà cessa quasi sempre quando si è superata la larghezza della pietra dell’architrave, che è più lunga e larga di tutte le altre [52].
Immagino la nostra città sarda dalle Porte Grandi come un’altra Micene con ingressi giganteschi, bassi, ma larghissimi. Questa cittadina sarda ha la sua agorà, molto simile alle piazze dei paesi odierni. In questi paesi del Nord della Sardegna, le strade ripide sono una sorta di precipizi costruiti; a Sassari e in tutto il Logudoro la via principale, o meglio la meno stretta di questi abissi, è chiamata erroneamente la Piazza… Sassari ha una sola lunga via chiamata un po’ erroneamente la Piazza, nome dato nel Logudoro alla via principale, al Corso: la Piazza de Sassari attraversa tutta la città orribilmente costruita [53]… In questa Piazza sono le principali boutique, i caffè e i negozi più ricchi ed eleganti [54].
Nella piazza di Telepilo, Antifate passeggiava con il mantello in spalla, quando sua moglie lo mandò a chiamare.
Il sito esatto di Erycion è ancora sconosciuto. La geografia antica della Sardegna settentrionale è molto incerta. L’Itinerario di Tolomeo e Antonino fornisce solo informazioni imprecise o contraddittorie. Storici e geografi moderni hanno esplorato la città di Erycion in tutta la Gallura, dal Golfo di Arzachena alle spiagge di Castel Sardo [55].
Attenendosi al testo dell’Odissea, sembra che Telepylos, pur essendo costruito nell’entroterra, non dovesse essere molto lontano dalla costa: gli uomini di Ulisse sembrano arrivarci rapidamente; inoltre la fonte dell’Orso deve poter fungere da fontana suburbana: «Ho ammirato la disinvoltura delle belle ragazze di Tempio, il loro corpo slanciato, quando, ben vestite e a piedi nudi, venivano ad attingere l’acqua alla fontana, portando con leggerezza e senza mai toccarlo il secchio sulla testa», racconta Valéry come per commentare i versi dell’Odissea: «incontrarono davanti alla città la forte figlia di Antifate che si recava a prendere l’acqua; scendeva verso la Fontana dell’Orso dal bel flusso, dove i cittadini vanno a prendere la loro acqua […]
Valery aggiunge:
«La vista più bella di Tempio è dalla cappella di San Lorenzo, una vista mista di colline, rocce, valli e mare… La salubrità, la leggerezza dell’aria di Tempio producevano la salute, la freschezza, la forza, bellezza, coraggio, intelligenza degli abitanti sono a tutti gli effetti i più rinomati dell’isola» [56].
Il viaggio odisseo dovrebbe vantare anche la grandezza, la forza e la bellezza dei grandi e valorosi montanari, delle loro mogli e figlie: ΐφθιμος, ίφθίμη, il forte, la forte, sono gli attributi che ricorrono nel poema per gli uni e per gli altri. […]
Gli uomini sono giganti. Le donne sono spaventosamente alte, alte come montagne […]
Questa dimensione degli uomini e delle donne di montagna del Nord colpisce ancora di più i navigatori in Sardegna in quanto le pianure meridionali dell’isola sono malsane, infette dalla malaria. Al Sud e all’Ovest il maltempo e la malaria imbastardiscono la razza e, minando gli individui, li rendono magri e malaticci. La Gallura, invece, è esente da paludi e febbri. Fatta eccezione per alcune spiagge in fondo ai porti sabbiosi, l’intera regione è straordinariamente sana. Paese di alte montagne e di grandi venti settentrionali, di foreste e radure, di pascoli e armenti, di sorgenti e di acque correnti, è una vera Arcadia, un angolo della Svizzera mediterranea, i cui pastori hanno custodito, la loro vita libera all’aria aperta e le loro usanze d’altri tempi giungono fino a noi. L’allegria di questa gente di montagna, il loro gusto per il canto e la poesia è sempre stato decantato dai viaggiatori:
«Questo gusto è innato tra i Sardi e soprattutto tra la gente di campagna, che allieta il tempo del lavoro e dei viaggi a cavallo con canti continui. Molto spesso le loro canzoni sono improvvisate. Si concentrano poi sugli avvenimenti recenti del paese o del cantone, e anche sul viaggiatore che i sardi accompagnano, se il cantante è una guida o un cavalcante. Le donne, in Gallura, si schierano contro gli uomini in una lotta galante in canti improvvisati, notevoli per la finezza delle allegorie…. Quando in Gallura la tosatura è appena terminata, la lana viene pelata grezza in comune. Le donne e le ragazze si siedono in cerchio e gli uomini si aggirano intorno. Durante il lavoro c’è solo il canto o una successione di versi cantati. Queste strofe sono talvolta improvvisate e si svolgono dialoghi in rima su un fiore offerto e spesso rifiutato, una dichiarazione ecc.» [57].
I pastori di Virgilio non cantano diversamente:
malo me Galatea petit, lasciva puella,
et fugit ad salices, et se cupit ante videri [58].
Il miglioramento sociale ed il progresso dei pastori galluresi non hanno alterato il loro carattere nato la loro fisionomia poetica. Continuano una canzone i loro versi improvvisati. A volte due di questi pastori, come quelli delle Bucoliche, cominciano a litigare con canti alternativi,
alternis igitur contendere versibus ambo
cœpere,
e si scambiano, prima del preludio, la stessa cortesia. Le composizioni di questi Corydons e Thyrsis sardi sono molto poco diffuse, perché non vi sono stenografi. Devo il testo di molte di queste improvvisazioni ad un canonico vicino a Tempio. Ecco il più notevole:
Dimmi tu Pietro d’Achena
Un’inchiesta ti vo’ far;
Se non ho di che campar,
E rinvenga che pigliar,
Prender posso senza pena?
Se t’affidi al mio parlare,
Un parer ti vo’ donar,
Qual tu sei senza mangiar,
Se ne trovi, il dei pigliar,
O per pazzo vuoi passare.
«Questa facilità poetica dei Sardi sembra antica, lo testimonia Tigellio (di Sardegna), improvvisatore di Cesare e Augusto, cantore alla moda, dipinto da Orazio» [59].
Il pastore sardo parla come il pastore delle Bucoliche:
Dic mihi, Damœta, cujum pecus?
e come lui è accompagnato dal flauto a due o tre ance, la launedda. Questo gioco di canti alternati è molto antico sulle rive del Mare Occidentale. Gli Elleni raccontano che i loro poeti avevano preso in prestito lo stile bucolico dai nativi della costa siciliana: fu a Tyndaris, sulla costa settentrionale della Sicilia [60], che nacque questo genere letterario.
I navigatori del viaggio odisseo mi sembra abbiano già incontrato questi poetici tornei sulle coste della Sardegna. Perché il pastore che chiama un pastore, il mandriano che cede il posto (o la parola) a un pastore di pecore, affinché entri (in scena) quando l’altro esce, hanno una somiglianza davvero notevole con i pastori bucolici.
Il verso dell’Odissea: il pastore che entra gridando al pastore che gli risponde uscendo, mi sembra che ci dia la migliore definizione di questo genere letterario. Virgilio direbbe: e cantare pares e rispondere parati.
Troveremmo un altro esatto equivalente in tali versi di Teocrito: «Il primo quindi, rivolgendosi a Dafni, Menalkas disse: O pastore di buoi muggiti!… ecc. Gli rispose Dafni: O pastore delle pecore dal folto vello!» [61]
Solitamente, nel bucolico, sono un pastore di buoi e un pastore di pecore a scontrarsi: L’amabile Dafni, il mandriano, incontrò Ménalkas che stava pascolando le pecore sugli alti monti [62].
Anche in questo caso, un verso di Odisseo sembra essere solo una sintesi di questi due versi di Teocrito:
τόν μέν βουκολέων, τόν δ’ άργυφα μήλα νομεύων.
Del resto il passaggio, da entrambe le parti, è lo stesso; le stesse alte montagne cadono nel mare, e le vedette dei tonni stanno su ciascun lato della baia [63].
E l’occasione per queste canzoni è la stessa oggi come in passato. Oggi è il momento della tosatura e della raccolta della lana; anticamente era durante il taglio e la raccolta del grano; la decima bucolica di Teocrito è intitolata Gli operai o i mietitori, Έργατίναι ή Θερισται: «questi canti sono adatti agli uomini che faticano sotto il sole» [64].
E il pastore che non si addormenta, l’uomo veramente sveglio (il testo dell’Odisseo a άυπνος, come dice il greco moderno έξυπνος: diciamo sveglio, intelligente), il pastore più intelligente vince un doppio premio, perché questi canti alternati sono gare e giostre, in cui ciascuno dei rivali deve porre una posta in gioco [65].
Anche i pastori di Virgilio chiedono il deposito della posta, il pegno:
UOMINI. – Vis ergo inter nos quid possit uterque vicissim
ego hanc vitulam (ne forte recuses ;
bis venit ad muletram ; binos alit ubere fetus)
depono : tu, dic mecum quo pignore certes.
DONNE. – De grege non ausim quicquam, deponere tectum.
Il vincitore alla fine tocca, solleva – il poeta odisseo dice έξήρατο – entrambe le poste: Thyrsis riceve entrambe le ricompense, δοιούς μισθούς, la capra e la coppa.
In questa lotta poetica, l’enigma e l’allegoria, oggi come in passato, occupano un posto di rilievo.
I viaggiatori raccontano che i pastori della Gallura mettevano in versi indovinelli tutti simili a quelli di Damœtas e Menalkas:
Die quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo,
tres pateat cœli spatium non amplius ulnas?
Forse, se la spiegazione data sopra dei sentieri notturni non sembra sufficiente, dovremmo considerare se non si possa trovare un’eco di questi indovinelli nei versi del nostro poeta sui sentieri così vicini al giorno e alla notte.
Credo che il poeta odisseo abbia trovato nel suo viaggio una descrizione di queste feste e tornei sardi, forse anche qualche modello di questi canti. Non è diverso che il viaggio di Hannon ci descriva i bambùlas dei neri senegalesi e le loro danze notturne al suono di flauti, cimbali e tamburelli [66].
In tutto questo, i nostri Lestrigoni sembrano essere un popolo reale quanto i Ciclopi. Anche in questo caso, il poeta sta semplicemente descrivendo la costa e i costumi, gli ancoraggi e il commercio degli indigeni.
Questi montanari della Sardegna possono offrire ai Popoli del Mare solo i prodotti delle loro mandrie e delle loro montagne: latte, formaggio, lana e legno. Sappiamo che il legno è sempre richiesto dai marinai, che ne hanno bisogno per le loro navi e città. Fino alla metà del secolo scorso, la Sardegna è rimasta una terra di grandi foreste e di bellissimi alberi. I marinai e le città marinare dell’Italia, della Provenza e della Spagna hanno sempre desiderato i suoi alberi di quercia, abete e castagno. Ma lo sfruttamento di questi boschi sardi è sempre stato difficile, quasi impossibile, per la mancanza di strade o di piste comode per trasportare il legname dalle vette, dall’alta montagna al mare:
«L’intera area [del Monte Urticu, sulla costa occidentale] era un tempo coperta da una magnifica foresta. Ma negli ultimi anni è stata gravemente danneggiata da ripetuti tagli sconsiderati. Sono state abbattute tutte le querce utilizzabili per l’edilizia e sono rimasti solo i lecci. Il bosco di Scano, che ho conosciuto come molto bello, è stato abbattuto nel 1821 da speculatori genovesi, che non hanno tratto da questo taglio un profitto equivalente al danno che hanno causato. Lo stesso si può dire di tutto il disboscamento che è stato fatto in altre parti dell’isola e che continua a essere fatto oggi. La grande difficoltà incontrata dai concessionari della foresta di Scano è stata quella di trasportare gli enormi pezzi di legno fino alla costa più vicina, che è molto disagevole per le navi. I comandanti di queste navi dovevano pagare una cifra enorme, a causa del pericolo di rimanere su questa costa durante il carico. Un’altra spesa importante fu l’apertura di strade per carri in questa foresta e fino al mare» [67].
Questa costa occidentale della Sardegna fornisce ancora oggi carichi di legname alle navi provenienti da Genova e da Livorno: le Istruzioni Nautiche dicono che da Bosa si esporta legname da costruzione. Per stabilire questo commercio fu necessario realizzare grandi strade tra i porti occidentali e le montagne dell’interno. Queste scoperte furono lunghe e costose da realizzare, poiché la struttura e la pendenza generale del paese non erano adatte a loro. Sulla costa settentrionale, invece, le pendici della Gallura e la valle del Liscia tracciano un percorso naturale, che devono aver sempre seguito i carri indigeni.
«L’attuale carro dei Sardi è antico almeno quanto il loro aratro. È diviso in due parti, che vengono semplicemente posizionate una sopra l’altra. Le ruote sono fissate all’asse, che scorre tra due pezzi ritagliati. Sono solidi e costituiti da tre pezzi di legno uniti insieme. Il carro sardo somiglia perfettamente al plaustrum dei romani e perfino al άμαξα dei greci. Le ruote piene, composte di tre pezzi, collegati anche da due traverse, e fissate ad un asse mobile mediante un foro quadrato, sono esattamente come quelle che i romani chiamavano timpani. Al carro vengono aggiogati i buoi come all’aratro… Questo carro serve per tutti i lavori dei contadini: quando vogliono trasportare paglia, terra, ecc., appoggiano all’interno dei muri una specie di stuoia, che forma come un grande cesto. Questa vettura marcia con molta difficoltà: l’attrito dell’asse produce un rumore molto sgradevole, «… montesque per altos contenta cervice trahunt stridentia plaustra» [68].
I compagni di Ulisse incontrano questi carri, questi amax dei Lestrigoni, che portano dalle montagne la legna in città. Qual era il vero nome di questi Lestrigoni? Abbiamo visto che Opiques o Oinotrians era il nome storico dei Ciclopi. Nel Nord della Sardegna i nomi più antichi di popolazioni indigene che gli Elleni abbiano conosciuto sono il nome dei Balares, Βάλαροι, e quello dei Korses [Corsi], Κόρσοι. Solo questi, secondo tutti i geografi e gli storici, sono i nomi delle popolazioni indigene. Tutte le altre popolazioni dell’isola, Sardi, Iolei, Ili, Libici, Iberici, ecc., provenivano dal mare. Ma anche gli Elleni sapevano che Βάλαροι, Balares, non è, in verità, un nome proprio: nella lingua dei Korses non è che un epiteto che significa fuggitivo, esiliato, fuggito, φυγάς, o, come direbbero gli isolani attuali, bandito. Nel corso dei secoli vediamo la Gallura e le isole vicine popolarsi di esuli, banditi corsi: il dialetto gallurese è molto più vicino al corso che al sardo. Essendo Balares solo un epiteto, il nome Korses, già noto agli Elleni, fu quindi, fin dall’inizio, l’unico vero nome del popolo stabilito sulle due sponde corsa e sarda delle Foci.
«La Maddalena e tutte le isole che la circondano sul versante sardo, a Sud dello stretto, non furono mai considerate dipendenti dal regno sardo prima del 1767. Solo allora. Il viceré Des Hayes inviò lì una forza navale per prenderne possesso in nome del re. Queste isole erano abitate a malapena da poche famiglie di pastori provenienti dalla Corsica… Queste si allearono con le famiglie di pastori del Nord della Sardegna e in brevissimo tempo si formò in questo luogo una popolazione di popolo robusto, formatosi dal sangue delle due nazioni [69]»… «La colonia corsa, fondata circa un secolo fa alla Maddalena, occupò dapprima la sommità, nel punto dove sorge la chiesetta della Trinità. Da allora questa colonia si è arricchita di profughi in fuga dalla coscrizione militare» [70].
Nell’arcipelago della Maddalena le nostre mappe riconoscono ancora il Capo dei Profughi, Punta Banditti: greci e romani avrebbero detto Capo dei Balares. Se volessimo sapere quale potesse essere stata l’esatta traduzione di balaros, banditto, φυγάς per i primi navigatori semiti, vedremmo subito che dobbiamo ricorrere alla radice s.r.d, che significa allo stesso tempo fuggire e fuggire, esci di casa ed evita il pericolo. Gli ebrei e gli arabi hanno l’aggettivo sarid, per designare il fuggitivo, il vagabondo, ciò che resta di una tribù o di un esercito dopo un’incursione o una sconfitta. Tale forma sarid, o forme equivalenti, saroud, sared, ecc., tradurrebbe quindi banditto e balaros. Gli Elleni sapevano che l’eroe Sardo, proveniente dalla Libia, era un discendente di Eracle. Credo che infatti il nome dei Sardi provenisse dalla Libia: era solo la traduzione fenicia di Balares.
I primi navigatori avevano qui la loro punta dei Balares, dei Sardi: non lontano dalla sorgente Artakiè, questo punto ha mantenuto fino a noi il nome di Punta di Sardegna: è, credo, solo un’antica Punta dei Banditi. Perché questo punto della Sardegna non è, come Capo Corsica sull’altra isola, la prima estremità del territorio insulare che si offre ai navigatori. Ma, al riparo delle isole della Maddalena, doveva essere la punta dei Sardi, dei Fuggiaschi, dei Corsi fuggitivi, che, dai tempi dei Fenici, venivano a sbarcare in queste rade di Liscia o di Mezzo Schifo, come oggi si viene a Porto Longone e Santa Teresa.
Raggiunsi Longo-Sardo con un battello disastrato. Sono stato accolto in casa di un còrso, il signor Antoine Peretti, che si è stabilito in Sardegna dopo essere stato costretto a lasciare la Corsica in seguito a una rissa scoppiata il giorno di Pasqua nella chiesa di Olineto, la sua patria, una scena da Medioevo in cui sono morti due uomini e ne sono stati feriti diversi, e che è valsa a Peretti una ferita da stiletto. Dopo diciotto anni di esilio, Peretti è stato recentemente assolto dalla Corte Reale di Bastia e può ora tornare nella sua isola natale. Quest’uomo straordinario, di cui conoscevo il coraggio e le avventure e che da tempo desideravo conoscere, al mio arrivo in Sardegna era in fuga e in clandestinità a causa di una vicenda tra la dogana e i contrabbandieri, in cui diceva di essere stato coinvolto accidentalmente e in cui era stato colpito da un proiettile allo stomaco. Mentre passavo per Longo-Sardo, Peretti era ancora costretto a rimanere nel paese dopo la lite con un mezzo medico, che aveva accusato di impertinenza e che, essendo troppo permaloso, gli aveva fatto una brutta ferita alla testa con il manico dello stilo.
Credo che il poeta odisseo avesse già annotato questo Capo dei Fuggitivi nel suo viaggio: al suo solito, è da questo toponimo che ha tratto l’avventura del suo romanzo. Perché sappiamo come lo fa. Abbiamo visto come il viaggio gli raccontasse l’ira e la pacificazione di Stromboli, i cambiamenti di Aiolos, seguendo la direzione dei venti, e come il poeta immaginasse il doppio viaggio di Ulisse ad Aiolos e la doppia accoglienza, benevola del vento del Nord, irritato del vento del Sud.
Nella nostra isola sarda, nei pressi di Pointe des Fuyards, il poeta immaginerà solo fughe. Innanzitutto si trattava della fuga degli uomini inviati ad esplorare il paese. È allora la fuga dello stesso Ulisse che sguaina la sua valorosa spada per poi tagliare gli ormeggi e fuggire, abbandonando il grosso della sua flotta.
Se l’episodio di Calipso è la Prigionia di Ulisse, se l’episodio di Cariddi e Scilla è il Naufragio, l’episodio dei Lestrigoni è la Fuga. Nel complesso e nei particolari, a questa fuga fu ricondotto l’intero episodio lestrigoniano: il grosso della flotta, che non doveva fuggire, andò a gettare l’ancora nel fondo del porto; l’unica barca di Ulisse, che doveva scappare, rimase fuori. Né a Kyklope, né a Kirkè, né a Skylla, Ulisse abbandona i suoi compagni in questo modo: solitamente, quando sguaina la sciabola, è per difendere le sue ciurme e non per tradirle. Ma eccoci all’Isola del Volo, in Sardegna.
Il viaggio doveva anche fornire al nostro poeta il nome dei Kors.
Pausania (o l’autore da lui copiato), dopo averci informato sul vero significato della parola balaros e sull’origine libica degli eroi sardi, aggiunge che l’isola chiamata Kurnos dagli Elleni aveva ricevuto il nome Korsika dai Libici [71]. Se Korsos è della stessa origine di Sardos, deve essere messo in relazione con la radice semitica k.r.s, che significa mordere, lacerare [72], sia letteralmente, cioè tagliare e macinare con i denti, sia figurato, cioè mordere con insulti, provocazioni o critiche. In arabo il verbo k.r.s ha tutti questi significati: in ebraico, per il significato figurato, usiamo piuttosto la frase mordere il pezzo, ekal keres, che i traduttori greci della Bibbia traducono con mangiare terribilmente, calunniare terribilmente, denigrare: l’equivalente più esatto sarebbe comunque parlare contro di esso. Si capisce allora perché il re dei Lestrigoni è un terribile mangiatore, che cattura uno degli inviati di Ulisse e lo mangia, e perché, allo stesso tempo, è l’accusatore, il calunniatore, il dittatore, Antiphatès. Il poeta odisseo sapeva che i Corsi, Korsim, erano laceratori, mangiatori di pezzi, okelim keres, o, come dicono ancora gli arabi, mangiatori di carne, okelim laham: è possibile che, traducendo da un lato in Anti-phatès, il poeta trascrisse dall’altro in Lamos, e questo forse ci spiegherebbe perché Telepylos, città di Antiphatès, è anche la città di Lamos, come Pylos, capitale di Nestore, è anche la città di Nélée.
All’origine di tutte queste belle cose non si può non mettere la frase trasmessa di viaggio in viaggio fino a Diodoro: gli indigeni dell’isola usano come cibo il latte, il miele e la carne [73]. Non sono mangiatori di pane né mangiatori di loto; sono mangiatori di carne, laceratori di carne, i Corsi: «il nome Corsi deriva da Korsis, schiava, guardiana di buoi» [74]. Quando Ulisse sbarcò, volle sapere chi fossero gli uomini mangiatori di grano di questa terra, e per questo inviò due uomini e un araldo verso la città: […]
In Sardegna troviamo i mangiatori di grano: «il Sud dell’isola ha pianure fertili in ogni cosa, ma soprattutto di grano». Ma i pastori delle Bocche e della Corsica «sono animali selvatici o bovini» [75], che «disertano la pianura e l’aratura e vivono solo di lana e carne» [76]. Alla carne delle loro mandrie aggiungono la carne del tonno. Un altro passo simile, che Diodoro copiò nei viaggi del Mare Eritreo, ci fornirebbe il testo stesso (o un esatto equivalente) del viaggio primitivo che forse aveva davanti agli occhi il poeta odisseo, quando immaginò il massacro degli Achei:
La corrente porta un’enorme quantità di pesci che vengono a cercare il cibo negli avvallamenti e sotto le rocce della costa, e il riflusso li abbandona in questi avvallamenti. Allora gli indigeni in massa, con donne e bambini, si precipitano sulle rocce e, divisi in bande, con urla selvagge, cominciano a cacciare. Donne e bambini catturano i pesci più piccoli e vicini della costa. Gli uomini attaccano i pezzi grossi, senza altre armi che corna affilate o frammenti di pietra [77].
Il viaggio odisseo aveva lo scopo di raffigurare i primi abitanti della Gallura con le armi, i costumi e i costumi che di loro conosciamo da testi e monumenti successivi [78]. Questi montanari della Sardegna sembrano essere stati gli svizzeri del Mediterraneo fenicio. Sempre pronti ad accettare la paga e i finimenti della guerra, ci appaiono come veri e propri soldati, cioè mercenari [79]. Le statuette in bronzo rinvenute sull’isola li rappresentano così come l’artista li vedeva intorno a sé e li raffigurava come meglio poteva, con i costumi che indossavano in guerra, a caccia o nelle occupazioni domestiche: i soldati costituiscono la serie più ricca e interessante. E gli archeologi ci descrivono a lungo questi soldati vestiti di metallo, con elmi e andature di metallo, armati di scudi, pugnali, archi, sciabole, arpioni e mazze. La statura di questi alti guerrieri è ulteriormente allungata dalle due gigantesche corna dell’elmo o da altre insegne [80].
Puntate molto in alto dietro l’uomo o sulla sua testa, queste insegne sono lunghe aste di ferro fissate dietro la statuetta e che sembrano uscire dalla faretra. È una freccia ingrandita, che indica la professione e l’abilità del personaggio? è una palma, simbolo di vittoria? Una di queste aste, terminante con due ruote, ha tutte le sembianze dell’asta di un carro, alla quale è attaccata una specie di cesta… A questi valorosi soldati la Scrittura darebbe il titolo che assegna sempre ai guerrieri di Giudici e di Re: gibor-hail, grande in forza, gigante in valore. Questa perifrasi, nella Scrittura, viene a significare solo soldato: άνήρ δυνατος, δυνατός ίσχύι traducono la Settanta. Penso che il viaggio primitivo dovette dare ai Sardi un titolo simile; il nostro poeta lo ha tradotto molto accuratamente come giganti di forza.
NOTE DI VIAGGIO
18 maggio 1901 [81]. — Partiti ieri sera da Civitavecchia col piroscafo che porta la posta quotidiana per la Sardegna, siamo arrivati questa mattina, prima dell’alba, nella baia degli Aranci: è l’avamporto del fangoso Golfo di Terranova [Olbia]. Qui prenderemo il piccolo piroscafo che, due volte alla settimana, serve la Maddalena: abbiamo quattro o cinque ore da aspettare. Tra enormi scogliere, le cui pareti scoscese sostengono lastroni piatti, il Golfo di Terranova [Olbia] spinge il suo corridoio nebbioso fino alla nebbia che, laggiù, galleggia sulla palude. Piene di grotte e nicchie, le scogliere sono popolate da innumerevoli uccelli. La Baia degli Aranci è interamente riparata dal mare aperto da Capo Figari e dal piccolo isolotto di Figarello: offre alle coste un ottimo riparo contro tutti i venti, tranne quelli da Sud-Est; abbondano acqua dolce e legname [82].
Finalmente stiamo partendo. Da [Golfo] Aranci alla Maddalena ci vogliono tre o quattro ore di traversata. Ma il vento contrario, che spira violentemente da Nord-Ovest, ritarda un po’ la nostra marcia e costringe le piccole barche a vela che ci seguono a rifugiarsi presto sotto i promontori di questa costa segmentata: le terre dell’interno formano una catena continua di alte montagne, che scendono, con numerosi anfratti, verso una costa molto frastagliata [83]. Niente è più monotono di questa costa dove promontori e depressioni si susseguono, tutti uguali, indistinguibili, di fronte a una sierra regolare [sierra: contrafforte montuoso dalla cresta molto frastagliata]. Solo l’occhio allenato dei piloti può scoprire alcuni punti di riferimento: il Monte Congianus è alto 650 metri e può essere utilizzato come punto di riferimento nella navigazione del golfo. Più avanti, la Testa di Cane, dalla forma particolare, e il Capo Ferro, dalla natura ferruginosa e dal colore rosso scuro, fanno ancora da guida.
All’ansa di Capo Ferro, appare all’improvviso l’Orso, tra le due cime del suo promontorio fatiscente. I navigatori provenienti da Est, una volta scoperto, hanno sempre in mente quest’Orso che li guiderà attraverso le pieghe e i canali delle Bocche. Precisa, ben staccata dal cielo, ben piantata sul piedistallo della sua alta penisola, la sagoma di questa roccia riproduce in modo meraviglioso il profilo dell’animale di cui porta il nome: allungando il collo, già ritto sulle due zampe anteriori, con le zampe posteriori ancora raccolte e semidistese a terra, l’Orso inizierà a camminare annuendo con la testa. È impossibile immaginare una statua realizzata da mani umane che possa dare una tale illusione di vita a distanza. Nell’accozzaglia di questi promontori, di questi golfi, di queste isole, di questi scogli, di queste pietre sgretolate, davanti a questa costa uniforme che segue sempre all’orizzonte la stessa catena montuosa dentata, i navigatori sono sicuri della loro rotta non appena salpati per l’Orso. Basta dirigersi verso di esso e doppiare la sua punta per scoprire l’ingresso corretto delle Bocche e proseguire dritto lungo il Cammino del tramonto. Sul posto, valutiamo correttamente l’utilità di questo promontorio e comprendiamo la fama che gli fecero i primi invasori.
Abbiamo attraversato il passo tra Capo d’Orso e Caprera, poi il passo tra Capo d’Orso e S. Stefano, e infine imboccato il canale tra S. Stefano e la Maddalena. Raggiungiamo il porto di quest’ultima isola. Questi canali insulari, tutti delimitati dallo stesso caos granitico, sarebbero un labirinto senza via d’uscita, se non fosse per il salutare segnale dell’Orso. Eccoci finalmente nel porto della Maddalena: sulla banchina è allineato un piccolissimo abitato, circondato da fortilizi staccati, intersecati da strade ad angolo retto. Dal piroscafo stesso, Dal piroscafo stesso, senza attraccare, noleggiamo una barca che ci farà riattraversare il canale e ci porterà in Sardegna, nella baia di Parau o Palau, alla sorgente dell’Orso.
In questa insenatura di Palau termina la strada maestra che, dall’interno, dalla cima dei monti, porta le vettovaglie dalla Gallura al mercato della Maddalena. In riva al mare e alla sorgente, alcune locande hanno allestito le loro case bianche. Man mano che ci avviciniamo a questa costa sarda, i blocchi di granito che punteggiano la riva appaiono più distinti. L’intera facciata della Sardegna è disseminata di enormi blocchi. Allo scalo di Palau, tra questi blocchi, emergono le cupole di grandi cumuli di carbone. L’unico commercio di Palau, oltre a rifornire la Maddalena, è la vendita del carbone, che arriva quaggiù dalle foreste di Tempio e che piccoli velieri francesi e spagnoli vengono a caricare per Marsiglia e Barcellona. Davanti alle locande, nove enormi mucchi di carbone costeggiano il mare: carri a due ruote, trainati da buoi, arrivano cigolando per scaricare le ceste e, davanti alle facciate bianche, riversano una nera nebbia di polvere fine.
Al termine di un piccolo molo sbarchiamo nei pressi di Palau. Speravamo di trovare un’auto che da qui ci portasse a Porto Pozzo. Ma, nelle quattro locande, non ci sono automobili: sulla strada, in fila, scendono e salgono solo i carri da buoi, pieni di carbone o vuoti. Dai tempi di Marmora, che ci ha descritto questi veicoli, i sardi hanno fatto qualche progresso: i loro carri non hanno più le ruote piene di un tempo; ma, salvo i raggi europei, credo che Ulisse riconoscerebbe ancora gli amax che scendevano dai boschi dei monti verso la città. Vicino alle locande sgorga una sorgente abbondante; le ragazze ed i barcaioli vengono lì a riempire le loro brocche e le loro botti: a questa fonte scese Artakiè la forte figlia del re Antifate.
Non avendo la macchina, abbiamo preso una barca per andare a Porto Pozzo. Proprio mentre stavamo lasciando il piccolo molo, arrivò un musicista che ci chiese di portarlo a bordo, con la sua chitarra, il suo mandolino e la sua bandiera. Ritornava dalla festa di San Pasquale, dove ha cantato, suonato, ballato per due e tre giorni di seguito. Vorrebbe andare a Santa Teresa. Saputo che stiamo andando in questa direzione, ci chiede un posto sul fondo della barca, sulle pietre che servono da zavorra. Telemaco ha accolto il supplice Teoclimeno: noi abbiamo accolto il musicista Antonio. Appena a bordo, si addormenta e russa con un suono che rallegra i nostri due rematori senza aver mai letto i versi dell’Odissea, uno di loro parla come il poeta: “Ecco un cantante che si guadagnerebbe il doppio della vita, col naso e con la sua bocca”.
Lasciamo Palau. Un maledetto vento di ponente mette in crisi i nostri vogatori. Lentamente, stancamente, mi sposto verso il porto di Mezzo Schifo, per poi puntare verso la Sardegna. Questo fiume è protetto da blocchi di granito, levigati, arrotondati, traforati, scavati e forati dall’agente atmosferico. Punta Sardegna fa parte di questo blocco: dall’alto fino in fondo, se si sovrappongono, rotolano e se si accumulano. Il primo paragone che viene in mente è quello di un campo di carneficina dove i giganti si sfidano a colpi di massi. Per i marinai europei, la vista di questo litorale non è affatto sorprendente: le nostre coste atlantiche possono offrire spettacoli simili. Ma nel Mediterraneo un simile caos granitico è raro. Soprattutto nel Mediterraneo di Levante, sarebbe difficile trovarne un esemplare. Provenendo dal Levante, i primi conquistatori erano abituati solo alle sabbie o alle pareti delle loro coste calcaree o paludose: devono essere rimasti colpiti da questo spettacolo del tutto nuovo. Fu nello stretto di Sardegna che incontrarono, forse per la prima volta, questi ghiaioni rocciosi. Navigando lungo questa costa, credo che si possa capire meglio la frase di Odisseo sulle pietre del mare, la più piccola delle quali poteva portare il carico di un uomo.
Dopo la punta della Sardegna, che ci copriva ancora un po’, eravamo completamente esposti al vento di ponente, che ci era contrario. Abbiamo dovuto bordeggiare all’infinito. Anche il musicista, che si era svegliato, dovette dedicarsi al duro lavoro di vogare. Per tre ore abbiamo virato e volato, dirigendoci verso lo Scoglio Colombo, la Roccia della Colomba, la Lais-Trigonie, che da sola può indicarci l’ingresso del Pozzo [si intende esattamente il canale che da Conca Verde porta all’attuale Porto Pozzo]. Perché l’ingresso del Pozzo è invisibile: la Punta delle Vacche lo copre; sotto i suoi ghiaioni, questa Punta assomiglia a tutti gli altri punti di questo passo. Il vento da Ovest, sempre più fresco, ha sollevato una forte mareggiata che ha nuovamente ostacolato i nostri sforzi. Abbiamo impiegato tre o quattro ore per percorrere cinque chilometri.
Infine, dopo aver doppiato la Punta delle Vacche, siamo arrivati al canale di Porto Pozzo. La bocca, molto stretta, ha una sorta di frangiflutti naturale su entrambi i lati, perpendicolare alla riva, che getta i suoi massi caduti nel canale. Ci sono diversi scogli che attraversano la strettoia, rendendo l’ingresso molto difficile.
Abbiamo fermato la nostra barca fuori dallo stretto. A vele spiegate, remi retratti, leghiamo l’ormeggio agli scogli che, dalla punta, cadono in mare. Ci siamo buttati sulle rocce a sinistra. Dietro di noi, nel mare, sopra la barca che ondeggiava nel moto ondoso, appaiono gli scogli della Roccia di Colombo.
Davanti a noi il canale di Porto Pozzo apre le sue due pareti di roccia sgretolata. La pendenza non è molto ripida. Ma l’epiteto odisseiano ήλίβατος, dove non si cammina, si sale, raffigura con perfetta precisione questo caotico pendio roccioso, dove camminare è difficile e la salita un po’ pericolosa, a causa di scivolamenti e inciampi su queste superfici arrotondate, lisce e contorte.
Dall’alto, da Punta Macchia Mala, tutto il porto appare liscio, senza onda, senza una macchia. Questo specchio leggermente appannato contrasta con il grande mare stellato di onde danzanti, che il vento di ponente agita fuori dall’insenatura. In fondo al porto, una breve spiaggia di sabbia e palude delimita una pianura ondulata. Alcune case, nella frazione di Dispensa, fiancheggiano la strada che, a scalini, sale lentamente verso le colline lontane. Questo nastro di strada principale è ben visibile. Il villaggio di S. Pasquale corona le prime alture. Alle sue spalle, in lontananza, si erge la sierra costiera, la cui parete è carica di boschi e nuvole di pioggia.
Queste alte montagne chiudono l’orizzonte in un cerchio continuo; ma la profonda valle del fiume Liscia vi scava un ampio varco. Il nastro della strada principale appare distintamente: la sua linea retta, partendo dal porto, taglia la pianura, poi le sue curve piegate si aggrappano al fianco delle colline e delle montagne. Questo punto di Macchia Mala è davvero un belvedere ripido. Fino alla Maddalena, questa vedetta di Macchia Mala, alta 94 metri e isolata su tutti i lati, vigila sui canali e sulle isole. All’orizzonte orientale, sopra Punta Sardegna, l’indimenticabile sagoma dell’Orso domina l’intero mare dello Stretto.
Siamo tornati alla nostra barca. Abbiamo sciolto l’ormeggio. Avremmo voluto doppiare il Capo di Erebus e ripartire sui sentieri del tramonto verso Santa Teresa. Ma il vento di ponente, sempre più fresco, ci costringe ad abbandonare le rotte notturne e ad intraprendere i sentieri diurni verso la Maddalena. Quindi, con questo forte vento in coda che schiaffeggia le vele, lasciamo che il pilota e la brezza facciano il loro lavoro: i rematori spillano il vino dalla botte; il musicista trova la sua chitarra e, cantando e bevendo, corriamo sulla schiena dell’onda, che salta e geme lungo il bordo. In versi alternati, il musicista e i marinai cantano un lamento senza fine, dove si parla dell’amore e degli uccellini.
Il vento rinfresca. Scappiamo dalle raffiche. Facciamo rotta verso la rada della Maddalena. La pioggia comincia a cadere in gocce grandi e pesanti. All’improvviso, lo stretto si riempì di urla e di fischi. Una flottiglia di piroscafi corre verso di noi da tutti i punti dell’orizzonte. Ci salutano. Gridano ordini e, a quanto pare, minacce. A tutto vapore arriva al nostro fianco una barca carica di uniformi. Un condottiero dei Lestrigoni, – voglio dire: un grande ufficiale di marina, – calò un rampino e ci fece prigionieri.
Su ordine del capo, due Lestrigoni in uniforme vengono a sedersi sulla nostra barca per osservare ciò che diciamo e facciamo. I nostri bagagli sono confiscati. Con fischi di trionfo, la flottiglia ci prende a rimorchio e ci trascina all’interno del porto, nella rada militare. Il nostro equipaggio e anche lo sfortunato musicista vengono imprigionati. Veniamo portati in questura: siamo accusati di spionaggio in queste acque strategiche. Per grazia, però, a causa dei nostri vestiti gocciolanti e della nostra stanchezza, – il capo dei Lestrigoni è stato gentile nell’assolvere questo noioso compito -, rinvia al giorno successivo il nostro interrogatorio davanti al re supremo di questi giganti della forza. Ci hanno addirittura restituito i bagagli. Ma si esige di promettere che non lasceremo l’alloggio assegnato e che non parleremo con nessuno. Una guardia segue ogni nostro passo.
Il giorno dopo, l’ammiraglio italiano che comanda l’arsenale ci fa interrogare a lungo: nonostante le nostre smentite, sembra convinto dei nostri colpevoli disegni. Qualche perfido calunniatore deve aver mangiato la nostra carne, perché l’ammiraglio contraddice tutto quello che affermiamo per difenderci: siamo nelle mani di Antifate. Dopo qualche ora, però, Zeus gli invia pensieri meno crudeli. Il testo greco dell’Odissea, un Atlante antico e un dizionario ebraico di F. Leopoldo riescono a convincerlo che i nostri studi non avrebbero potuto nuocere alla sicurezza delle flotte italiane. Decise di lasciarci piena libertà di movimento, perché almeno quel giorno era domenica; domani lunedì telegraferà a Roma e chiederà di noi al nostro ambasciatore. Siamo quindi liberi di soggiornare alla Maddalena, ma non di attraversare lo stretto.
Cosa fare in questo porto chiuso dove abbiamo solo la libertà sulla parola… Dobbiamo anche confessarlo. che avevo dei timori, non tanto per la crudeltà di questi Lestrigoni quanto per lo zelo, comportamento prematuro dei nostri diplomatici? Certamente la mia esplorazione delle Bocche non è stata un’impresa sospetta o ingiusta. Nonostante le fotografie che abbiamo scattato, non riuscirò mai a smascherare il minimo cannone o il minimo siluro. Come accademico non sono mai stato, nemmeno per un anno, un “gigante di forza”… Eppure temevo le informazioni troppo precise che forse il nostro ambasciatore avrebbe dato sulla mia identità. A volte mi occupo di politica estera e io insegno geografia alla Scuola superiore della Marina. Se il re dei Lestrigoni venisse a conoscermi in questa veste, tutti i dizionari ebraici potrebbero scagionarmi dal sospetto di spionaggio?… Durante il giorno partì una nave per Livorno. Con il permesso di Antifate, l’abbiamo preso.
Ed è per questo che ho potuto fornire qui solo mediocri fotografie dell’Orso: i nostri barcaioli dovevano portarci su questo promontorio riportandoci nel Golfo degli Aranci. Prima di fuggire da Lestrigonia, avevo almeno ottenuto la libertà del nostro equipaggio. Forse un giorno il musicista metterà in versi questa avventura del mio Nostos. Annone il Cartaginese racconta nel suo viaggio come, un giorno, fuggì anche lui, temendo la ferocia degli isolani e seguendo il consiglio dei suoi indovini. [84].
QUI LE IMMAGINI INCLUSE NEL LIBRO:
https://archive.org/details/lesphniciensetl00brgoog/page/212/mode/2up
https://archive.org/details/lesphniciensetl00brgoog/page/218/mode/2up
https://archive.org/details/lesphniciensetl00brgoog/page/246/mode/2up
https://archive.org/details/lesphniciensetl00brgoog/page/250/mode/2up
https://archive.org/details/lesphniciensetl00brgoog/page/252/mode/2up
https://archive.org/details/lesphniciensetl00brgoog/page/254/mode/2up
2) 1912: IL SECONDO VIAGGIO IN SARDEGNA DI VICTOR BÉRARD
CON IL CELEBRE FOTOGRAFO SVIZZERO
FRED BOISSONNAS
Presentazione di Guido Rombi
Nell’estate del 1912, per tre giorni interi ‒ dal 17 al 19 agosto ‒ due viaggiatori stranieri veleggiano (barca a vela di 36 tonnellate e un albero alto 12 metri) dinanzi alla Costa Nord della Sardegna, da Capo Testa a Capo Figari. In realtà la perlustrano, ancorano davanti alle numerose calette e rocce, prende appunti il primo, scatta foto l’altro. Uno, Victor Bérard, è francese ed è uno studioso già di grande fama (e tra i maggiori di sempre) di Omero e in particolare dell’Odissea, l’altro è svizzero di Ginevra ed è un fotografo dei migliori in circolazione, Fred Boissonnas.
Che ci fanno insieme in questo viaggio? Cosa cercano? Per saperlo, bisogna sapere di Bérard, partire da lui… è una lunga ma così affascinante storia! Una storia che Gallura Tour ha deciso di raccontare in modo esteso, vista la particolare rilevanza della Sardegna nella sua narrazione.
Per farla invece breve in questa presentazione, Victor Bérard aveva collocato qui, in questa costa della Sardegna nord-orientale, quindi della Gallura, la presenza dei Lestrigoni, quel popolo raccontato nell’Odissea di giganti antropofagi che distrussero la flotta di Ulisse e uccisero molti dei suoi uomini infilzandoli con enormi spiedi (per Bérard un’interpretazione metaforica della spettacolare pesca del tonno effettuata in Sardegna)... Si salvò dalla strage solo la nave dell’eroe, rimasta all’ancora fuori dal porto. Ne aveva scritto nel secondo volume di Les Phéniciens et l’Odyssée (I Fenici e l’Odissea), pubblicato nel 1903, esattamente nel capitolo 8, paragrafo II. Un libro che sarebbe stato di un’importanza si può dire epocale, e non è una esagerazione. (SI VEDA QUI). Prima di scrivere quelle dense pagine Bérard aveva già navigato lungo la costa gallurese in compagnia della moglie Alice con funzioni di fotografa. (Sono sue le poche fote nel libro, che riportiamo nella pagina a parte indicata, sebbene non apprezzabili).
Bérard, eclettica e affascinante figura di studioso e navigatore instancabile, oltre che di politico (senatore della sinistra repubblicana), ha però ora un nuovo progetto, un’opera che ricostruisca la navigazione di Ulisse con a corredo un’apparato fotografico di grande levatura. «Era opportuno», scrive il figlio Bérard, ambasciatore di Francia, «che l’illustrazione di un poema come l’Odissea fosse accompagnato da vedute degne di esso». Altre note biografiche di un certo interesse sono state recentemente raccolte dai nipoti Étienne Bérard et Reine-Marie Bérard (QUI al momento in lingua francese e inglese).
E questa volta vuole con sé a documentare il suo viaggio in Sardegna “sulle orme di Ulisse” – viaggio che comprendeva altri litorali dell’Italia centrale e meridionale –, uno dei più affermati fotografi internazionali, lo svizzero Fred Boissonnas, già suo collaboratore comunque dieci anni prima per alcune sezioni di Les Phéniciens et l’Odyssée, infatti lì citato nei ringraziamenti: «M. F. Boissonnas, di cui sono note le mirabili fotografie di montagne, si è messo a mia disposizione per un viaggio in Grecia; ha intrapreso la circumnavigazione di Itaca seguendo le mie istruzioni, al solo scopo di mandarmi i documenti di cui avevo bisogno».
Fred Boissonnas accolse anche questo invito e si appassionò all’impresa accettando di buon grado tutte le difficoltà. Il viaggio al seguito di Ulisse si svolse tra l’estate e l’autunno del 1912. Fu effettuato in più tappe a seconda delle possibilità materiali e degli obblighi professionali di entrambi». Il risultato sarebbe stata la pubblicazione postuma Dans le sillage d’Ulysse. Album odysséen [Sulla scia di Ulisse. Album di Odisseo], Paris 1933.
Sappiamo le date di questo viaggio grazie al ricordo, ma forse meglio dire una preziosa biografia, di cui abbiamo sopra riportato alcune righe, scritta dal figlio Armand, peraltro facendo le veci del fratello Jean, prematuramente e drammaticamente deceduto, e che seguendo la passione del padre si era già affermato tra i migliori giovani ellenisti degli anni Quaranta e Cinquanta.
L’esito di quel viaggio in tandem nel Mediterraneo saranno – dicono Étienne Bérard et Reine-Marie Bérard – 1400 lastre fotografiche in vetro, 175 delle quali furono pubblicate nell’Odyssean Album 75. Accanto alle fotografie dell’Odissea, pensate per essere viste tenendo in una mano l’ Album e nell’altra il testo dell’Odissea , si trova un resoconto geografico ed etnografico sul Mediterraneo nel 1912. (Estelle Sohier, si veda sotto doce «più di 2.000 fotografie su lastre di vetro»): foto oggi conservate e visionabili presso la Biblioteca di Ginevra, che nel 2021 ha dato luogo ad una mostra al Musée Rath di Ginevra, intitolata “Fred Boissonnas e il Mediterraneo”.
Delle migliaia di foto conservate presso la Biblioteca di Ginevra, Gallura Tour propone quelle sulla Sardegna – circa un centinaio di foto tra Santa Teresa e Capo Figari poco o nulla conosciute –, dopo averle pazientemente organizzate però per località e anche un po’ in ordine di scatto, per offrire una migliore consultazione delle stesse. Al sito della biblioteca di Ginevra, che oltre al merito di averle rese fruibili consente la migliore visualizzazione delle stesse, rimanda il click su ciascuna. Si apprezzerà la maestria nella tecnica di Fred Boissonas. In più casi fotografie di una nitidezza che potrebbero essere state fatte oggi. E invece siamo nel 1912! Sono foto uniche, le prime foto della Costa della Gallura dal mare, di Conca Verde e Porto Pozzo, Porto Pollo e poi Capo d’Orso e Capo Figari, integrate da inediti scatti del Porto di Santa Teresa Gallura e da scene di vita quotidiana a Palau.
Questo corpus documentale, sebbene abbia un gran valore a sé stante come tutti i reportage fotografici, ne acquisisce ancora più se visto come un supporto e completamento visivo delle pagine dedicate da V. Bérard a Ulisse in Sardegna. Colto “nella sua interezza”, ad esse collegato, è un lascito ancora più prezioso per la Sardegna: si tratta di una pagina di storia, di letteratura, e insieme di fotografia della Sardegna, di respiro veramente internazionale sia culturale sia turistico. Una pagina ad oggi del tutto dimenticata nei libri di “cose sarde”, molto male usata da certi per mancanza delle “necessarie lenti”, sfiorata forse ma non compresa e perciò accantonata da altri.
LE FOTO
DA CAPO TESTA A CAPO FIGARI, SULLA SCIA DI ULISSE
di Fred Boissonnas 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒
1912
CLICCARE QUI
3) VICTOR BERARD E I SUOI VIAGGI RACCONTATI DAL FIGLIO ARMAND BERARD
VICTOR BÉRARD ET LES NAVIGATIONS D’ULYSSE (ca. 1971)
di Armand Bérard – Ambassadeur de France
traduzione in italiano di Gallura Tour
Quarant’anni fa, Victor Bérard morì, a seguito di una crudele malattia, ad un’età non troppo avanzata. Dal 1920 rappresentava il dipartimento della Giura al Senato; vi presiedeva la commissione per gli affari esteri dopo aver presieduto la commissione per l’istruzione; ma altrettanto rimase occupato dagli studi omerici che aveva portato avanti per tutta la vita. Perché questo giurassiano di nascita era mediterraneo per scelta. Della sua opera ellenista, la sua traduzione dell’Odissea in versi sciolti continua ad essere regolarmente ristampata nella collezione Guillaume Budé, dove apparve per la prima volta. I tre volumi della sua Introduzione, ricercati da tutti gli omeristi, non hanno ancora potuto essere ripubblicati. Anche i suoi Phéniciens et l’Odyssée, le sue Navigations d’Ulysse, il suo Album odysséen erano fuori stampa.
I quattro volumi delle Navigations sono appena stati ripubblicati e l’album Dans le Sillage d’Ulysse (Sulla scia di Ulisse) lo sarà quando appariranno queste righe (1).
Riportiamo come sono stati concepiti e come sono nati.
Figlio di un farmacista di Morez-du-Jura, Victor Bérard è stato inviato, da bambino, come borsista al liceo di Lons-le-Saunier, poi, da adolescente, al liceo Louis-le-Grand di Parigi. Nell’autunno del 1887, dopo aver lasciato la Scuola Normale, partì per la Scuola di Atene. Per questo montanaro, abituato alla stretta e austera valle di Morez, ai suoi ripidi pendii di calcare bianco coronati di scuri abeti, la scoperta della Provenza, di Marsiglia, delle sponde del Mediterraneo, di Roma dove gli Ateniesi sostarono nella villa Medici, poi la Grecia fu una rivelazione, un’esperienza folgorante.
Più tardi, quando dopo il matrimonio, ragioni familiari lo indussero a trascorrere le vacanze a Saint-Valéry-en-Caux, fu al Mediterraneo che pensò dall’alto delle scogliere della Manica, come a Calypso, ai Pilastri di Ercole, Ulisse, il suo eroe, pensava all’isola natale e al mare.
Dalla Scuola di Atene, andò, per due primavere consecutive, nel 1888 e nel 1889, a dirigere gli scavi di Tegea e Mantinea nel Peloponneso. Fu lì che raccolse le impressioni e concepì le teorie che avrebbero governato tutti i suoi studi. Lo raccontò nell’introduzione alla sua tesi Sull’origine dei culti arcadici, pubblicata nel 1894. Le «innumerevoli festività non lavorative del calendario ortodosso» lasciavano a lui e ai suoi operai qualche giorno di svago quasi ogni settimana. Se ne servì per visitare, col suo Pausania in mano, tutti i cantoni dell’Arcadia. Rimase colpito, scrisse, dalla “mirabile accuratezza di questa guida” e del suo libro Gli Arcadici, mentre viaggi e scavi «gli mostravano ogni giorno più chiaramente quale differenza separa i culti arcadici dalle altre religioni più propriamente elleniche». Fu così portato, come Pausania, «a riunire certi miti orientali, dei Cari o siriani, con i miti arcadici».
Ne emergeva una duplice conclusione: era necessario riconoscere gran parte di verità e di reale conoscenza che la tradizione antica contiene ed era ovvio che gli elementi orientali e più in particolare i navigatori e colonizzatori fenici avevano assicurato alla primitiva civiltà della Grecia un grande contributo. Questo è stato il principio guida della sua ricerca; tale fu l’oggetto delle sue riflessioni mentre, tornato come tutor all’Ecole Normale, come “caimán” secondo la lingua di rue d’Ulm, vi preparò la sua tesi; tale era la convinzione che ripeté, trentadue anni dopo, nella prefazione alla nuova edizione de I Fenici e l’Odissea: “Fedele alle opinioni da me espresse nel 1894, credo con Erodoto che, provenendo dal Mar Rosso alle rive del “nostro mare”, intorno al XXV o XXX secolo aC, i Fenici furono, dal XVI all’XI secolo, i principali fattori di influenza faraonica nelle acque del Levante. » Le loro storie, i loro portolani avevano ispirato l’autore o gli autori dell’Odissea.
Durante il suo primo soggiorno all’Ecole Normale, Victor Bérard fu profondamente influenzato da due maestri: Brunetière e Vidal de la Blache. Gli studi di storia e geografia non erano allora, come divennero in seguito, nettamente separati dalle lettere. L’arte di esprimere i propri pensieri e lo stile per farlo giocavano un ruolo importante ed erano considerati strumenti necessari. Le lezioni di Brunetière riunivano tutti gli studenti; volevano imparare da lui questa costruzione logica, questa deduzione in cui eccelleva. A Vidal de la Blache chiedevano il talento di evocare i legami tra una regione, un paesaggio, le condizioni geografiche e le persone che vi abitavano. Vidal mantenne tra i suoi modelli il Tableau de la France di Michelet.
È in parte seguendo questa tradizione che è stata educata la generazione di mio padre. Conservo per molti anni le sue lezioni all’Ecole Supérieure de Marine. Il suo insegnamento scientifico si basava su una documentazione solida e precisa e i suoi ascoltatori, capitani di fregata o di nave, non erano uomini che, su questo punto, potessero lasciarsi ingannare.
Ma, partito da questa base, cercò di andare sempre più in alto e più lontano dalla tradizione che Vidal gli aveva insegnato. I suoi scavi gli avevano dato l’idea; la Marina gli donò l’esperienza. Per ventitré anni, dal 1891 al 1914, visse questo legame. Mentre, dal 1891 al 1894, scriveva a l’Ecole la sua tesi principale De l’Origine des Cultes Arcadians (Dell’origine dei culti arcadici) e la sua tesi accessoria in latino De Arbitrio inter liberas Graecorum Civitates, aveva accettato, per integrare il suo magro stipendio di tutore, le funzioni di esaminatore di ammissione all’Accademia navale, che mantenne dal 1891 al 1901. Conobbe intimamente i suoi colleghi di «Rue Royale». Con loro aveva preso l’abitudine di percorrere a piedi, ogni anno una nuova, una parte del viaggio che li conduceva successivamente ai nostri diversi porti di guerra dove si svolgevano le prove orali: Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Tolone. Visse con loro per molte settimane. Frequentò gli ultimi ufficiali che avevano prestato servizio nella marina velica. Divenne un avido lettore delle Istruzioni nautiche, che gli sarebbero state di grande aiuto nella sua ricerca sull’Odissea. Si avvicinò veramente alla vita del mare. L’aveva già imparata praticando la vela con Charles Seignobos e gli amici universitari che lo circondavano ad Arcouest. Dall’enorme Glossario Nautico, ha acquisito un’abitudine duratura.
Dal 1896 al 1914, il suo corso di geografia all’Ecole Supérieure de Marine lo mise, tutto l’anno, in contatto con ufficiali che avevano una lunga esperienza di navigazione e dei mari europei. La generazione di marinai di quest’epoca era particolarmente colta e curiosa d’animo. Scrivevano non senza talento. Raccontando i loro viaggi, le loro stazioni sulle coste del Mediterraneo, dell’Africa o dell’Asia, diventavano narratori affascinanti. Inviarono a mio padre estratti dei loro diari di bordo, copie di rapporti, resoconti delle loro osservazioni, impressioni politiche e storiche sulle popolazioni con cui vivevano o sui problemi sorti nella loro regione.
Sarà da marinaio che Victor Bérard ripeterà il viaggio di Ulisse. Ma, prima di raccontare i suoi viaggi, è opportuno citare un tratto del suo carattere che fa luce sulla sua opera. Non separò mai le sue ricercche sul mondo antico dall’osservazione del mondo presente; studiava parallelamente le colonizzazioni e le pratiche commerciali a trenta secoli di distanza. Albert Thibaudet, che era suo ammiratore e amico, scrisse di essere tornato da Atene «con due valigie: il suo bagaglio di idee odissee e il suo bagaglio di idee e politica orientali, la sua Atena a riposo e la sua Atena con l’elmo». Alla Grecia e all’Oriente delle iscrizioni e delle rovine unì, infatti, la conoscenza della Grecia e dell’Oriente del suo tempo. Membro della Scuola di Atene, durante le vacanze aveva visitato la Macedonia, oggetto di tanti concorsi a quel tempo. Fece un’altra visita nel 1896. Ne riferì in un’opera di impressioni e suggestioni apparsa nel 1897 e che fu il primo di una lunga serie di libri sulla politica estera.
Nel 1901 ebbe luogo il suo primo viaggio di esplorazione sulle orme di Ulisse. In compagnia di Alice Colin, che aveva sposato nell’ultimo anno del secolo, partì per una ricognizione dei luoghi odissei. Bisogna aver sentito mia madre raccontare questa storia per avere un’idea di cosa significasse viaggiare in Grecia al di fuori di Atene: Lunghe tappe a piedi o a cavallo lungo mulattiere non ombreggiate, sotto un sole cocente; arance raccolte lungo la strada, che spesso si rivelavano amare, per rifocillarsi; un pollo etico, il cui collo si chiedeva al contadino di strizzare, e che si preferiva friggere da soli; per quanto riguarda le stanze degli ostelli, il piede troppo spesso faceva salire una nuvola di pulci: bisognava rassegnarsi a passare la notte con loro. I treni erano rari, due o tre volte alla settimana; quando apparivano all’orizzonte, in mancanza di una strada, bisognava correre sulla massicciata fino alla fermata successiva; Alice Bérard sentiva la rivoltella nella tasca della sottoveste, che era costretta a portare a causa dell’incertezza del paese, mentre mio padre era carico di mappe e libri.
I miei genitori si recarono in pellegrinaggio a Mantinée; lì, sul muro della casa contadina dove aveva trascorso i mesi di scavo nel 1888 e nel 1889, mio padre trovò il suo tubo di zinco, coperto dalla polvere di tredici anni, appeso al chiodo dove l’aveva appeso.
Da questo viaggio, Victor Bérard scrisse i due volumi di Les Phéniciens et l’Odyssée, pubblicati nel 1902-1903. Le illustrazioni, o meglio la documentazione fotografica, furono opera di Alice Bérard. Aveva scattato tutte le fotografie e, durante i mesi estivi, dopo aver allestito una camera oscura nella sua casa di Saint-Valéry-en-Caux, le aveva pazientemente sviluppate e stampate. Gli appunti di questa spedizione del 1901 sono ampiamente utilizzati nei quattro volumi delle Navigazioni, dove sono stati integrati da osservazioni più recenti. Ma poco dopo, l'”Atena con l’elmo” ebbe la precedenza sull'”Atena a riposo” per alcuni anni.
Nel 1901, su richiesta di Lucien Herr, l’indimenticabile bibliotecario dell’Ecole Normale, il cui sapere enciclopedico mise a disposizione di tante generazioni di accademici, Victor Bérard entrò a far parte della Revue de Paris come editorialista.
Nel 1904, sotto la pressione di Herr che abbandonò la segreteria generale della Rivista, accettò di succedergli. La preparazione di ogni numero, la ricerca e la lettura dei manoscritti, la correzione delle bozze, la supervisione della composizione occuparono tutte le sue giornate, contemporaneamente alla stesura degli articoli di politica estera. Victor Bérard ha poi rielaborato questi articoli e li ha pubblicati in libri, sforzandosi, “tra gli eventi e le trattative, di eliminare le questioni effimere, di considerare solo gli interessi permanenti, i problemi duraturi”. Alla Macedonia succedettero la Turchia e l’ellenismo contemporaneo, Gli affari di Creta, La politica del sultano, Le questioni esterne, La rivolta dell’Asia, La Francia e Guglielmo II, L’affare marocchino, Il sultano, L’Islam e le potenze, La rivoluzione turca, La Morte di Istambul e quei libri che, per le loro visioni profetiche o per le vaste immagini che dipingono della vita di un popolo o di un paese, rimangono, dopo mezzo secolo, dei classici: Le rivoluzioni di Persia, Inghilterra e imperialismo, Russia e lo zarismo. Durante questo primo decennio del secolo, però, le preoccupazioni di mio padre crebbero di fronte alla direzione presa dalle relazioni franco-tedesche e alle ambizioni di Berlino. Lo ha detto ne L’affare marocchino e in La France et Guillaume II. Lo ha ripetuto nei suoi articoli. Istruito dagli esempi del passato, questo storico dubitava della durata della colonizzazione.
Riconosceva pienamente il lavoro compiuto dalla Francia nel Nord Africa. Era persino appassionato del nostro impegno. Aveva visitato spesso la Tunisia, dove un tempo Armand Colin aveva fondato un villaggio; aveva visitato la maggior parte dell’Algeria; in Marocco, stretto amicizia con Lyautey, aveva percorso le ferrovie militari a dresin, a cavallo o su un’autoblindata lungo i binari appena tracciati. Ma temeva che la guerra europea sarebbe nata da qualche rivalità coloniale e, soprattutto dopo la vicenda di Agadir, era ossessionato dal timore che una penetrazione da noi effettuata troppo in fretta in Marocco non avrebbe dato a Guglielmo II l’occasione auspicata per cogliere un litigio con noi. Alla fine della politica di conquista marocchina, vide chiaramente la guerra dei Balcani, poi la guerra mondiale. I gruppi colonialisti intervennero presso Lavisse, direttore della Revue, affinché le cronache di Bérard avessero un orientamento diverso. Mio padre si rifiutò di mettere a tacere le sue convinzioni e si dimise.
Occupò una cattedra di geografia storica all’École des Hautes Etudes, dove allora l’insegnamento era molto mal retribuito, e riprese le sue ricerche omeriche. Era la seconda metà del 1911. Mentre continuava la traduzione e i commenti al testo dell’Odissea, voleva fornire una prova scientifica dell’idea che aveva avanzato nel 1894 nella sua tesi e che aveva sviluppato nel 1902 in Les Phéniciens et l’Odyssée. Il poema omerico «non è un semplice insieme di racconti: è un documento geografico, la pittura poetica, ma non distorta, di un certo Mediterraneo, che aveva le sue abitudini di navigazione, le sue teorie del mondo e della vita navale, la sua lingua, le sue istruzioni nautiche e il suo commercio. Reciprocamente, questo Mediterraneo fenicio, una volta esplorato, ci spiega l’insieme e i dettagli delle avventure odissee: Ulisse non naviga più nella nebbia della leggenda, in paesi immaginari; di capo in capo, di isola in isola, costeggia coste già frequentate dal commercio di Sidone».
E Victor Bérard prosegue: «Gli antichi erano abituati a cercare nei poemi omerici la fonte di ogni scienza e di ogni verità, perché un’opera greca non è mai un prodotto della sola immaginazione; i poemi omerici e soprattutto l’Odissea non possono essere paragonati alle enormi teratologia degli indù né alle folli fantasticherie degli arabi: «Costruire una vana teratologia senza alcun fondamento di verità non è omerico» dice Strabone. È meglio paragonare all’Odissea quei poemi geografici e utilitaristici che i Greci e i Romani componevano o traducevano per codificare le loro scoperte e quelle degli altri… I poeti greci intendevano innanzitutto istruire o moralizzare il loro pubblico: i poeti omerici dovettero adattarsi agli stessi gusti. I loro contemporanei ascoltavano più volentieri versi che potevano aiutarli nella navigazione.
Trascorrendo un’ora piacevole, questi uomini pratici volevano imparare la strada per l’Eldorado, la lunghezza del viaggio e il ritorno attraverso il mare pieno di pesci: «Eratostene, dice Strabone, «sosteneva che ogni poeta cerca solo divertimento e non la verità.»
Ma una scuola opposta, quella dei «più Omerici che seguono l’epos versetto per versetto», sapeva che la geografia di Omero non è inventata, che «il Poeta è invece il capo della scienza geografica»: i suoi resoconti sono esatti, «molto spesso più esatti di quelli delle epoche successive; contengono indubbiamente una parte di allegorie, di decorazioni, di artifici popolari; ma sempre, e soprattutto nei Viaggi di Ulisse, hanno un fondamento scientifico»… Quanto più si avanza nello studio dei Viaggi di Ulisse, tanto meglio si verifica l’esattezza di questa frase: le più fantasiose descrizioni odissee in apparenza contenere sempre qualche copia precisa della tua realtà… «Devi seguire il metodo del più Omerico, attaccarti a tutte le parole dell’epos e, per comprendere veramente il testo, collocare l’opera nella serie di libri simili che, di secolo in secolo, di talassocrazia in talassocrazia, si sono trasmessi fedelmente le marinerie mediterranee: Istruzioni nautiche, Portulani, Piloti, Torce o Specchi marini (1).»
Nel 1912, Victor Bérard decise di completare l’identificazione dei siti odisseici, in particolare quello della grotta di Calipso, dell'”isola” di Circe, del porto dei Lestrigoni e prelevare, generalmente dal mare, documenti fotografici che ne fornissero la giustificazione. Alice Bérard si trovò trattenuta a Parigi per obblighi familiari. Ma l’attenzione di mio padre era stata attirata da un fotografo ginevrino di grande talento, Fred Boissonnas, che, dopo essersi fatto conoscere per le sue fotografie alpine, aveva appena pubblicato, nel 1910, con Daniel Baud Bovy un notevole album In Greece over hill and dale.
Era opportuno, secondo Victor Bérard, che l’illustrazione di un poema come l’Odissea fosse accompagnato da vedute degne di esso. Fred Boissonnas si appassionò all’impresa e accettò di buon grado tutte le difficoltà.
Il viaggio al seguito di Ulisse si svolse tra l’estate e l’autunno del 1912. Fu effettuato in più tappe a seconda delle possibilità materiali e degli obblighi professionali di entrambi.
Imbarcati a Marsiglia, scesi a Gibilterra, Bérard e Boissonnas visitarono per la prima volta, dal 1 al 5 agosto, sull’altra sponda dello stretto, il Mont aux Singes, Pérégil, la baia di Benzus, dove ebbero la gioia di trovare la “grotta delle quattro sorgenti”, quella dove Calipso tenne tanto a lungo il suo “divino Ulisse”.
L’11 agosto, da Roma, raggiunsero il Monte Circeo in treno, poi in automobile; ma le difficoltà pratiche non permettevano loro di visitare con soddisfazione “l’isola della dea”.
Il 17 agosto sbarcarono in Sardegna e andarono a fotografare, nei pressi delle Bocche di Bonifacio, Porto Pozzo, il porto dei Lestrigoni.
Il 20 agosto erano nei pressi di Napoli, a Pozzuoli presso i Ciclopi e nella “terra degli occhi tondi”. Il 26, al largo della penisola sorrentina, andarono a riconoscere, al largo della penisola sorrentina, l’arcipelago delle Sirene, le isole dei Galli. Boissonnas fu poi richiamato in Svizzera dagli obblighi della sua professione. Victor Bérard, desideroso di mettere in ordine i suoi appunti, trascorse tre settimane a Fiesole, dove aveva dato appuntamento alla moglie e ai figli.
Il 26 settembre i due viaggiatori furono a casa di Circe, dove ebbe termine la loro esplorazione fotografica, il 29 settembre a Pozzuoli e il 1° ottobre a Cuma.
Iniziò quindi, su una piccola barca a vela senza motore, la visita del “Regno delle Isole” e il tour del “Mare delle Isole”. Sull’Olive, più leggero di un “incrociatore omerico”, con un equipaggio di tre persone, viaggiarono da Corfù a Lefkada e Cefalonia; andarono a riconoscere e a fotografare di Itaca, i suoi promontori, le sue scogliere e le sue insenature, per poi ripetere il viaggio di Telemaco. Victor Bérard voleva “rivisitare questo mare di Ulisse col cattivo tempo che di solito segue l’equinozio e nei giorni meno belli dell’ultima parte dell’autunno”, e affrontare le burrasche che l'”eroe della resistenza” aveva sperimentato.
Da Patrasso un transatlantico della Compagnia austro-americana li portò a Messina il 30 ottobre; dal 1 al 7 novembre andarono a visitare Scilla, Cariddi, lo Stromboli ancora fumante, Lipari, le bocche di Vulcano dove individuarono le Planktes, lo “stretto delle Due Pietre”. Finalmente, “dopo tre giorni di tempeste ululanti, pioggia accecante, onde furiose, beccheggi e rollio di mare grosso” che costrinsero la nave postale in partenza da Palermo a cercare tutto il riparo che gli scali in Sicilia e negli isolotti vicini potevano offrire, approdarono a Tunisi, da dove partirono a Djerba per fotografare la terra dei Lotofagi, i mangiatori del frutto dell’oblio.
La durezza della ricerca, la gioia del successo si esprimono nei passaggi in cui Victor Bérard racconta come scoprì la grotta di Calipso, ai piedi delle Colonne d’Ercole, tra Ceuta e Tangeri, senza che lui e Boissonnas fossero stati minacciati dai ribelli Rifains.
«Come premio per la lunga fedeltà (ho iniziato lo studio dell’Odissea nel maggio 1888), Atena ha voluto darmi la felicità ineffabile di contemplare a piacere questa terra della ninfa… e di vivere in pace quest’ora di gioia intellettuale in cui Cammino, vivo, nel mio sogno omerico… Ci sono gioie inebrianti come i fumi più caldi della passione o dell’alcool. Ho sperimentato l’ebbrezza e, per così dire, il rapimento dello spirito su questo Capo degli Alberi Morti,
dove i miei occhi hanno verificato i miei ragionamenti e le mie ipotesi di venticinque anni: tutte le obiezioni sono cadute, tutte le difficoltà sono state appianate, sono penetrato fino all’ultima piega della descrizione omerica».
Le Navigazioni di Ulisse erano sia il commento di questo viaggio che la presentazione delle teorie odissee di Victor Bérard, l’Album ne era l’illustrazione.
Va detto qualcosa sul contesto e sulle condizioni in cui questi lavori sono stati eseguiti.
Alla fine del 1911, per lavorare in pace, mio padre si stabilì in una vecchia casa circondata da un giardino, ai margini dell’Osservatorio, di fronte all’infermeria Marie-Thérèse di Madame de Chateaubriand. Il quartiere allora era considerato eccentrico; il boulevard Raspail avrebbe raggiunto il Lion de Belfort solo pochi mesi dopo. La nostra famiglia vi abitò per più di cinquant’anni fino a quando la proprietà non fu espropriata dai Domaines a beneficio dell’Observatoire. Oggi possiamo sperare che, dopo lunghe difficoltà, lo spazio verde costituito da questo giardino possa essere salvato. Dai suoi anni di scavi, Victor Bérard conservò per tutta la vita l’abitudine di alzarsi all’alba o anche prima dell’alba, alle quattro e mezza o alle cinque del mattino. Dal suo ufficio vedeva il giorno sorgere dietro gli alberi dell’Osservatorio e l’affilato campanile di Saint-Joseph-de-Cluny. Nel silenzio della città addormentata ha lavorato alle sue traduzioni, alle identificazioni dei siti, ai suoi studi sulla vita mediterranea attraverso i secoli. Verso le 9 arrivò uno dei suoi studenti dell’Ecole des Hautes Etudes e, più tardi, quando fu entrato in Senato, il suo collaboratore René Langumier. Rimase con loro fino a mezzogiorno. Ai suoi occhi la sua giornata di studio era ormai finita: il suo pomeriggio era dedicato o a questioni di politica estera oppure, dal 1920, alla sua attività di senatore.
Quando, dopo la prima guerra mondiale, Victor Bérard pubblicò i tre volumi de L’Odyssée, Poésie homérique, in cui cercò di “fornire un’edizione critica e una traduzione in francese del XX secolo di questo testo tradizionale”, poi i tre volumi d’Introduzione, dove cercò di legittimare, una per una, le novità «della sua presentazione e traduzione», riportò la sua attenzione al «poema geografico» e volle avviare una nuova edizione dei Fenici e dell’Odissea. Ma, come egli stesso spiegò, le sue ricerche da riportare, le scoperte egee e cretesi da analizzare e discutere non consentivano più di racchiudere l’argomento del libro del 1902-1903 in due volumi, di formato ridotto. Sotto l’antico titolo raggruppò quindi «tutto ciò che riguarda i Fenici, le loro origini e i loro commerci nel Levante, riservando per una seconda parte il carattere, la famiglia, il regno e le avventure di Ulisse». Le storie dell’eroe della resistenza, dell’uomo dai mille inganni, furono oggetto dei quattro volumi delle Navigazioni di Ulisse: Itaca e la Grecia degli Achei, Penelope e i Baroni delle Isole, Calipso e il Mare di Atlantide, Nausicaa e il ritorno di Ulisse (1).
Les Navigations non sono solo un’opera di erudizione, la somma delle conoscenze di una vita sul Mediterraneo antico e moderno, ma il racconto di una personale esplorazione nello spazio e nel tempo, la ricostruzione del più famoso dei viaggi, l’evocazione dei luoghi più belli storia del mare, di una grande avventura avvenuta ottocento anni prima della nostra era. La pubblicazione dei quattro volumi terminò nel 1929. L’Album doveva essere, secondo Victor Bérard, il complemento necessario. La sua morte nel 1931 gli impedì di portare a termine la sua opera.
Archeologo come lui, il suo secondo figlio, Jean Bérard, lo completò. Sarebbe toccato a lui scrivere questo articolo oggi, avendo ereditato il pensiero di nostro padre e la sua vivace comprensione dell’antichità. Un incidente stradale lo ha strappato prematuramente al nostro affetto, al suo lavoro e all’Università.
La ripubblicazione delle Navigations d’Ulysse e dell’Album odysséen non riapre al lettore l’intera opera omerica di Victor Bérard, ma gli restituisce il vasto affresco del Mediterraneo eterno dipinto da colui che fu insieme ellenista e studioso, uno storico realista e un uomo che amava l’azione e ammirava lo spirito d’avventura.
4) RECENSIONE ELOGIATIVA DI VICTOR BERARD
LA GÉOGRAPHIE DE L’ODYSSÉE D’APRÈS L’OUVRAGE DE Mr V. BÉRARD ⇒
Annales de Géographie, 13e Année, No. 67 (15 janvier 1904), pp. 21-28 (10 pages)
traduzione in italiano di Gallura Tour
Nella bellissima opera che il signor Bérard ha appena terminato: I Fenici e l’Odissea, si trovano due tesi distinte anche se, nel pensiero dell’autore, strettamente collegate tra loro. La prima mira a stabilire l’origine fenicia dei dati su cui avrebbe lavorato l’autore dell’Odissea, prendendo in prestito i suoi argomenti principalmente dall’onomastica. Il signor Bérard si mostra fedele alle idee che lo hanno ispirato nel suo libro sull’origine dei culti arcadici, così come in numerosi studi che i nostri lettori non hanno perso di vista.
Ma contestualmente a questa provenienza, e a sostegno della dimostrazione che vuole fare, l’autore si propone di stabilire che da un’estremità all’altra del poema le scene dell’Odissea si svolgono in terre reali e non immaginarie. Per questo non si accontenta, come i suoi predecessori, di confrontare separatamente le espressioni del testo con le località in cui per ipotesi si trovano: cerca di ricostruire le condizioni generali che presiedevano, intorno all’epoca omerica, alle vie dei commerci, alle fasi di navigazione, nei siti di stabilimento. Secondo Bérard, c’è tutta una serie di questioni che possono essere chiarite reciprocamente alla luce del luogo. Usa perfino un nuovo nome, quello di topologia, per designare questo studio. Penso che basterebbe il vecchio nome di geografia. È infatti una geografia del mondo mediterraneo in epoca omerica quella che possiamo, secondo l’autore, trarre dall’Odissea.
È su questo terreno geografico che ci proponiamo di percorrerlo; sarebbe avventato da parte nostra avventurarci nell’altro. Il signor Bérard è un geografo e un viaggiatore che merita considerazione e fiducia.
In queste coste odissee del Mediterraneo, non si è forse spesso addentrato nelle baie e nelle insenature non frequentate dalle navi da crociera, dove si può arrivare solo con imbarcazioni che l’eroe di Omero avrebbe senza dubbio riconosciuto? Ne sono testimonianze le bellissime fotografie con cui è illustrato il libro.
Lungo le coste di Corfù e Itaca, della Sicilia e della Campania, passano vividamente davanti ai nostri occhi le stesse visioni che devono aver colpito i navigatori quando brancolavano tra i promontori e le isole, quando invece di tagliare dritto attraverso il mare oscuro, cercavano le tappe e piccoli rifugi.
A coloro che forse pensano che una controversia sulla veridicità delle descrizioni omeriche sia di scarso interesse per la geografia, vorrei far notare che in nessun luogo migliore di quello intorno al Mediterraneo possiamo abbracciare un lungo sviluppo della geografia umana. Qui si sono succeduti popoli e dominazioni; e ogni epoca ha, secondo l’espressione del signor Bérard, depositato i suoi fossili: santuari, città antiche come Astipalea, toponimi a volte tradotti, a volte distorti dalle generazioni successive. Non è la stessa distribuzione che, nei diversi periodi vagamente definibili con i nomi fenici, greci, veneziani, ecc., ha presieduto alla scelta dei siti, delle stazioni e dei vari insediamenti umani.
Anticamente, dice Tucidide, le città non venivano fondate nelle immediate vicinanze del mare; ai suoi tempi era il contrario. Per molto tempo, sulle rive del Mediterraneo, le popolazioni furono confinate su un terreno più elevato. Oggi assistiamo alla loro discesa e alla loro dispersione nelle pianure, almeno dove la malaria non ne rende impossibile la permanenza. Oggi i porti migliori sono quelli che si addentrano più nei golfi e spingono la loro penetrazione verso l’interno; Syra lascia il posto a Smirne. Ma è sempre stato lo stesso? La storia e l’archeologia dicono il contrario. Quanti nuovi orientamenti collegati al commercio, infine, possono incidere sul destino delle coste e delle città! Chi avrebbe detto, cinquant’anni fa, che Algeri sarebbe diventata una tappa popolare sulla rotta dall’Inghilterra all’India?
Pertanto, i vari periodi della vita storica del Mediterraneo corrispondono a condizioni diverse che si riflettono negli insediamenti umani. Ciascuno di questi periodi ha, in una certa misura, la sua carta delle poleis; e nelle alterne fortune di questa vita urbana si riflettono le condizioni generali del commercio. Se è dunque vero che i viaggi e gli errori di Ulisse si svolgono su uno sfondo reale, se i tempi e i luoghi non si confondono, da questo studio può emergere una lezione di geografia storica comparata. La guida che ci viene offerta per dipanare questi interrogativi va accolta favorevolmente; lui, come Ulisse, ha esperienza personale di luoghi e persone.
Gli antichi si dividevano in due scuole riguardo alla veridicità delle descrizioni dell’Odissea.
C’erano quelli che ritenevano che le finzioni omeriche contenessero una base essenziale della realtà. Questa era l’opinione di Ipparco, Polibio e Strabone.
“Costruire un’impalcatura di finzione su una base interamente immaginaria non è omerico”, ha detto con grande senso il geografo Strabone; e all’inizio della sua grande composizione non esitò a dare il posto d’onore a Omero.
Altri erano più scettici. Per Eratostene queste descrizioni omeriche potevano tutt’al più essere prese sul serio nell’ambito dei paesi ex ellenici; oltre a ciò era solo leggenda; e abbiamo ripetuto questa battuta del maestro: “L’isola potrebbe anche cercare l’operaio che ha cucito la pelle dei venti”.
Leake, Gell, Gandar, Schliemann e molti altri hanno molto discusso di Itaca; hanno identificato le principali scene della storia dell’Odissea.
Tuttavia, la critica moderna è stata generalmente sfavorevole all’opinione di Strabone; piuttosto, ha aggiunto alle negazioni di Eratostene. C’è soprattutto un autore contemporaneo che si è distinto per l’assoluta radicalità dei suoi giudizi. Per Rudolf Hercher, cercare di ritrovare attraverso le scene dell’Iliade e dell’Odissea i veri lineamenti della piana di Troia o dell’isola di Itaca, è pura allucinazione. Cosa pensare di più delle isole dei Feaci, di Eolo e Calipso, delle terre dei Lestigoni e dei Ciclopi? È senza dubbio appropriato fare lo stesso caso delle isole di Saint-Brandan, del paese di Gog e Magog sulle nostre mappe medievali, o delle isole e montagne dorate di Sindbad il marinaio. Questo è ciò che hanno giudicato molte menti sagge.
Questi giudizi ispirano però qualche perplessità. Le analogie tratte dalla fantasia araba o dalle meraviglie cristiane difficilmente soddisfano coloro che, nell’Odissea, apprezzano la logica e la naturalezza delle storie. Questo ricorso al mito e alla leggenda non è un modo semplice per condannare ciò che un esame più attento del testo e della sequenza delle cose spiegherebbe? Dobbiamo tenere conto del meraviglioso in un’opera di immaginazione; ma non c’è uno sfondo reale anche nei paesaggi animati e personificati dal genio del poeta?
Il signor Bérard ci fa rivivere le realtà omeriche. Passo dopo passo segue Telemaco nel suo viaggio da Itaca a Pilo, poi Ulisse nelle varie peregrinazioni che compongono il tema del nostos o ritorno. Il prodigioso non manca in queste avventure; osserviamo però che i fatti, per quanto spesso incredibili siano di per sé, non accadono come in un mondo di sogno attraversato da qualche nave fantasma. Navighiamo su barche “cave”, senza ponti, sormontate solo da una piattaforma a prua e un’altra a poppa: ogni oggetto ha il suo posto: manovre, gesti, incidenti si spiegano con la disposizione della nave. Per fuggire dall’isola di Calipso, Ulisse costruisce uno σχεδίη, tronchi squadrati; espressione che preferirei tradurre con chiatta piuttosto che con zattera. Esistono alcuni tipi di imbarcazioni rinomate; si tratta delle “navi veloci” utilizzate dai navigatori più esperti, come i Feaci.
Le partenze avvengono di notte. Dalla spiaggia dove erano state spinte, le barche furono rimesse a galla per proseguire a remi fino al promontorio vicino, da dove salpavano. Si tratta infatti, come indicano le Istruzioni di Regata, di sfruttare la brezza di terra fin dal momento in cui sorge, cioè due o tre ore dopo il tramonto. L’operazione, regolarmente ripetuta, presuppone che tra la spiaggia che serve da riparo e il punto da cui si salpa, la distanza non sia mai grande; si remava verso il tramonto.
L’aspetto delle coste è descritto come una serie di minute articolazioni in cui le punte sporgenti, gli isolotti, le piccole spiagge sabbiose occupano il primo piano; solo talvolta si notano sullo sfondo alte montagne boscose. Le cose, osserva il signor Bérard, si vedono dal mare. Per essere un abitante della terraferma, Itaca non merita l’epiteto di isola bassa; ma per i navigatori è davvero bassa, di fronte alla vicina isola alta, Samé (Cefalonia), dalla quale bisogna saperla distinguere. Certe somiglianze sembrano destinate a imprimere nella mente dei punti di riferimento: come la barca pietrificata sull’isolotto di Karavi, a nord di Corfù; come Capo Orso sulla costa settentrionale della Sardegna. Confrontate la nomenclatura immaginifica e dettagliata che marinai e pescatori creavano per il loro utilizzo sulle coste norvegesi o bretoni.
Le particolarità riscontrate sulla costa sono le grotte, che possono fungere da appostamento e nascondiglio, le sorgenti, le cascate: in una parola, le informazioni necessarie alla sicurezza oltre che alla sussistenza. Dall’interno conta soprattutto una cosa: gli indigeni sono benevoli o ostili? Ma anche nell’ipotesi più favorevole, i nostri navigatori faranno attenzione a non sprofondare nei golfi tortuosi, dove venti contrari potrebbero intrappolarli, come in una trappola per topi. Devono essere in grado, al minimo allarme, di allontanarsi; o altrimenti rendersi inespugnabili in un isolotto. Preziosi sono perciò i porti aperti a portata dei punti sporgenti, le giunture semi o del tutto distaccate dal continente: preferiremo per molto tempo Falera al Pireo, Calcedonia al Corno d’Oro. Alcune espressioni indicano che siamo consapevoli di questa capacità di conquistare luoghi favorevoli e che ne siamo orgogliosi: Ulisse parlando dei Ciclopi ai suoi ospiti Feaci fa notare che fuori dal loro porto si estende “un’isola piccola, né troppo lontana dalla terra”; ma questi selvaggi non pensavano di approfittarne1.
Le fotografie allegate fanno luce su queste particolarità della topografia omerica. La foto 1 rappresenta un isolotto della costa africana, che possiamo intuire mezzo avvolto tra le pieghe del continente: sarebbe, per il signor Bérard, il nascondiglio fenicio (Calypso), un posto azzeccato nei pressi delle Colonne d’Ercole. La foto 2 rappresenta la superba fila di montagne orientate W-E, che delimita la baia di Liapades, sulla costa occidentale di Corfù. Ai loro piedi sono ritagliati promontori e insenature, e le estremità di questi promontori, talvolta attaccati alla terraferma solo da un istmo depresso, sembrano fatti per sostenere una di queste città di navigatori dal doppio porto, come quella dei Feaci sotto il loro re Alcinoo.
Non c’è quindi solo un accordo intrinseco tra le storie e le descrizioni dell’Odissea in cui nulla è fuori posto; ma tanti dettagli che sembrano visti, colti sul momento. Più di una volta è nelle Istruzioni di Regata che trovano la loro spiegazione. Sono riconoscibili, ad esempio, gli effetti meteorologici dovuti ad alcuni venti: in particolare quelli da Sud-Est cupo e tempestoso. Siamo quindi portati a chiederci da dove possa provenire questa esperienza pratica. Il signor Bérard risponde dicendo che frammenti di viaggi sono entrati nella composizione dell’Odissea; e porta a sostegno di questa ipotesi tutta la duttilità di un’argomentazione ingegnosa, senza dimenticare i temperamenti e le sfumature di cui il sentimento non poteva mancare in uno studioso come lui.
In questa opinione c’è grande plausibilità. La poesia antica si è ispirata più volte a queste fonti. Non solo si può presumere che i viaggi abbiano fornito a Omero un tema su cui esercitare la sua immaginazione; ma è anche molto probabile che altri poeti lo abbiano fatto prima di lui, come altri lo hanno fatto in seguito.
Una volta accettata l’idea del documento geografico, quale potrebbe essere la data? I poemi omerici ci appaiono nell’indeterminatezza di un’antichità remota; ma non siamo forse ingannati da nubi che noi stessi assembliamo? I greci del periodo classico non avevano l’idea di risalire a una data molto antica.
Erodoto, vissuto nel V secolo [avanti Cristo], afferma che i poemi di Omero furono composti circa quattrocento anni prima. Questo è all’incirca il periodo a cui ci porterebbero le informazioni che possono essere estratte dai documenti utilizzati nella composizione dell’Odissea. Si riferirebbero ad un’epoca in cui, secondo l’esplicita testimonianza di Strabone, i Fenici avevano già spinto le loro spedizioni marittime fino alle estremità occidentali del Mediterraneo. Ma d’altra parte i dati del poema indicano, come vedremo, una situazione sociale chiaramente precedente alla colonizzazione ellenica, che non iniziò prima dell’VIII secolo.
Una vita attiva fermenta lungo le coste del Mediterraneo. Intorno agli stretti o ai grandi promontori che condividono i venti, sulle rive dove abbonda la conchiglia purpurea, non c’è quasi un punto o un isolotto dall’articolazione favorevole che non sia stato oggetto dell’attenzione dei navigatori, di una occupazione temporanea o permanente. Queste stazioni sono numerose, come si addice alle navi che seguono le coste a tentoni e che aspettano il momento giusto per lanciarsi in mare aperto. Non è raro che le navi siano costrette a farvi lunghi soggiorni perché a volte passano mesi o settimane prima che i venti contrari si calmino e i temuti passaggi diventino praticabili.
I corsari che nei secoli XVII e XVIII perlustrarono l’arcipelago, crearono così dei “luoghi di sosta” dove stazionarono per lungo tempo, dove dimenticarono, se non la patria a cui difficilmente pensavano, almeno gli interessi dei loro protettori o armatori. Là si mangiava bene, come presso i Feaci.
Il signor Bérard ha fatto ampio uso dei divertenti racconti in cui Thévenot, Paul Lucas e altri descrivono questa vita avventurosa, molti dei quali ricordano la vita omerica del Mediterraneo. Più di un bambino Eumeo fu rapito così, con la sua ancella e i tesori rubati alla famiglia, da questi marinai, cristiani o barbareschi!
Ma dobbiamo dare la colpa ai Fenici per tutto quello che ci viene raccontato sulle imprese di questi commercianti o avventurieri del mare?
Sicuramente più di un gruppo di “professionisti” si era formato da solo o presso la propria scuola. I Cari, i Feaci, i Tafi, tra gli altri, di cui indubbiamente è anche difficile definire l’origine, ci sembrano svolgere il loro ruolo separatamente, nei vari compartimenti più o meno separati di cui è composto il bacino del Mediterraneo.
Trovo difficile credere in una vera talassocrazia che si estenda da un capo all’altro di questo mare.
Comprendiamo che questi rapporti commerciali sono regolati da una giusta diffidenza reciproca. Se i navigatori esitano ad addentrarsi nei golfi profondi, i marinai terrestri non sono meno riluttanti a stabilirsi troppo vicino alle coste. Si confinano in alto, a distanza; la spiaggia o la marina sono il luogo neutrale dove avvengono gli scambi, il bazar improvvisato dove vengono esposti oggetti che possono stuzzicare la curiosità femminile. Il tipo della città omerica è la città alta ([…]). L’emporio marittimo, come dovevano rappresentare Mileto, Corinto, Pireo, non esiste ancora; lo stesso Tucidide lo aveva sottolineato.
Tuttavia, nell’antica Grecia nel Mediterraneo esistevano città dove si potevano acquistare prodotti lussuosi provenienti da fuori e beni preziosi da lontano. Queste città non erano marittime, ma occupavano una sorta di posizione intermedia tra quella marittima e quella continentale. Non è certo un caso che città di antica fama, di cui oggi viene riportato alla luce lo splendore, Ilio, Micene, come anche Tebe di Cadmo, si trovino verso il centro di un istmo, tra due golfi o mari che corrispondono tra loro. Ilio domina il passaggio più breve tra il golfo di Adramitta e la Propontide, come Tebe la rotta tra il golfo di Atlante e quello di Corinto, come Micene sorveglia la via più diretta che la collega a Nauplia.
Per mostrare come questa importanza fosse legata alle inveterate abitudini della navigazione antica, il signor Bérard sottolinea giustamente che molto tempo dopo, al tempo della guerra del Peloponneso, era ancora via terra che Atene comunicava con l’Eubea. La conquista di Decelea, situata a metà dell’istmo attico, minacciò di recidere questi rapporti.
A ovest del mondo civilizzato esiste un mondo barbaro, la cui peculiarità appare chiaramente nell’Odissea. Essa è espressa da un criterio, il tipo di cibo. I civilizzati sono “i mangiatori di farina”. Saremmo lieti di aggiungere un accenno di localismo a quelli che l’autore ha già citato. Cefalonia, la parte principale del regno di Ulisse, godeva della proverbiale fertilità dell’orzo e del grano, come testimoniano le monete. Per i navigatori di queste isole, i mangiatori di frutta (lotofagi) e soprattutto i mangiatori di carne sembravano esseri estranei a tutte le convenzioni e abitudini acquisite. Questo modo di distinguersi non è meno naturale, osserva Bérard, di quello di distinguersi attraverso il linguaggio. — Abbiamo d’altronde perso ogni abitudine a questo criterio e non potremmo, tra i popoli d’Europa, citare ancora altri esempi?
Fu soprattutto il mondo pastorale e selvaggio che i coloni greci avrebbero incontrato più tardi in Sicilia, Campania e Sardegna, a suscitare un misto di avversione e terrore. Questi Ciclopi, questi Lestrigoni appaiono come esseri semifantastici. Dalle fattezze con cui viene raffigurato, Polifemo è sia una montagna che un uomo. L’occhio rotondo del Ciclope rappresenta forse, nell’immaginario antropomorfo del poeta, i crateri che imprimono un aspetto così strano ai Campi Flegrei.
Paesaggi bizzarri ed esseri singolari non sono che la stessa cosa, incarnati l’uno nell’altro. Tale fu senza dubbio la prima impressione prodotta sulle popolazioni civili dell’epoca da questo mondo di montanari e di pastori, che è l’elemento ostile e mai del tutto domato dei paesi mediterranei; il τό μάχιμον di cui parla Strabone, pensando agli sforzi che la sua subordinazione era costata alla colonizzazione greca e alla stessa potenza romana.
Chi pensa che il significato delle realtà viventi sia essenziale per l’interpretazione del passato troverà piacere e beneficio nell’opera che abbiamo appena analizzato troppo brevemente. Non sarebbe giusto nei suoi confronti elogiare solo l’ampiezza delle informazioni e la ricchezza dei punti di vista, e un’ingegnosità che seduce proprio laddove, eccezionalmente, non riesce a convincere del tutto. Credo che questo libro possa esercitare una buona influenza sull’esegesi omerica, tirandola fuori dai sentieri dove spesso si smarrisce. Le cose greche non dovrebbero essere giudicate da un punto di vista astratto e idealistico. Il signor Bérard dichiara in più punti di essere tra i “più omerici”; con ciò vuol dire che le espressioni, gli epiteti, le immagini dell’Odissea si applicano a cose realmente viste e praticate.
Si può notare che in molte delle sue opinioni non fa altro che riprendere quelle che gli antichi avevano già sostenuto e che alcuni moderni avevano erroneamente scartato. Questo perché, attraverso il sentimento diretto dei luoghi e degli uomini, egli si avvicina più di questi moderni allo stato d’animo che i Greci stessi portavano nei loro giudizi e nelle loro opere
La critica erudita che noi applichiamo a questi testi antichi è probabilmente sbagliata nel disprezzo che mostra per questo modo di interpretare apparentemente terra-a-terra. Il quadro in cui il poema prende forma non perde nulla quando viene illuminato da realtà vive. Assume così qualcosa della precisione e delle linee fisse che il genio greco metteva in ogni cosa; senza dubbio Atena si riconoscerebbe meglio in essa.
5) RECENSIONI IN ITALIA DI LES PHÉNICIENS ET L’ODYSSÉE di VICTOR BÉRARD
♦ Al secondo volume 1904, di Giacomo Tropea ⇒
6) LE TESI DI VICTOR BERARD ANCORA OGGI OGGETTO DI STUDI E DIBATTITO
6.1) Per una geografia arbitraria: un modesto contributo alla geografia odissea
di Sophie Rabau
2022
traduzione di Gallura Tour
Quando ci troviamo a Saint-Denis, comune situato nel dipartimento della Senna-Saint-Denis, siamo anche a nord della strada che da Cariddi e Scilla conduce all’isola di Calipso, a sud-ovest, quindi, dell’isola dei Lestrigoni, a sua volta situata tra la città di Stains e la città di Dugny. E trovandoci in questo luogo, percorriamo anche la strada che conduce Gavroche dalla via degli Archivi, dove incontra Javert, alla chiesa di Saint Merri. Come dimostrano queste poche affermazioni, di cui alcuni scontenti potrebbero deplorare l’inesattezza, la mia conoscenza della geografia è quantomeno approssimativa e, per dirla senza mezzi termini, abbastanza recente. A questo primo difetto devo aggiungere un secondo difetto: dotato di animo irrequieto, ho poca esperienza nelle discipline intellettuali più elementari. Mi viene chiesto di immaginare cosa possono fare le scienze umane con l’Odissea? Qui mi impegno a considerare cosa possono fare gli specialisti dell’Odissea con una scienza umana, in questo caso la geografia. Qui comincio ad esplorare non le modificazioni che l’Odissea può subire vista attraverso la geografia, ma la geografia vista dall’Odissea. Tanto vale ammetterlo, questo articolo inizia decisamente male…
Per salvarmi dall’accusa di impostura, non ho che un mezzo, o meglio una sola guida: un ellenista riconosciuto, anche un uomo politico, lo specialista del suo tempo di Omero e dell’Odissea. Si chiamava Victor Bérard, nacque nel 1864, morì nel 1931. Ma più dell’archeologia, più della storia o della filologia, questo grande studioso amava la geografia che insegnava e che lo guidò per tutta la sua carriera.
Louis Robert scrisse di lui nel 1973: «L’intimo legame che, per tutta la sua vita, unì gli studi ellenici e la politica contemporanea fu la geografia. È il filo rosso della ricca trama.» A cui potremmo aggiungere che Victor Bérard deve parte della sua notorietà alla geografia: della sua opera i posteri hanno conservato principalmente la lettura geografica che ha dato dell’Odissea. Desideroso di situare nello spazio reale del Mediterraneo il mitico viaggio di Ulisse, seppe impegnarsi personalmente e partì lui stesso “sulla scia di Ulisse” in compagnia del fotografo Fred Boissonas; da questa spedizione trasse un album fotografico dei luoghi che identificò come odissei. Meno si sa che nei sei volumi di circa quattrocento pagine ciascuno che costituiscono la base di questa spedizione, è come geografo e attraverso la geografia che V. Bérard legge l’Odissea e ne applica i racconti al mondo³.
Questo perché l’epopea omerica è, secondo V. Bérard, la trascrizione dei viaggi compiuti nel Mediterraneo dai Fenici, popolo di marinai per eccellenza. Omero avrebbe conosciuto e si sarebbe ispirato alle istruzioni nautiche fenicie, viaggi che descrivevano le principali rotte marittime. Per cui l’Odissea è «un documento geografico, la pittura poetica ma non distorta» del Mediterraneo fenicio. Questa visione delle cose non mancò di suscitare reazioni a dir poco negative.
L’ellenista André Bonnard evocò, già nel 1937, una “geografia fantastica”: il testo di Omero è mitico e non può in alcun modo sostenere un approccio geografico scientifico, senza dimenticare che l’esistenza dei viaggi fenici è puramente ipotetica. Ma queste apparenti debolezze e questa metodologia un po’ troppo fantasiosa possono presto diventare titoli di gloria, purché si accetti di vedere in V. Bérard un precursore del postmodernismo, pronto a far interagire il testo e il mondo, abile nell’inventare il Mediterraneo. Avrebbe detto in anticipo, a modo suo e senza dubbio senza volerlo, che il mondo è fatto anche dalle sue rappresentazioni, anche se mitiche, cosa che oggi è ampiamente ammessa non solo dai geografi, in particolare dagli specialisti dell’antichità geografia, ma anche letterati appassionati di “geocriticismo”.
V. Bérard forse ha fatto di più e senza dubbio è andato anche oltre questi sostenitori dell’immaginazione geografica. Perché scuote, ancora una volta involontariamente, uno dei presupposti su cui si fonda l’approccio geografico più incline all’immaginazione e alla geocritica più postmoderna. Tutte queste discipline aperte al sogno dello spazio concordano su un punto che nessuno si sogna di rimettere in discussione: il legame tra un luogo e la sua rappresentazione è sempre motivato o da un’identità – è la stessa città, Istanbul, ad essere oggetto delle nostre percezioni empiriche e dei sogni di Loti – o, quantomeno, da una somiglianza – è in nome di un’analogia che Proust usa l’immaginario di Baghdad per descrivere la Parigi di Charlus. Ma non so se qualcuno abbia proposto di utilizzare le descrizioni di Istanbul di Pierre Loti per arricchire, ad esempio, l’immaginazione di Chicago. Non conosco nessuno studio che dimostri come la rappresentazione omerica di Itaca possa contribuire alla descrizione di un’altra isola, ad esempio Manhattan. L’operazione sembrerebbe a dir poco arbitraria…
Una geografia arbitraria è proprio ciò a cui conduce la geografia di Bérard applicata all’Odissea, una geografia in cui il legame tra il testo e il luogo che esso permette di “inventare”, o addirittura generare, non è in alcun modo motivato da una preesistente relazione. Perché il metodo di Victor Bérard ha l’effetto paradossale di rendere l’Odissea adatta a qualsiasi descrizione di luogo, indipendentemente dal legame che può esistere tra questo luogo e l’epopea omerica. V. Bérard ha esplorato il Mediterraneo. Vorrei seguire le sue orme per esplorare l’idea di una geografia arbitraria, e cercare così di arricchire il mondo attraverso l’immaginazione omerica.
Le mie prime osservazioni sul carattere odisseo del comune di Saint-Denis testimoniano i notevoli risultati che questo nuovo ramo della scienza geografica può produrre. Mi resta da spiegare più chiaramente le condizioni delle possibilità, dei metodi e delle applicazioni.
La geografia odissea di Bérard chiarisce i gesti fondamentali della geografia arbitraria: sovrapposizione, imposizione, riconoscimento. È da questi tre gesti che trarremo le basi generali della geografia arbitraria, che mi daranno l’opportunità di presentare più in dettaglio la mia nuova geografia di Seine-Saint-Denis. È risaputo che tutta la scienza ha valore solo attraverso le sue applicazioni pratiche, e alla fine tracceremo i contorni di una geografia applicata arbitraria.
LA GEOGRAFIA SECONDO BÉRARD
Superposizioni
Il primo gesto di V. Bérard è abbastanza ben documentato dai geografi, anche se l’ellenista lo usa in modo un po’ sistematico e esagerato: si tratta di riunire, o addirittura sovrapporre su una stessa carta, strati eterogenei dal punto di vista temporale, culturale o ontologico. È per rispondere ad un problema metodologico che lo studioso inventò e praticò questo gesto. Partendo dal postulato sopra detto – Omero descrive il Mediterraneo a partire dai viaggi dei Fenici – egli interpreta il testo omerico in modo tale da trovarvi due tipi di indicazioni. Innanzitutto indicazioni su un orientamento del viaggio odisseo: in questo caso si tratta di un viaggio verso l’Occidente, dall’Oriente verso l’Occidente, che egli cerca di scoprire. Segni, poi, di una localizzazione più precisa che scopre o decifrando quelli che ritiene simboli – il Ciclope è infatti un vulcano – oppure indulgendo in etimologie più o meno azzardate che gli fanno associare i nomi odisseici a toponimi.
Combinando queste operazioni con i luoghi tradizionali del viaggio di Ulisse, riesce a mappare i suoi viaggi.
Ma quando V. Bérard arriva sul campo, è costretto a constatare che ciò che scopre non corrisponde al “documento geografico” che è l’Odissea: deve completare ciò che vede. La sua scienza geografica viene allora in soccorso del suo metodo in pericolo.
Lo studioso fa appello alla topologia, la cui idea ha trovato in Gustav Hirschfeld e di cui si appropria, addirittura distorce un po’. Vista da Victor Bérard, la topologia consiste in uno studio ragionato dei siti: in condizioni geografiche comparabili, si applicano le stesse leggi invariabili. Un porto di estuario opera secondo le stesse leggi nell’800 aC, nel XVI secolo e nel XX secolo, in Africa, Australia o Europa.
La topologia deve quindi essere contrapposta alla topografia descrittiva che fornisce un semplice resoconto della realtà e non si basa su leggi geografiche invarianti valide in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Per cui, su un asse diacronico, Bérard è sensibile alle permanenze al di là delle differenze apparenti: una volta che si trova in un luogo omerico, ciò che vede è considerato riprodurre ciò che videro i Fenici, a cui Omero si ispira nell’Odissea; l’esploratore si trova contemporaneamente sia presso Circe all’epoca dei viaggi fenici, sia nella regione del Monte Circeo all’inizio del XX secolo.
Ecco un primo modo di risolvere il problema di una possibile discrepanza tra il luogo scoperto da V. Bérard e il testo omerico. V. Bérard vede ciò che hanno descritto i Fenici e quindi è Omero ad avere torto se la sua descrizione è “inesatta”: il poeta avrà frainteso il viaggio da cui trae ispirazione.
La seconda conseguenza dell’approccio topologico, su un asse transculturale, è che quando il luogo non somiglia abbastanza a ciò che dovrebbe essere, o viceversa, quando Omero manca di precisione, basta confrontare il sito con siti simili, presi in varie epoche e in varie regioni, per dedurre diversi tratti della sua geografia.
Così, è possibile per lo studioso correggere il testo omerico grazie alla sua visione diretta di un paesaggio ritenuto immutato nei suoi tratti essenziali.
Gli è anche possibile correggere il mondo che scopre cercando in altri luoghi, ritenuti obbedienti alle stesse leggi, gli elementi omerici che non vi trova. Passeggiando così nel Lazio, in quella che pensa essere la regione di Circe, e faticando a trovare i leoni e i lupi che, secondo Omero, circondano la casa della maga, non esita a trovare questi animali in luoghi da lui ritenuti comparabili, situati, per esempio, in Siria o in Messico. Questa concezione della topologia autorizza in Bérard due gesti di sovrapposizione.
Una sovrapposizione diacronica, innanzitutto: una fotografia scattata nel 1910 può perfettamente essere etichettata come la «foresta di Circe» e una carta nautica del Golfo di Napoli risalente all’inizio del XX secolo può avere come titolo «Le sirene». Non ci si sorprenderà, quindi, se le mappe ispirate da V. Bérard portano generalmente sia il nome geografico che il nome omerico: Gibilterra (Calipso), per esempio, o Calipso (Gibilterra).
La sovrapposizione diacronica va spesso di pari passo con una sovrapposizione spaziale: poiché i luoghi obbediscono a leggi comuni, basta parlare di uno spazio o di una pratica conosciuti per evocare ciò che ignoriamo: la nostra conoscenza storico-geografica sulla talassocrazia britannica è quindi una fonte diretta di conoscenza sulla talassocrazia fenicia. Si trovano comunemente, negli scritti di Bérard, formule come «gli Inglesi della Fenicia».
Nelle osservazioni di V. Bérard emerge dunque una mappa mentale dove sulla Fenicia si indicherebbe tra parentesi “(Inghilterra)” e sull’Inghilterra, viceversa, “(Fenicia)”. Allo stesso modo, i nomi di Tahiti e del Messico dovrebbero essere riportati sulla mappa del Monte Circeo, nel Lazio, dove, secondo V. Bérard, si trova la residenza di Circe. In tutti questi luoghi si trovano anche usanze comparabili. Non che V. Bérard stia inventando un metodo del tutto nuovo: gli storici geografici segnalano numerose pratiche cartografiche in cui le epoche coesistono, mentre i luoghi mitici convivono con luoghi percepiti come più reali. Il metodo di V. Bérard si riferisce a queste pratiche, ma lo studioso è per il resto radicale: non si tratta solo di prossimità, ma di sovrapposizione. In certi punti della mappa, e potenzialmente in ciascuno dei suoi punti, si incontrano contemporaneamente più luoghi e più tempi, anche diversi livelli di realtà, almeno se si ammette che l’Odissea è una finzione.
Qui si inizia a comprendere meglio come Saint-Denis non sia poi così distante dall’isola dei Ciclopi e come io mi permetta di sovrapporre la mappa dei viaggi di Ulisse a quella di Seine-Saint-Denis. Nessuna regola topologica, tuttavia, permette di proporre una analogia certa tra l’Île-de-France e il Mediterraneo. E si può scommettere che neanche Victor Bérard avrebbe osato un tale avvicinamento.
Tuttavia, ha aperto la strada a questo colpo di forza. Se il metodo topologico si basa ancora su un metodo analogico, esiste nell’approccio di V. Bérard un gesto molto più arbitrario, che chiamerò l’imposizione del tragitto odisseo.
Imposizioni
Il viaggio di Ulisse permette di descrivere qualsiasi luogo nel mondo e si possono imporre le erranze del figlio di Laerte a qualsiasi parte della mappa del mondo. Questa imposizione arbitraria è resa possibile dall’incontro tra un tratto del testo odisseo e la lettura geografica fornita da V. Bérard. Da una parte, si può parlare di un effetto geografico dell’Odissea, come si parla di un effetto della realtà. Poiché questo racconto di viaggio non è affatto chiuso alle preoccupazioni geografiche. Prima che Ulisse doppi il Capo Malea e si perda in un mondo meraviglioso, vengono menzionate terre geografiche conosciute. Anche in questo mondo magico, il bisogno di orientamento è abbastanza ricorrente. Appena Ulisse arriva da Circe, la cui isola è situata a Levante, sale su una collina per cercare, anche se senza successo, di orientarsi con il sole. In generale, nel testo sono indicate direzioni cardinali. Più in generale, nell’epopea non mancano preoccupazioni di geografia umana, economica o fisica, nemmeno tra gli dèi dell’Olimpo, se si considerano queste parole di Atena riguardo a Itaca:
“Sì, quest’isola è rocciosa e poco adatta ai cavalli. Ma né troppo misera né troppo vasta, Vi si trova grano in abbondanza, buon vino. La pioggia non manca, né la rugiada che arricchisce. Terra di capre e di mucche, le foreste sono di ogni tipo, e gli abbeveratoi sempre pieni.”
L’Odissea sembra invitare a una lettura geografica sia in termini di luogo che di descrizione.
Ma questo è solo un effetto geografico che gli specialisti concordano debba essere visto come ingannevole.
Ci basta ricordare che Itaca, nell’Odissea, è piatta mentre l’Itaca geografica è montuosa e aggiungere con Alain Ballabriga che lo spazio meraviglioso è un «accostamento di luoghi inaccessibili che nessun itinerario consapevole permette di collegare» e «non uno spazio geografico governato da una logica cartografica».
L’Odissea dà l’impressione di descrivere uno spazio, ma questo spazio non può essere realmente localizzato e non può essere tracciato su una mappa. O meglio, ogni descrizione dell’Odissea potrebbe essere adatta a più luoghi, come nel caso della descrizione di Itaca: la descrizione è attuale nel senso letterario del termine e potrebbe adattarsi a molte isole del Mediterraneo o altrove.
È così che V. Bérard impone il suo schema orientato sulla mappa del Mediterraneo. Abbiamo allora l’illusione di una geografia dell’Odissea: il testo sembra indicare un percorso preciso in un mondo determinato. Ma dal testo possiamo ricavare, leggendolo, solo un diagramma orientato e non una carta geografica. Nelle questioni odissee, la mappa di base e il diagramma sono quindi cose separate, come dimostra la presentazione dei viaggi di Ulisse da parte di Gabriel Germain: il diagramma vi appare indipendentemente dalla carta geografica che è essa stessa discutibile.
L’indipendenza tra la mappa e il diagramma rende l’Odissea un testo disponibile per descrivere qualsiasi mondo: basta cogliere il diagramma orientato e imporlo su un’altra mappa in un altro luogo. Questa non è pura teoria.
Ce ne convinceremo osservando le varie regioni del mondo in cui si è già compiuto il viaggio di Ulisse: oltre al Mar Mediterraneo, non abbiamo già proiettato il percorso delle sue peregrinazioni sulla carta del Baltico, dell’Atlantico, e dell’Islanda? “E così via” si potrebbe aggiungere.
Ma questo seguito è già stato ripreso da uno scrittore irlandese. James Joyce non procede diversamente dagli altri geografi odissei, quando applica alla città di Dublino lo schema dei viaggi di Ulisse secondo V. Bérard. Attraverso il metodo di Bérard, l’Odissea diventa una matrice applicabile a qualsiasi mondo, e su qualsiasi scala, dall’universo fino, perché no, alla mia camera da letto. In geografia, secondo V. Bérard, ogni mondo può essere Odisseo, il che non è poi così male…
Ma forse sto esagerando. Dopotutto, V. Bérard giustifica le sue ipotesi con un’esplorazione di luoghi che l’imposizione del suo itinerario gli permette di identificare e che riconosce in tutti i sensi del termine. Ma questo gesto di riconoscimento, anch’esso arbitrario, è un altro modo di imporre l’Odissea alla realtà.
RICONOSCIMENTO
Quando V. Bérard riconosce il testo omerico sul campo, impone ancora al luogo un carattere odisseo attraverso un meccanismo molto particolare. Lo scienziato infatti riconosce solo una serie di tratti rilevanti, ignorando le differenze. Questa astrazione delle differenze si basa innanzitutto su un appello alla magia della topologia: ciò che non vediamo lo troviamo altrove, nella descrizione di un altro luogo comparabile. Risulta anche, come hanno dimostrato Sophie Lécole Solnychkine e Laury-Nuria André16, da una confusione tra la struttura del paesaggio e la sua realtà: è, ad esempio, abbastanza facile trovare in vari luoghi del Mediterraneo la struttura che emerge dalla descrizione di Itaca data dalla dea Atena.
In diversi luoghi del Mediterraneo, ma anche nel mondo: l’autore della notevole opera intitolata Omero nel Baltico, riconobbe senza particolari difficoltà i luoghi odisseatici del Nord Europa. Il riconoscimento può quindi essere descritto come un’operazione di rimotivazione del legame arbitrariamente costruito tra il testo e il mondo. Arbitrario, consente tuttavia di assegnare un luogo singolare a una descrizione d’attualità, di “singolarizzare il topos” secondo la formula di Sophie Lécole Solnychkine e Laury-Nuria André. Potrebbero essere molti posti, ma diventa questo posto.
Ma l’imposizione dello schema e il riconoscimento come rimotivazione arbitraria contribuiscono evidentemente ad un arricchimento del mondo che si ritrova carico nella sua realtà dell’immaginazione odissea: grazie a Victor Bérard, un giorno andrò nella regione del Monte Circeo e penserò a Circe; grazie a Bérard, non posso visitare Corfù senza pensare ai Feaci: guide e tradizioni locali dell’isola segnalano al turista dell’Odissea uno scoglio pietrificato, in realtà una nave dei Feaci trasformata da Poseidone per punire questo popolo la cui Odissea ci dice certamente che egli accolse Ulisse, ma in nessun caso visse a Corfù.
PER UNA GEOGRAFIA ARBITRARIA
Ispirata al metodo berardiano, la geografia arbitraria è ancora agli inizi. Il suo sviluppo è un po’ ostacolato dalla mia incompetenza in geografia e cartografia, tanto che posso qui solo presentarne i fondamenti, piena di speranza che geografi più competenti di me possano aiutarmi nel suo necessario sviluppo. Ogni scienza ha i suoi goffi ma eroici pionieri… Vedremo in seguito che avrei davvero bisogno di aiuto in termini di scala, di progettazione grafica e che trarrei sicuramente beneficio nel chiarire il mio vocabolario tecnico. Tuttavia si sarà capito il principio di questa nuova branca della geografia: si tratta di prendere uno schema orientato, disponibile nel senso da me indicato, e di applicarlo arbitrariamente a carte e piani diversi, dal piano dell’ufficio dove sto scrivendo queste righe alla mappa degli Stati Uniti o del mondo, compresa quella di Seine-Saint-Denis.
Anche se V. Bérard e i suoi epigoni del Mar Baltico o dell’Atlantico hanno aperto la strada a questo arricchimento del mondo, James Joyce è, a mia conoscenza, l’unico ad aver proceduto in questo modo in modo deliberato quando applica il Viaggio odisseo orientato alla mappa di Dublino. Ecco perché resta ancora molto da fare da parte di tutti coloro che posso convincere a praticare la geografia arbitraria. Per incoraggiarli in questa direzione ho effettuato alcune operazioni geograficamente arbitrarie, i cui risultati possono essere esaminati nelle carte VIII e IX.
Dall’applicazione del viaggio dell’Odissea alla mappa degli Stati Uniti d’America, emerge che Circe vive in Minnesota, e che per incontrare i Lotofagi dobbiamo andare in Texas. Ma l’imposizione della rotta è solo il primo momento del metodo geograficamente arbitrario. In secondo luogo, è opportuno continuare ad applicare il metodo di Bérard, impegnandosi, attraverso il riconoscimento, nella motivazione a posteriori dell’arbitrario. Questa motivazione arbitraria contribuisce evidentemente ad arricchire la nostra rappresentazione del mondo, a infondervi nuovi miti e nuove storie. E poiché nulla è più importante che aggiungere l’essere, anche mitico o immaginario, al mondo, descriverò ora in dettaglio i principali percorsi a disposizione del ricercatore che desideri praticare questa modalità di riconoscimento. Il riconoscimento schematico delle caratteristiche notevoli resta il metodo regina in questa materia: è così che il caldo tropicale del Texas si sposa benissimo con la coltivazione del fiore di Lotos, mentre nel Minnesota dove vive Circe ricorderemo ovviamente che la pratica dell’allevamento dei suini è una delle sue principali risorse. Inoltre, è stato in una cittadina del Minnesota, Rochester, che Agnes Moorehead, memorabile interprete di Endora in My Beloved Witch, ha posto fine alla sua vita, prova, se ce ne fosse ancora bisogno, che la regione è decisamente una terra di streghe.
Se l’identificazione dei tratti comuni non è sufficiente, non dobbiamo esitare a integrarla con un racconto arbitrario: dobbiamo mostrare un po’ di fantasia e spiegare la collocazione arbitraria inventando una narrazione eziologica. Noto a questo proposito che sulla mappa della Seine-Saint-Denis il percorso di Ulisse trascura attentamente non solo la cittadina di Saint-Denis dove mi reco qualche volta, ma anche la cittadina di Neuilly-Plaisance dove risiedo. Solo la storia inventata del rapporto difficile che ho sempre avuto con il figlio di Laerte potrebbe spiegare perché mi evita in questo modo. In modo meno egocentrico, è urgente che io forgi al più presto le cause del tropismo spagnolo di Calipso. Che lei viva a Gibilterra sulla mappa del Mediterraneo va ancora bene… Ma che si ritrovi al confine del Messico quando imponiamo il viaggio dell’Odissea sulla mappa degli Stati Uniti, non può essere una coincidenza, e merita sicuramente alcune spiegazioni . Se all’arte del racconto preferiamo l’ermeneutica, possiamo ancora giustificare incontri arbitrari con la pratica della lettura allegorica o in chiave – praticata non poche volte da Bérard, che vede nel ciclope il simbolo di un vulcano o nella figura di Circe la personalizzazione di un’isola.
Così un geografo arbitrario e appassionato di novità socio-politiche vorrà spiegare il legame allegorico che può unire Cariddi e Scilla e i comuni di Pavillon-sous-bois e Clichy-sous-bois. Queste operazioni, il cui elenco non è esaustivo, permettono già di arricchire la realtà. Da oggi la città di Saint-Denis è anche il luogo che Ulisse evitò nei suoi viaggi, né più né meno di quanto l’isola di Itaca, nel Mar Ionio, sia il luogo dove egli nacque. Al di là di queste operazioni fondamentali, l’imposizione in stile Bérard dello schema odissea apre altre due strade alla geografia arbitraria. Innanzitutto possiamo estendere il metodo a testi diversi dall’Odissea. Se l’epica di Omero viene manipolata da V. Bérard per estrarne un diagramma orientato, la stessa operazione non è forse possibile per qualsiasi testo che racconti un viaggio in un luogo geografico e/o mitico e proceda dallo stesso effetto pseudo-geografico dell’Odissea? Nulla ci impedisce di iniziare a costruire una biblioteca di testi matriciali per la geografia arbitraria. Qualche anno fa, il museo Carnavalet ha pubblicato il viaggio compiuto nel Marais dai personaggi di Les Misérables.
La tentazione di eliminare questo itinerario dalla mappa del Marais e di imporlo ad altri luoghi è molto forte. Tanto più allettante, infatti, perché questa imposizione può riportarci al primo gesto di Bérard che finora abbiamo poco sfruttato: la sovrapposizione, che per essere giustificata dalle leggi della topologia, non appare meno in qualche modo arbitraria. Ma nulla ci impedisce di rendere ancora più arbitrario e di attenerci al metodo di Bérard che un luogo sulla carta può essere designato da due toponimi molto eterogenei. Praticheremo una via di ipertestualità geoletteraria, sovrapponendo ad esempio il viaggio di Gavroche al viaggio di Ulisse. Resterà quindi solo da notare gli inquietanti incontri geografici che sicuramente deriveranno da questa nuova operazione. Possiamo complicare ulteriormente l’operazione, e quindi arricchirla: invece di sovrapporre i due schemi senza alcuna carta di supporto, possiamo decidere che ad una delle carte tradizionalmente associate ad un percorso venga imposto un altro percorso. Proietteremo il viaggio di Ulisse nella Parigi dei Miserabili. Possiamo ancora far incontrare due o più percorsi su una carta geografica preesistente. Avendo effettuato l’esperimento per Seine-Saint-Denis, dove ho riunito l’itinerario di Gavroche e quello di Ulisse, posso ora affermare che se Ulisse non si ferma a Saint-Denis, Gavroche, meno orgoglioso, non disdegna per muovere i suoi passi lì. Ricorderemo anche che Ulisse incontra Javert sul Quai des Ormes, tra i Lotofagi, e ne trarremo le opportune conclusioni.
Forse vedremo qualche eccentricità in questi progetti. Ma sistematizzano solo pratiche ben documentate. Bertrand Westphal ricorda che nel XVI secolo i pittori fiamminghi rappresentavano il censimento di Betlemme in piccoli villaggi innevati, aprendo così la strada all’arte della sovrapposizione. Dal lato letterario, Joyce ha già deciso il percorso di Leopold Bloom e Stephen Dedalus imponendo il percorso di Ulisse sulla mappa di Dublino, e la geografia arbitraria sarebbe stata sicuramente di grande aiuto a Derek Walcott quando trasferì il gesto omerico al Caraibico.
Pittori e scrittori… Più si penetra nei suoi misteri, più la geografia arbitraria sembra allontanarsi dalle sponde sicure della Scienza, anche se umana… Vuol dire questo che può essere utile solo agli artisti? Niente è meno sicuro. Studiando i suoi ambiti di applicazione, dimostreremo che se si riferisce all’arte, ha il suo posto anche nel regno della scienza.
GEOGRAFIA ARBITRARIA APPLICATA
Geocritica del come se
La geografia arbitraria si trova all’intersezione disciplinare di due rami della teoria letteraria: la critica del come se e la geocritica di Westphal. Laddove Pierre Bayard suggerisce, ad esempio, di agire come se le opere cambiassero autore e di lavorare su queste attribuzioni immaginarie, io suggerisco di agire come se le opere cambiassero il loro referente nel mondo: la geografia arbitraria ispirata da Bérard mi dà le modalità per attuare questa variazione. Si tratta di un geocriticismo nel senso che il geocriticismo studia il modo in cui il testo letterario arricchisce il mondo, ma un geocriticismo attivo, che partecipa a questo arricchimento attraverso la variazione immaginaria. Si apre quindi la porta ad una geocritica del come se. Tuttavia – ed è qui che troviamo la scienza – Pierre Bayard ha ricordato l’importanza per ogni critica del come di passare attraverso quello che lui chiama, dopo Freud, delirio: un’operazione mentale staccata dalla realtà empirica ma costruita razionalmente, in altre parole un speculazione razionale.
La geografia di V. Bérard può essere definita un delirio speculativo: è razionale ma non necessariamente descrittiva, intende seguire protocolli e ragionamenti logici anche se non descrive, qualunque esso sia, uno stato di cose. Freud ha discusso i legami che uniscono il delirio paranoico e la speculazione teorica. È sorprendente vedere come la selezione di tratti rilevanti nel riconoscimento schematico richiami il modo in cui il paranoico conserva gli unici tratti della realtà che possono fondare la sua fantasia. In entrambi i casi, il rigore del protocollo stabilisce l’invenzione.
V. Bérard avrebbe senza dubbio contestato questa descrizione del suo metodo, poiché credeva fermamente che le leggi della topologia dessero accesso agli stati di fatto. È il punto di vista di un terzo – in questo caso il mio – che rileva una forza speculativa nel metodo. Allo stesso modo, è la visione di Pierre Bayard che rivela la forza speculativa dell’attribuzione di un’opera a un autore. Ma una volta avvenuta questa conversione, la geografia arbitraria trova certamente un primo campo di applicazione nella geocritica del come se.
In quanto speculativa, la geografia arbitraria contribuisce alla costruzione razionale di dispositivi in cui l’immaginazione testuale e la rappresentazione del mondo si mescolano: in questo senso, poiché crea nuove descrizioni del mondo e arricchisce così la nostra realtà di rappresentazione, trova anche un campo di applicazione nell’arte, a condizione che l’arte non sia dissociata dalla scienza.
Creare un geoartista
Sia che creiamo – meglio di me – sovrapposizioni di mappe o produciamo, a posteriori, finzioni motivazionali, l’approccio artistico basato sulla geografia arbitraria si basa su un metodo scientifico che è costrizione. Fa quindi parte della ricerca di vincoli oulipiani presi in prestito da vari ambiti scientifici, senza molta originalità. Soprattutto autorizza una forma di creazione che direi meccanica, che sfugge alla soggettività dell’artista: nel geocriticismo di Westphal, la soggettività è al centro dell’immaginazione geografica e della sua costruzione. La geografia arbitraria non attribuisce un ruolo fondativo alla soggettività artistica. È l’applicazione meccanica del diagramma sulla mappa che orienta i gesti, la soggettività interviene solo a posteriori nell’operazione di rimotivazione. La fantasia più sfrenata vi si fonda dunque con metodo rigoroso ed è l’incontro tra rigore e fantasia che dà un sapore particolare al suo delirio. La scienza non dovrebbe limitarsi a descrivere il mondo. Deve anche trovare le fantasie dell’arte, addirittura farle nascere. L’arte ha quindi tutto da guadagnare da questa nuova scienza arbitraria. Ma anche la scienza geografica può trarre vantaggio da questo nuovo ramo disciplinare, che senza dubbio arricchirà il pensiero della pianificazione urbana nella sua dimensione geopolitica, anche economica.
PER UNA NUOVA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ARBITRARIA
Uno dei compiti dell’urbanista è studiare i toponimi, o anche partecipare alla denominazione dei luoghi della città. Ma nominare le parti della città significa sempre inventarle e inventare la città, in realtà in modo del tutto arbitrario. Da parte mia, essendo nato nella buona città di Bordeaux, non posso immaginare la Place Gambetta, situata nel centro di questa città, senza che mi si imponga l’immagine di una mongolfiera, quella che ha scattato il detto Gambetta, non so più quando né perché, la mia incompetenza storica eguaglia la mia ignoranza geografica. Attraverso la magia del nome, la mia rappresentazione di Bordeaux unisce le panchine di questo luogo dove potevamo riposarci nella mia infanzia e un grande pallone gonfiabile visibile solo con l’occhio della mente. Marcel Proust lo ha detto molto meglio degli altri toponimi. Tuttavia, la geografia arbitraria deve poter contribuire a questo arricchimento dello spazio attraverso la toponomastica.
L’imposizione di un percorso su una città rafforzerà innanzitutto la coerenza dello spazio urbano e non vedremo più queste aberrazioni spaziali e cronologiche che fanno – restiamo a Bordeaux – una Place Gambetta e una rue du Palais Galien – Gallo- Circo romano – tutti adiacenti, non si sa bene il perché, in rue Judaaïque. Non sarebbe meglio offrire sia ai viaggiatori che ai residenti un viaggio significativo che li porti da Place Éole a Rue Circé, a sua volta adiacente all’Impasse Elpénor, che si aprirà su Rue Tirésias? Lo spazio urbano ne guadagnerebbe sicuramente in coerenza e continuità. I residenti troverebbero l’opportunità di acquisire una visione globale della città, che rafforzerebbe il loro sentimento di appartenenza all’entità urbana.
Abbiamo paura che la sistematizzazione abbia una presa eccessiva sullo spazio? Che lo territorializza e lo controlla? Aggiungeremo quindi un po’ di instabilità e giocheremo sovrapponendo i percorsi. Sogno un luogo chiamato, ad esempio, Place des Sirènes e de Gavroche, a discrezione di ogni passante che voglia rimotivare l’incontro tra il ragazzino e gli incantatori.
Ovviamente, i consiglieri comunali diffidenti nei confronti di un’eccessiva arbitrarietà e desiderosi di preservare la storia della loro città, potranno scegliere il percorso o i percorsi che imporranno alla loro città. A volte è ovvio: Madame Bovary per Rouen, Dickens per Londra, ecc. Ma a volte la scelta del percorso verrà fatta solo a costo dei dibattiti che animeranno i consigli comunali. Preferiamo un viaggio odisseo per Marsiglia o un itinerario attraverso Pagnol? Stendhal è una buona opzione per Grenoble? E cosa scegliere, per Parigi, tra Manon Lescaut, Les Miserables e Alla ricerca del tempo perduto, tra le altre possibili opzioni? Ma i comuni faranno bene a non cadere nella tautologia illustrativa e a non scegliere sistematicamente romanzi che sembrino riferirsi alle loro città.
A tal fine, creeremo, in ogni città, un posto di consulente di toponomastica arbitraria: egli impedirà i viaggi tanto attesi e avrà anche il compito di motivare a posteriori gli incontri tra luoghi e nomi. Ciò comporterà l’apertura di un nuovo settore negli studi geografici universitari: multidisciplinare e professionale, sarà fortunatamente in linea con le tendenze attuali.
Sul piano economico vediamo i vantaggi che i comuni possono trarre da imposizioni arbitrarie sui percorsi: le città più inventive e audaci offriranno percorsi immaginari che non potranno che attrarre una nuova categoria di turisti geografico-letterari. Arriveranno eventi culturali che contribuiranno ulteriormente a rafforzare l’attrattività dei nostri grandi centri urbani. Dublino presto impallidirà con il suo Bloom’s Day che sembrerà molto blando e privo di inventiva.
La geografia arbitraria ha quindi un futuro luminoso. Ma ha già anche una storia e un passato. Una storia davvero sfortunata, quella di un’occasione mancata. In una cittadina del sud della Francia, un sindaco, ormai deceduto e peraltro di triste memoria, decise di dare un’aria greca alla sua cittadina: ricordiamo che intitolò un nuovo quartiere “Antigone”, ma spesso non sappiamo di più l’area per non vedenti della mediateca di questa città si chiama ancora oggi “Espace Homere”. La cosa non manca di spirito, soprattutto se sappiamo che questa mediateca si chiama anche Émile Zola e si affaccia su Place Dionysos, bell’esempio di incontro arbitrario tra il Cieco, l’autore di J’accuse e il dio, dovremmo stupitevi, del delirio baccanale… Malgrado questo buon inizio, il nostro sindaco mancava tuttavia di ambizione e senza dubbio avrebbe tratto vantaggio, purché avesse ellenizzato, non senza arbitrarietà, la sua città, creandovi una via odissea secondo i metodi che ho detto: se vogliamo essere arbitrari dobbiamo saperlo essere con coerenza e costanza. La causa non è persa: avendo partecipato l’anno scorso al primo Bloom’s day organizzato in questa città del sud, ho suggerito ai suoi organizzatori di sovrapporre il percorso di Ulisse e Bloom alla mappa della loro città già un po’ ellenizzata, e di disegnare le conseguenze necessarie per il viaggio del loro prossimo Bloom’s Day. Spero che seguano il mio consiglio.
CONCLUSIONE: SULLA SOMIGLIANZA, LE SCIENZE UMANE E L’ODISSEA
In quest’ultimo esempio in forma di augurio e di progetto, come in tutte le pratiche di questa nuova branca della geografia, l’imposizione sulla mappa del percorso è arbitraria perché non è motivata da una somiglianza di sorta: nessuna analogia tra luogo e viaggio. È forse questa questione di somiglianza che, in definitiva, unisce la questione della geografia come scienza umana e la geocritica del come se: il principio di arbitrarietà porta a mettere in discussione il principio di analogia minima che governa anche la rappresentazione scientifica della geografia del mondo così come la geografia scientifica del mondo. l’immaginazione geografica.
Il percorso attraverso la geografia odissea di V. Bérard ci permette di suggerire che la somiglianza non è necessariamente un dato ma un risultato, una costruzione che può risultare da un’imposizione arbitraria. Ciò mi riporta – un po’ tardi ma ancora in tempo – alla questione delle scienze umane nel loro rapporto con l’Odissea, o meglio alla questione del futuro dell’Odissea nelle scienze umane. Può darsi che, di sfuggita, io abbia finalmente affrontato l’argomento che pretendevo di evitare.
Perché tutto è questione di somiglianza e di arbitrarietà in questa annessione dell’Odissea. Gli specialisti delle diverse scienze vorrebbero che l’Odissea fosse in un rapporto di somiglianza, addirittura di identità, rispetto ad esse. Vorrebbero disperatamente che Omero, il garante per eccellenza, avesse già detto – diversamente, meno chiaramente, in modo più figurato, ma già – quello che loro dicono adesso. Lo stesso Bertrand Westphal, come trascinato da questo demone dell’analogia, trova qualche somiglianza tra la sua affermazione geocritica e l’Odissea… Non ci insegna forse che Omero era interessato alla rappresentazione dello spazio e che nell’Odissea, “Canzone X racconta come l’uomo sia riuscito a sopravvivere oltrepassando i limiti naturali del mondo”? Vorremmo ricordare al geocritico quella canzone Abbiamo sempre bisogno di un po’ di autorità…
Estesa nei suoi principi, la geografia arbitraria è tuttavia suscettibile di offrire un po’ di riposo a questi studiosi in cerca di un’autorità basata sull’analogia. La somiglianza può essere costruita e motivata a posteriori: e se vogliamo, chi non lo vorrebbe? – assomigliano all’Odissea e a Omero, abbiamo il diritto di decidere, quindi di inventare le nostre ragioni. De narratur fabula e farei bene a ricambiare il consiglio: forse anch’io non ho bisogno che il mio approccio assomigli davvero a un metodo geografico e la mia incompetenza in materia non dovrebbe in nessun caso ostacolare il mio progetto di arricchimento dello spazio. Dopotutto, di cosa ho bisogno dell’autorità geografica per dire quello che ho da dire su Omero e Berard? Non so, in definitiva, se ho studiato solo geografia, e non sono sicura, qualsiasi cosa egli fosse, che Bérard fosse un grande geografo. Non importa… sono sicura che l’Omero letto da V. Bérard offra un modo inaspettato di inventare nuovi luoghi nel mondo e di tracciare viaggi e incontri sorprendenti. O per dirla in un altro modo, lasciamo lì l’autorità, non preoccupiamoci delle somiglianze e preferiamo la sorpresa…
6.2) REIMMAGINARE IL MEDITERRANEO CON L’ODISSEA, LE MAPPE E LA FOTOGRAFIA.
VICTOR BÉRARD, UN GEOGRAFO SULLE ORME DI ULISSE – 2016
traduzione di Gallura Tour
«I Fenici e l’Odissea [di Victor Bérard] sono, con il Tableau de la France di Michelet e l’Introduzione geografica di Vidal de la Blache, una delle nostre opere geografiche più vive, poste in autentico contatto con la terra e i mari. Tanta fantasia, diciamo spesso. Ma è un’immaginazione geografica, un dono autentico e raro. In geografia come altrove, e forse più che altrove, non si fa nulla senza fantasia, nient’altro che libri di testo.» (Albert Thibaudet, “Omero nel cinema”, 1er marzo 1928, p. 1243).
Fin dall’antichità, l’Odissea di Omero ha plasmato l’immaginario del viaggio e la percezione dell’area mediterranea da parte dei suoi lettori.
Al di là delle sue qualità poetiche, l’epopea è stata oggetto di un lungo dibattito che mette in discussione la realtà e l’ubicazione dei luoghi attraversati dall’eroe Ulisse e, così facendo, il ruolo di Omero come fondatore della geografia (Jacob, 1991).
Questo articolo si interroga su una delle tappe di questo interrogativo geografico, ritornando sul percorso dell’autore che ha cercato di far coincidere il testo e lo spazio mediterraneo con la massima coerenza, enfasi e prova, Victor Bérard (1864-1931).
Se la sua traduzione dell’Odissea, più volte ripubblicata, fu una pietra miliare, Victor Bérard pubblicò parallelamente una decina di opere per dimostrare, con dovizia di particolari, che i poemi omerici non erano un’opera di pura finzione, ma la descrizione fedele del Mediterraneo al tempo dei marinai fenici le cui collezioni nautiche si dice abbiano ispirato Omero (Jacob, 1991, pp. 16-24; Rabau, 2005; Bonnet, 2015). Tuttavia, nessuna di queste raccolte è stata ritrovata, e la tesi densa ma in definitiva inverificabile di V. Bérard è stata da allora confutata, non senza suscitare ammirazione, dibattito e polemiche in Europa (Basch, 2015). Gli specialisti della letteratura in particolare sono stati estremamente critici nei confronti dell’uso della fotografia nel suo lavoro, concentrando la loro attenzione sulla raccolta postuma In the Wake of Ulysses (1933) illustrata dal fotografo svizzero Fred Boissonnas[4]
La Scuola Solnychkin, Laury-Nuria, 2013). Tuttavia, prendere in considerazione un insieme più ampio di fonti pubblicate e inedite fornisce nuovi elementi di comprensione dei complessi legami intessuti da Victor Bérard tra le immagini dei paesaggi mediterranei e la narrativa di Omero. Appunti di viaggio inediti ci permettono di interrogarci sul ruolo della fotografia nelle sue indagini sul campo, ma anche sul posto della geografia nel suo lavoro.
Filologo ed ellenista, il traduttore dell’Odissea fu anche un intellettuale e un politico che condusse diverse carriere, lavorando quotidianamente sia su testi antichi (al mattino) che su questioni politiche attuali (al pomeriggio) (Basch, 2015; E. e R.-M.Bérard, 2015). Inoltre, quando il critico letterario Albert Thibaudet, citato nel highlight, sottolinea la dimensione geografica dei suoi scritti, questo collegamento non è solo retorico. Sebbene non sia mai menzionato negli studi sulla storia della geografia e sulla scuola vidaliana (come Berdoulay, 1981; Claval, 1972; Claval (dir.), 1993; Robic (dir.), 2006 ; Soubeyran, 1997), Victor Bérard ha tuttavia mantenuto stretti legami con la disciplina attraverso la sua formazione, il suo insegnamento e le sue reti. Formatosi all’École Normale Supérieure, Bérard, infatti, durante la sua carriera insegnò solo geografia, come professore di geografia politica ed economica all’École supérieure de Marine dal 1896 al 1914, e docente di geografia antica all’École Pratique des Hautes Études di Parigi. Dal 1896 al 1919. Dopo aver pubblicato le sue prime ipotesi negli Annales de Géographie (Bérard, 1895 e 1896), di cui fu considerato uno dei collaboratori più anziani (Gallois, 1932), dedicò la sua prima opera sulle orme di Ulisse, Il I Fenici e l’Odissea (1902-1903), a Vidal de la Blache, questo “caro maestro”.
Comprendere il pensiero di Bérard sul mondo e sui metodi attraverso il prisma della geografia ci invita a comprendere meglio il suo approccio e a mettere in discussione i margini della scuola vidaliana, ma anche a mettere in discussione le diverse modalità possibili del rapporto tra finzione e geografia(1). Discuteremo il posto delle sue teorie all’interno di una disciplina in via di istituzionalizzazione, e in tensione tra i suoi vecchi legami – la lettura di autori antichi – e nuovi pensieri sull’uomo e sullo spazio.
- “Prolegomeni geografici all’Odissea. Sulle orme di Strabone, Élisée Reclus e Vidal de la Blache
La tesi che Victor Bérard difese per quasi quattro decenni, dai suoi primi articoli negli anni Novanta dell’Ottocento fino alla sua morte nel 1931, fu riassunta in modo semplice e grafico da Albert Thibaudet:
“Cogliamo Omero in una flagrante operazione di mitologia, quando una realtà geografica diventa mito, quando il paese dagli occhi rotondi, dai crateri spenti, prende vita nella terra dei Ciclopi. Omero trasforma le istruzioni nautiche [dei marinai fenici] in poesia, la verga secca in un albero la cui testa è vicina al cielo e i cui piedi toccano l’impero dei morti. E il signor Bérard trova le istruzioni nautiche sotto la poesia, la bacchetta al principio dell’albero. È il lavoro del filologo e del geografo” (Thibaudet, 1928, p. 1244).
1.1. Inserire “Omero in una palese operazione mitologica”. La ripresa dei testi antichi, patrimonio della geografia
Considerando Omero come l’antenato fondatore della geografia e cercando di riesumare dati geografici reali dalla finzione, Victor Bérard si inserisce in un dibattito aperto fin dall’antichità da grammatici e geografi greci (Jacob, 1991, p.20). Riprende esplicitamente le tesi di Polibio e soprattutto di Strabone, che cita ampiamente nei Fenici e nell’Odissea. Secondo loro, l’Odissea avrebbe permesso di ricostruire la geografia dell’antico Mediterraneo, avendo Omero immaginato il quadro delle avventure di Ulisse utilizzando le istruzioni nautiche dei marinai fenici, navigatori provenienti dalle coste dell’attuale Siria e del Libano che avrebbero spinto le loro spedizioni verso la sponda occidentale del Mediterraneo, prima dell’avvento della navigazione greca (per un’analisi dettagliata di questa tesi si veda in particolare Bonnet, 2015; Spain, 2015). Si trattava di portare i dati geografici fuori dalla finzione.
Oltre a Omero e Strabone, Victor Bérard si servì di Erodoto, Tucidide, Tolomeo, Plutarco e Diodoro di Sicilia per affrontare un tema di geografia storica classica, la tendenza dominante nella geografia universitaria dell’epoca (Berdoulay, 1981, p. 159). Con questa disciplina condivideva l’erudizione e il legame con l’antichità, ma anche la necessità di chiarire i metodi e le tappe della scoperta del globo – lo stesso Vidal de la Blache aveva scritto delle rotte commerciali nella Geografia di Tolomeo (Claval, 1972 p. 31 e 41).
Riprendendo esplicitamente la tesi di Strabone, confutata fin dal XIX secolo (Vidal de la Blache, 1904), Bérard, come i geografi del suo tempo, rivendicava l’eredità diretta degli autori antichi, gli antenati fondatori che davano peso e legittimità alla disciplina in via di istituzionalizzazione. Formatosi all’École Normale Supérieure, Bérard divenne uno dei “discepoli” di Paul Vidal de la Blache, seguendo corsi che avrebbero avuto un impatto decisivo sulla sua futura carriera, come quelli tenuti dagli storici Fustel De Coulanges ed Ernest Lavisse (E. e R.M. Bérard, 2015).
Storico di formazione, Vidal de la Blache aveva scoperto la sua vocazione di geografo viaggiando in Grecia e cercando di capire l’influenza dei luoghi sul destino delle civiltà (Claval, 1972, p. 20). Come il suo maestro, Bérard soggiornò all’École française d’Athènes per approfondire la conoscenza dell’antichità.
La geografia vidaliana ispira anche il modo in cui Bérard intende lo spazio mediterraneo, seguendo un approccio più innovativo rispetto alla geografia storica classica. Egli inventa infatti un metodo di indagine “ibrido” caratterizzato, certo, dall’esegesi dei testi, ma anche dall’utilizzo dell’analisi cartografica e della pratica sul campo. Segue l’evoluzione della geografia verso studi umani, fisici e regionali (Berdoulay, 1981, p. 159), e verso un nuovo rapporto con il mondo.
1.2. La superiorità dell’analisi dello spazio e della vita per comprendere il passato – e il presente
Fare un lavoro geografico è localizzare”: uno dei grandi principi dei Vidaliani (Soubeyran, p. 198) è l’obiettivo principale della ricerca di Victor Bérard che si svolge anche su una carta Atlas di storia e geografia (1894) da Vidal de la Blache i luoghi individuati come tappe del ritorno di Ulisse a Itaca, nella sua prima opera, I Fenici e l’Odissea (Fig. 1).
Per individuare i luoghi descritti da Omero nella sua opera – anche nei suoi passaggi più favolosi -, si immagina un doppio metodo di indagine. Si basa anzitutto sulla toponomastica che deve rivelare, in particolare, l’origine semitica dei nomi greci, essendo i Fenici considerati, “secondo un discutibile amalgama etnolinguistico” ma allora attuali, come Semiti (Bonnet, 2015). Il secondo metodo è più originale: Bérard inventa per le esigenze della sua indagine una scienza ad hoc, la “topologia”, ispirata al pensiero dell’archeologo tedesco Gustav Hirschfeld, e destinata a elaborare una tipologia degli insediamenti greci dell’Antichità.
Definita “scienza dei luoghi”, sarebbe, secondo Bérard, per la topografia ciò che la geologia sta alla geografia: la descrizione e la localizzazione dei luoghi non sono un fine, ma il mezzo per stabilire leggi generali per identificare tipologie di habitat umani trans-storici, e viceversa, per indurre il tipo di civiltà a cui si riferisce un particolare tipo di habitat umano (Bérard, 1902, p. 6-9).
L’autore descrive con entusiasmo il suo metodo al quale attribuisce poteri quasi demiurgici:
“Origine, estensione e durata, per ciascuna talassocrazia, questi due studi (topologia e toponomastica) ci forniranno una cronologia e una geografia complessiva. Ma soprattutto riusciranno a penetrare nei dettagli, a far rivivere davanti ai nostri occhi la vita locale di un dato luogo ormai deserto o trascurato: quando la testimonianza degli scrittori e dei monumenti sarà assolutamente muta, faranno emergere dal suolo stesso la visione delle folle che un tempo si affaccendavano lungo qualche strada dimenticata o nei suq di qualche bazar scomparso” (Bérard, 1902, p. 28).
Grazie a questa combinazione di metodi, Bérard salta da un punto di vista, da un’idea, da una lingua o anche da un millennio all’altro in un perpetuo gioco di analogie – infliggendo al lettore una tale quantità di informazioni che egli vorrebbe controbattere in anticipo. le obiezioni dei suoi detrattori.
Vidal de la Blache elogiò I Fenici e l’Odissea in un resoconto pubblicato negli Annales de Géographie.
Sebbene sostenga il lavoro di Victor Bérard, rimane flemmatico riguardo all’utilità della “topologia”, sinonimo secondo lui del “vecchio nome della geografia” (Vidal de la Blache, 1904, p. 21). Esprime una riserva esplicita sull’influenza esclusiva dei Fenici e sull’idea di una tale talassocrazia, ma si sofferma poco sull’idea di tipologia trans-storica e sul determinismo geografico alla base dell’approccio di Bérard, insistendo sul fatto che diverse condizioni governano gli insediamenti umani di ogni epoca (1904, p. 22 e 26).
La ricerca di V. Bérard si basa, tuttavia, sull’idea fondamentale di Vidal de la Blache dell’unità terrestre e sulla ricerca di correlazioni tra i fenomeni, in un approccio olistico, ma diverso nel suo desiderio di stabilire leggi generali per comprendere gli insediamenti umani, i viaggi, scambi, ma anche comportamenti e immaginari umani:
“I risultati di questi due studi avranno un valore generale, vale a dire che, ben stabiliti per un dato punto, le loro scoperte saranno valide per tutti gli altri siti dello stesso periodo. Il molo inglese è uguale ovunque: chi conosce gli usi e i costumi di Gibilterra conosce anche Malta, Aden e Singapore [sic]. […] il Mediterraneo di oggi spiega il Mediterraneo di quaranta secoli fa” (Bérard, 1902, p. 28).
Egli riprende l’idea di uno spazio concepito come base permanente delle attività umane (Soubeyran, 1997, p. 110), e percepisce la storia come “un terreno sedimentario” dove gli uomini lasciano tracce, con differenze ma anche molti tratti comuni nella misura in cui “attraverso tutti i secoli e tutte le civiltà, il Mediterraneo non cambia: conserva il suo regime dei venti, il suo andamento generale delle correnti e delle coste, il suo clima, la sua fauna, la sua flora, ecc. » (Bérard, 1902, p. 26). Lo studio dei luoghi per comprendere il passato è innegabile a causa della loro permanenza (Bérard, 1902, p. 23), essendo la natura leggibile come un libro. L’analisi del mito e del passato deve servire anche alla comprensione del presente, in un incessante gioco di specchi, costituendo i testi di Omero una sorta di archetipo del viaggio e delle relazioni umane.
Lo “spirito geografico” dell’approccio di Bérard si manifesta anche nella particolare attenzione che presta ai paesaggi, “oggetto canonico” della geografia sin dalla sua partenza dal suo ufficio (Robic, 1996, p. 358). Anche la sua pratica sul campo, pratica che fa di lui un vero geografo per Vidal de la Blache:
“Il signor Bérard è un geografo e un viaggiatore che merita considerazione e fiducia. Non è forse forse penetrato, in questo ambiente odisseo del Mediterraneo, nelle insenature e nelle pieghe che le navi da crociera non frequentano […]? » (Vidal de la Blache, 1904, pp. 21-22).
1.3. Un modo per “aprire gli occhi”: il sondaggio sul campo
Dopo il soggiorno alla Scuola Francese di Atene, Victor Bérard compì numerosi viaggi nel Mediterraneo per confrontare il testo di Omero e le località proposte dagli autori antichi con i dati geografici osservati. Tentò anche di ricostruire le rotte seguite dai marinai fenici elaborando una “legge degli istmi” (Bérard, 1902, p. 78) secondo la quale gli antichi navigatori avrebbero favorito l’attraversamento di questi lembi di terra per facilitare i loro spostamenti, e mantenevano rapporti privilegiati con le comunità che vivono nelle vicinanze (Spagna, 2015).
Oltre a numerosi viaggi sporadici, il geografo ellenista compì da solo due grandi viaggi nel Mediterraneo per sostenere la sua tesi: in viaggio di nozze, portò la moglie a indagare sui siti dell’Odissea nel 1901, mentre Alice Bérard era responsabile del servizio fotografico aspetto della missione.
Nel 1912 intraprende un secondo grande viaggio, questa volta accompagnato dal fotografo ginevrino Fred Boissonnas che mette la sua arte al servizio della teoria berardiana. La prima parte della loro missione si svolse dal 27 luglio al 30 agosto 1912, con partenza da Marsiglia, con tappe a Gibilterra, Ceuta, poi Roma, prima di raggiungere per ferrovia il Monte Circe, in Sardegna (per vedere le bocche di Bonifacio, individuate come porto dei Lestrigoni), poi Napoli, Pozzuoli, in Campania (paese dei Ciclopi), per finire con Sorrento (con l’arcipelago de Li Galli, rifugio delle Sirene). Altrettanto fitto il programma del secondo soggiorno, dal 26 settembre al 14 novembre, con tappa ancora al Monte Circe, poi Napoli, Cuma, le isole di Corfù, Lefkada, Cefalonia, Itaca, poi Patrasso, Messina in Sicilia, l’isola di Stromboli, l’isola di Lipari, infine Tunisi e Djerba, alla ricerca della terra dei Lotofagi (Bérard, 1933).
Scritte a qualsiasi ora del giorno e della notte, le lettere di Victor Bérard a sua moglie nel 1912 servirono come un taccuino di campo, un campo praticato sia in mare (su navi di linea, torpediniere, barca a vela o remi) che a terra, in treno, in automobile o a piedi. Registra informazioni sul loro viaggio, le condizioni materiali del viaggio (viaggio, alloggio, vitto), i loro incontri, ma anche osservazioni geografiche, etnografiche, linguistiche e politiche (in particolare sull’aumento delle tensioni tra Grecia e Impero Ottomano), una “autopsia multisensoriale e colta” come pratica Vidal de la Blache sul campo (Robic, 1996, p. 362). Attestano quanto egli persegua una “geografia all’aria aperta” – e “all’aria aperta” in questo caso – valorizzata dalla vulgata vidaliana fin dall’inizio del secolo, in seguito al passaggio dalla disciplina come “scienza di gabinetto” a una scienza dell’osservazione (Robic, 1996, p. 357-359). Nelle sue opere, Bérard critica volentieri anche i “geografi in camera da letto” o altri “scienziati in ufficio” che, secondo lui, sono incapaci di cogliere, semplicemente leggendo carte e libri, i dati a cui fa riferimento il testo di Omero (es. Berard, 1902, p. 192).
Impegno fisico e resistenza sono richiesti durante tutto il viaggio con Boissonnas: dopo essersi avvicinati alle coste in barca, ne scalano le vette per cogliere la geografia dei luoghi, in particolare in prossimità degli istmi. I due uomini ricercano instancabilmente anche punti di vista che riecheggiano il testo dell’Odissea, come questa domenica a Corfù, identificata come la “terra dei Feaci”:
«“Taigny [un amico e connazionale] […] è un po’ stupito dalle fatiche che affrontiamo, dalle nostre salite e dalle nostre passeggiate per scoprire propr9io la visione di cui si parla nell’Odissea. Pensava che stessimo interpretando le nostre opinioni in modo un po’ a casaccio; vede che è un lavoro e un grande lavoro, è felice di partecipare […] a questa “opera gigantesca”».
1.4. Il visibile e l’immaginario: alla ricerca di punti di vista
Se l’Odissea è considerata come una fonte per accedere agli spazi antichi (Jacob, 1991, p. 17), anche i paesaggi contemporanei vengono decifrati – seguendo il metodo di Vidal de la Blache per il quale la loro interpretazione era “un po’ di esegesi” (1908, p. 59) – per comprendere meglio il testo di Omero, in un incessante andirivieni tra narrativa, carte geografiche, istruzioni nautiche e descrizione degli spazi percorsi. Bérard legge e rilegge l’Odissea quotidianamente e ogni sito gli offre una nuova comprensione del testo. Osserva le linee generali dei paesaggi, i particolari fenomeni geologici, la struttura delle coste e la loro accessibilità, le correnti marine, la presenza di acque dolci, la vegetazione, la presenza di città, villaggi e insediamenti umani più modesti, le distanze e vie di comunicazione, ma anche la “geografia delle rovine” raccomandata da Friedrich Ratzel, citata da Vidal de la Blache (Vidal de la Blache, 1908).
Critico nei confronti dei metodi degli archeologi, Bérard invita i suoi lettori ad aprire «gli occhi sulla realtà, sulle necessità primordiali della vita quotidiana» (Bérard, 1902 p. 352) per riesumare il passato non dalle vecchie pietre, ma dai viventi.
Secondo lui, la geografia permette di compensare le inadeguatezze del “regno dell’archeologia” (Bérard, 1902, p. 19) osservando i modi di vestire, muoversi, mangiare e vivere delle popolazioni incontrate, secondo questo ancora forse Vidal de la Blache per il quale i tipi di vita contemporanei erano “i risultati contingenti dei tipi di vita precedenti” (Costa Gomez, 1993, p. 94). Permette di dedurre da casi particolari generalità sugli stili di vita, sugli equilibri di potere tra i gruppi e sul rapporto delle società con lo spazio attraverso l’incessante invenzione di analogie e confronti tra diverse culture, tra diversi periodi passati e il presente, tra finzione e documenti geografici. A Itaca, ad esempio, dove interroga i bambini che corrono al loro fianco sulla situazione degli uomini della loro famiglia partiti per l’Africa o l’Australia, e paragona la situazione delle loro madri all’attesa vissuta da Penelope.
Il geografo accede alla vita di uomini e donne del passato interpretando la finzione; in cambio analizza la situazione di tutte le popolazioni incontrate alla luce dei testi antichi.
Osservando l’ambiente mediterraneo sotto il prisma di un’esegesi dell’Odissea, Bérard pone al centro della sua ricerca l’essere umano e il suo rapporto con l’ambiente: (sur)vita individuale e collettiva di fronte agli elementi, vita (economica) scambi in particolare), le pratiche del mare, gli insediamenti lungo le coste e il loro sviluppo, la trasmissione delle conoscenze geografiche. Mette in discussione anche il ruolo del mito, del sacro e dell’immaginazione nelle interpretazioni dello spazio, ancora al tempo di Omero come in epoca contemporanea.
Così, vicino Napoli:
«Siamo tornati al tram, completando il giro del Lucrin sulla sua sponda occidentale. In un angolo delle colline, una sorgente termale sgorga in un grande occhio fumante: è il Piriflegetonte di Strabone. Per un corso d’acqua tiepida sfocia nel Lucrino; con molti segni di croce, i contadini vengono a bagnare un povero cavallo stanco: queste acque sacre rimangono sempre miracolose» (Bérard, 1903, e figura 68).
Nel momento in cui l’azione, il pensiero umano e il mito danno significato alla materia, essa tenta di ripristinare il punto di vista e l’immaginazione delle popolazioni passate e presenti. La narrativa ci permette di portare alla luce un’immaginazione e una conoscenza geografica di tre millenni.
Come i suoi colleghi geografi che concentrano il loro lavoro sul visibile, i suoi testi contengono molteplici riferimenti alla vista, allo sguardo, al punto di vista. L’Odissea viene analizzata come una raccolta delle visioni che i Greci e i loro predecessori fenici avevano sui confini dell’area mediterranea, una sintesi effettuata attraverso il ricorso alla figura dell’eroe viaggiatore, Ulisse.
Bérard intende quindi l’area mediterranea come un’unità, nella tradizione degli scienziati e dei viaggiatori del XIX secolo che inventarono questo concetto, percependo ormai il mare non più come uno spazio che separa i continenti, ma come un oggetto coerente di studio, una zona di scambi politico-economici privilegiati che collegano un “insieme di società che partecipano allo stesso mondo” (Saminadayar-Perrin, 2012, p. 5).
1.5. Il mare come spazio di flusso e scambio.
Sulla scia dei viaggiatori romantici e di Élisée Reclus
Victor Bérard è l’erede dei viaggiatori che, partendo da Chateaubriand, fecero del viaggio nel Mediterraneo “un movimento di ritorno alle fonti e un’impresa di archeologia del mondo contemporaneo” (Saminadayar-Perrin, 2012, p. 10) richiedendo la decifrazione di un insieme di segni. Condivide con i romantici alcuni dei loro riferimenti letterari, come gli scritti di Pausania, ma anche un sentimento di familiarità e di “déjà vu” degli spazi percorsi. Anche lui sperimenta la stessa sensazione discreta ma attuale della fuga del tempo – come altri geografi, come Vidal de la Blache – e la necessità di registrare i dati prima della loro scomparsa: se il Mediterraneo del 1912 è visto come lo specchio del Mediterraneo di Al tempo di Omero, la sua trasformazione è tuttavia percepita come imminente.
Tuttavia si distinse dai romantici rivendicando la scientificità del suo metodo e difendendo un’altra concezione generale del passato mediterraneo: non rivolse la sua attenzione verso un’eredità latina – di cui aborriva le rovine – , ma verso le radici semitiche dell’antica Grecia, interpretando l’Odissea come un’opera certamente greca, ma debitrice alla cultura fenicia (Bonnet, 2015).
Tra le sue numerose fonti di ispirazione, Victor Bérard utilizzò forse gli scritti di Élisée Reclus – citati brevemente nei Fenici e nell’Odissea – per costruire parte del suo quadro teorico. Oltre all’idea secondo la quale l’osservazione della terra spiega gli avvenimenti della storia (Claval, 1998, p. 85), condivide con l’autore della Nuova Geografia Universale l’idea implicita di un’unità del Mediterraneo nel passato come presente (idea sviluppata nel volume sull’Europa meridionale citato da Nordman, 1998, p. 8), un’unità geografica modellata dalla circolazione in mare di più centri di civiltà successivi: Fenicia, Grecia, Italia, Francia, Gran Bretagna (Deprest, 2002)
Se E. Reclus è uno dei pensatori che contribuirono, nel XIX secolo, a percepire il Mediterraneo come un “carattere storico”, percezione resa popolare nel secolo successivo da Fernand Braudel (1949), gli scritti di Victor Bérard – citati altrove da Braudel – sono uno degli anelli della catena di questa idea.
Victor Bérard, invece, rilegge l’area mediterranea combinando punti di vista sia terrestri che marini. A tal fine percorre le coste a piedi, in macchina, costeggiando e noleggia con Boissonnas in barca a vela (36 tonnellate e un albero alto 12 metri) tra Corfù e Parga, in Epiro. Lento e più imprevedibile del viaggio in battello a vapore, questo viaggio permette loro di scoprire il punto di vista dei navigatori, ma anche i vincoli legati alla navigazione che trasformano la loro percezione dello spazio, in particolare l’accessibilità delle coste, le distanze, il ruolo di correnti e di venti: “abbiamo bisogno di queste esperienze marittime per dare a noi terrestri il senso dell’Odissea”, dopo aver percorso solo 6 chilometri in 5 ore al largo di Corfù.
La questione del punto di vista e la tensione tra finzione e geografia in questa ricerca odissea è particolarmente visibile nell’uso di due strumenti: la mappa e la fotografia.
- Pratica sul campo, esegesi di mappe e paesaggi, fotografie. Giochi di specchi tra finzione, antichità e presente
Il viaggio di diversi mesi intrapreso nel 1912 da Victor Bérard con il fotografo svizzero Fred Boissonnas rappresenta il culmine di questa ricerca odisseica, anche se il progetto editoriale dei due uomini non fu mai realizzato a causa di una combinazione di circostanze esterne (Sohier, 2015). Utilizzate fin dall’inizio dell’indagine, nel 1901, le fotografie di paesaggio, come le mappe, hanno in questo lavoro un ruolo complesso. Strumenti scientifici, queste immagini vengono utilizzate anche per la loro dimensione poetica e narrativa.
2.1. Il potere delle carte
L’analisi cartografica occupa un posto centrale nel metodo sviluppato da Victor Bérard. Inteso lo spazio come dato stabile, egli utilizza le mappe contemporanee per visualizzare con precisione il territorio su cui vivevano i Greci, e prima di loro i marinai fenici. L’Atlas antiquus (che fu fornito al ricercatore nel 1901 poiché l’opera servì da alibi, insieme all’Odissea e un dizionario ebraico, durante il suo arresto in Sardegna da parte della polizia italiana che lo sospettava di spionaggio (1903, p. 257), le carte dell’Atlante di Vidal de la Blache, dello stato maggiore francese, o quelle più antiche, come quelle di M. Mapie o della missione Morée, si completano a vicenda e offrono una soluzione di continuità tra passato e presente.
Le carte topografiche vengono utilizzate per individuare centri abitati, anche i più modesti, indizi della presenza di “siti omerici”, per la presunta continuità delle aree di habitat, ma anche rifugi naturali come grotte, fonti di acqua dolce – prove decisive nella sua teoria – luoghi di culto, fiumi, vie terrestri. Le carte nautiche vengono utilizzate per identificare isole e isolotti, ma anche correnti, porti e porti naturali potenzialmente frequentati dai Fenici tre millenni prima, baie, insenature o spiagge. La lettura referenziale delle carte geografiche fa appello all’oggettività dei documenti e alla loro autorevolezza per fornire supporto scientifico alla dimostrazione: “Per meglio illustrare l’esattezza delle descrizioni odissee, vedremo in seguito che le carte e le fotografie dei luoghi sono di aiuto essenziale. Questi documenti scientifici danno la spiegazione precisa di tutte le parole del poeta” (Bérard, 1902, p. 55).
Gli strumenti dei geografi permettono però anche di illuminare il senso della finzione, come illustra la sua dimostrazione attorno ai Campi Flegrei (una caldera situata in Campania, nella regione del Vesuvio) identificati fin dagli Antichi come il paese dei Ciclopi – questi esseri giganti del Canto IX dell’Odissea, feroci lanciatori di pietre, che sarebbero nati dall’immaginazione di Omero sulla base delle descrizioni dei vulcani.
A sostegno di questa ipotesi, Victor Bérard fece fotografare obliquamente una pianta di rilievo del laboratorio di geografia fisica della Sorbona (Bérard, 1903, fig. 11 p. 130 e 12 p. 131) per evidenziare i crateri sparsi attorno al Vesuvio somiglianti a degli “occhi”, collegamento che dimostra che proprio questo fenomeno geologico era all’origine della figura del Ciclope (Fig. 2).
Applica così una lettura poetica e soggettiva agli strumenti del geografo utilizzati come mediazione simbolica tra l’uomo e lo spazio (Jacob, 1992). Questa interpretazione presuppone una visione aerea del territorio che era difficile da immaginare ai tempi di Omero (Jacob, 1991, p. 20), anche se Bérard giustifica questa teoria con l’idea che il bordo di queste formazioni geologiche fosse chiamato “sopracciglia” dagli Antichi (Bérard, 1903, p. 131).
Meglio, l’analisi cartografica permette di collocare la finzione nello spazio e di fondere le parole del testo, il tracciato cartografico e le rispettive immaginazioni: «Non dobbiamo correre così lontano alla ricerca dei porti di Alkinoos. Basta aprire le nostre carte nautiche. […] Prendi la mappa. Vi si applicheranno tutte le parole del testo odissea» (Bérard, 1902, p. 523). L’autore invita lo spettatore a viaggiare tra le linee delle mappe per individuare le informazioni virtuali che contengono, un metodo che riecheggia le raccomandazioni dei teorici dell’insegnamento della geografia sotto la Terza Repubblica, che incoraggiavano gli insegnanti a mobilitare l’immaginazione dei loro studenti per sognare il mondo e viaggiare utilizzando le mappe prima di analizzarle (Jacob, 1992, p. 328). Victor Bérard non si limita a difendere una teoria, cerca di sedurre i suoi lettori trascinando di nascosto una dimostrazione scientifica d’avanguardia verso il sogno e l’immaginazione, grazie al potere di fascino della finzione, ma anche a quello degli strumenti geografici.
Carte e planimetrie permettono di scandire la manifestazione moltiplicando i punti focali sia sul racconto che sull’area mediterranea; alle analisi accademiche delle mappe seguono “immersioni” nello spazio rappresentato utilizzando appunti di viaggio punteggiati da aneddoti datati e localizzati con precisione. Poesie, mappe e toponimi sono mediazioni simboliche tra il lettore e l’antico passato, come il racconto dello spostamento del geografo che tenta di abolire la distanza fisica e temporale affinché la finzione si incarni in uno spazio reale. Questo è anche il punto centrale delle fotografie.
2.2. La fotografia, dal documento scientifico alla ricostruzione in situ della finzione
Victor Bérard e Fred Boissonnas riportarono dalla loro missione più di 2.000 fotografie su lastre di vetro, il cui solo peso dà un’idea dell’importanza attribuita a questi documenti. A prima vista, è per la loro dimensione indicale che queste immagini sono state create, con l’idea di fondo di una perfetta adeguatezza tra territorio, mappa e fotografia, come suggeriscono questi appunti di viaggio scritti nel villaggio di Lacones, a Corfù:
«Laggiù, in uno strapiombo, ai piedi di duecento metri di dislivello, il paese dei Feaci si presenta a noi come una carta geografica spiegata; fotografiamo questo innalzamento topografico dove risaltano in rilievo tutti i principali tratti della descrizione odissea».
L’importanza dell’analisi del paesaggio nella dimostrazione di Bérard giustifica l’uso della macchina fotografica, uno strumento prediletto dai membri della Scuola francese di geografia (Robic, 1993a, p. 59) per studiare sul campo sia i fenomeni fisici che l’ “impronta” umana (Robić, 1993b). Altri discepoli di Vidal de la Blache, Jean Bruhnes ed Emmanuel de Martonne, contribuiscono a mettere la fotografia al servizio della disciplina (Mendibil, 1993, p. 140). Colleghi di Bérard, entrambi avevano già collaborato con Fred Boissonnas, incaricato di redigere, sotto la loro direzione, l’Atlante fotografico delle forme dei rilievi terrestri al termine del 9° congresso internazionale di geografia, tenutosi a Ginevra nel 1908. Questo atlante doveva riunire sotto forma di fascicoli i documenti “fotografici e scientifici” di “tutte le parti del globo” raccolte grazie ad un appello internazionale alla collaborazione (De Martonne, 1912). Fu pubblicato solo il primo opuscolo (Brunhes, Chaix, de Martonne (dir.) 1911), ma questo progetto dimostra che Boissonnas, che lavorò più volte per gli archeologi, era consapevole anche delle problematiche relative all’uso della fotografia da parte dei geografi. Jean Bruhnes, ad esempio, utilizzava la fotografia come ausilio alla memoria per descrivere l’aspetto dei luoghi al termine delle sue campagne di osservazione (Robic, 1993b, p. 117). Victor Bérard ha fatto lo stesso uso delle fotografie di Boissonnas, ogni stampa di riferimento è stata incollata su cartoncini numerati, accuratamente didascalia e classificati, per una facile consultazione.
Strumento di indagine, la macchina fotografica è un prolungamento dell’occhio del geografo, di cui serve anche ad affinare la visione, come suggerisce il bilancio di Victor Bérard della sua indagine con Boissonnas: “Su due punti importanti, questo controllo attento del fotografo mi ha permesso di correggere le mie prime identificazioni di luoghi” (Bérard, 1927, t. 1, p. 20). Bérard mobilita anche l’oggettività del documento fotografico, vera “retina dello studioso” (Gunthert, 2000), e la sua presunta trasparenza per stabilire prove da opporre ai suoi detrattori (Bérard, 1927, t. 1, p. 354). Così, le immagini dimostrano che gli scogli immaginati da Omero per l’episodio del naufragio di Ulisse prima di essere salvato da Nausicaa, nel canto VI dell’Odissea, esistono effettivamente ai piedi del castello di Saint-Angel, a Corfù, come tutti gli elementi geografici citati nel testo, rinvenuti da un capo all’altro della costa in una frenetica indagine effettuata in automobile dal 3 al 7 ottobre 1912.
Le fotografie vengono però utilizzate a supporto di diverse tipologie di dimostrazioni perché si riferiscono a referenti molto diversi: da un lato dati di geografia fisica che permettono di localizzare le rotte e i siti frequentati dai marinai fenici (istmi — Fig. 3 per esempio -, sorgenti d’acqua dolce, elementi geologici caratteristici che possono fungere da punti di riferimento per i naviganti, come lo scoglio di Capo d’Orso in Sardegna); dall’altro a elementi citati nella narrativa di Omero, e considerati come altrettanti indizi: montagne, foreste, specie vegetali e animali endemiche, o anche pratiche umane (agricoltura, habitat, pesca, attrezzature nautiche).
Ma altre fotografie vengono utilizzate ricorrendo a una lettura metaforica del referente, come questo pesce fotografato da tutte le angolazioni da Boissonnas alla stazione di Messina (Fig. 4): l’eccidio dei Lestrigoni, questi giganti cannibali, perpetrato nel canto X dell’Odissea , era infatti per Bérard, seguendo Strabone, un’interpretazione metaforica della spettacolare pesca del tonno praticata sulle coste sarde (Strabone, I, 2, 15-16; Bérard, 1903, p. 225-229 ;Jacob, 1991).
Le fotografie del rilievo della Società Geografica di Parigi già citate e pubblicate nel 1903 si riferiscono ad un altro tipo di somministrazione di prova da parte dell’immagine fotografica, con un legame ancora più complesso tra l’analisi metaforica del racconto di fantasia e l’immagine, destinato ad attivare l’immaginazione del lettore. Il collegamento funziona grazie alla semplicità del risultato, unita all’autorevolezza del referente (il piano di soccorso). Questo tipo di immagini era già utilizzato nel mondo scientifico per evocare mondi fuori dalla portata dell’occhio umano: le immagini della superficie della Luna pubblicate nel 1858 erano state realizzate allo stesso modo – con un risultato del tutto simile – da un modello in gesso illuminato ad angolo (Burbridge, 2015, p. 46). Inoltre, questo utilizzo non era in contraddizione con le pratiche di altri geografi, poiché Vidal de la Blache, ad esempio, talvolta associava metafore e immagini poetiche alle fotografie nelle sue opere per tenere conto della dimensione immaginaria di un sito (Mendibil, 1993, pp 155-156).
Tuttavia, in Bérard, alcune fotografie non si riferiscono ad analisi ma a pura e semplice illustrazione di finzione, come le immagini dei maiali che riecheggiano quelli di Circe, o di questa grotta identificata come quella dei Ciclopi, e sullo sfondo della quale si vede un è stato acceso un fuoco per comporre la scena. La fotografia viene quindi utilizzata non come prova, ma come supporto visivo di una scena immaginaria, gli spazi attraversati fungono da ambientazione con un’efficacia poetica tanto più forte quanto più le immagini sono scattate in situ, nei luoghi che avrebbero ispirato il racconto, e attraverso incontri casuali. Le innumerevoli vedute di mare, uccelli, nuvole o altri tramonti visibili nella collezione Bérard-Boissonnas non hanno altra funzione.
Fred Boissonnas gioca con l’ambiguità dello statuto della fotografia per creare immagini corrispondenti alle aspettative della geografia fisica e umana, mettendo senza dubbio il suo talento “artistico” – e rivendicato come tale – a disposizione dell’opera di V. Bérard, la cui traduzione dell’Odissea verrà pubblicata anche sotto forma di lussuosa opera illustrata (Sohier, 2015).
2.3. Ripristinare i punti di vista
Le fotografie scattate da Boissonnas ci permettono di seguire lo sguardo del geografo che intendeva invitare il suo futuro lettore al suo viaggio attraverso testi e immagini. La loro composizione è realizzata con cura, con particolare attenzione al punto di vista e all’inquadratura. La serie di fotografie combina vedute riprese dal mare (in alto mare, o a distanze variabili dalle coste) e da terra (dalle coste, o dall’entroterra comunque generalmente collocate rispetto alla riva), al fine di rivelare i diversi punti di vista di cui l’Odissea sarebbe la sintesi. La fotografia consente la ricerca archeologica dal punto di vista degli Antichi:
“Qui, sul posto, vi assicuro che rivivo ora per ora le preoccupazioni vitali di queste persone, e che riesco a vedere il mondo greco come lo vedevano loro, ben diverso da come lo vediamo noi attraverso le nostre illusioni o le nostre teorie sulla storia ellenica».
Trasformando regolarmente in finzione i suoi racconti di viaggio (editi e inediti), il geografo fa coincidere la sua visione con quella dei marinai fenici che si suppone siano realmente esistiti, ma anche con quella dell’eroe della finzione, come qui, in Sardegna: “È sembra che questa costa sarda delle Bocche ci riporti tutti i luoghi e, allo stesso tempo, tutti gli episodi dell’avventura odissea. È in questo Pozzo che Ulisse venne a sbarcare: con la mappa davanti agli occhi, possiamo seguirlo passo dopo passo” (Bérard, 1903, p. 230).
Victor Bérard mette in scena sia l’opera di Omero che l’analisi scientifica che ad essa applica incarnando la figura di un ricercatore-viaggiatore-avventuriero. La sua dimostrazione è infatti scandita dall’alternanza di analisi erudite e del resoconto della propria esperienza a partire dalla sua prima opera sulla questione, I Fenici e l’Odissea. Così, in Sardegna, quando la sua squadra viene arrestata dagli agenti della polizia italiana mentre navigavano di buon passo durante l’ora dell’aperitivo in barca a vela al suono dei canti dei marinai:
“A tutta forza arriva al nostro fianco una barca carica di uniformi. Un condottiero di Lestrigoni – voglio dire: un grande ufficiale di marina – fa cadere un rampino che ci fa prigionieri” (Bérard, 1903, p. 256).
Qualche anno dopo, il progetto fotografico con Boissonnas è senza dubbio volontà di mettere in scena il ricercatore, ma anche di mettere in mostra l’opera di Omero per “aggiornare” la sua poesia, e restituirle allo stesso tempo vita e movimento. Il legame con la geografia non è quindi del tutto spezzato: questo modo di riportare analisi ardue, sul piano teorico, è in linea con i racconti di viaggi e di esplorazioni che hanno contribuito a diffondere nuove visioni del mondo e a popolarizzare la geografia tra gli uomini del suo tempo, come l’immenso successo in libreria della rivista Le Tour du monde (Berdoulay, 1981, p. 143).
È anche al di fuori dell’ambito accademico che va valutata la portata della sua opera: se la teoria di Bérard non ottenne il sostegno del mondo accademico, il successo editoriale dei numerosi libri da lui dedicati alla questione omerica dimostra che il suo approccio non fallire completamente.
- La dimensione performativa della lettura del mito. Pedagogia, politica e reincanto del mondo
Il legame di Victor Bérard con i geografi della sua generazione si ritrova forse anche nel suo impegno politico e sociale, considerando la sua teoria sia come mezzo che come fine.
3.1. Tessere nuovi legami tra “il mondo del testo e il mondo del lettore
“Numerosi autori antichi e moderni ci fornirebbero la prova che, dal più arido di questi viaggi o portolani, possono emergere le storie più meravigliose” (Bérard, 1930, p. 161-162). Secondo la testimonianza dei suoi ex studenti, Victor Bérard avrebbe saputo, in qualità di insegnante di geografia, far amare ai futuri ufficiali di marina il testo dell’Odissea (discorso funebre pronunciato dal ministro della Marina, Charles Dumont, pubblicato in Victor Bérard, 10 agosto 1864-13 novembre 1931… Il suo approccio all’area mediterranea attraverso la narrativa è stato, inoltre, un mezzo per familiarizzare i suoi studenti con la lettura di carte o istruzioni nautiche, ma anche con la conoscenza di dati geografici precisi sulle correnti marine, sulla divisione delle coste del Mediterraneo, sui loro rilievi, sulla fauna e flora, le vie di traffico, la distribuzione delle società e l’ubicazione dei siti antichi e attuali, ma anche l’immaginario geografico delle diverse società.
È anche al di fuori dell’ambito accademico che va valutata la portata della sua opera: se la teoria di Bérard non ottenne il sostegno del mondo accademico, il successo editoriale dei numerosi libri da lui dedicati alla questione omerica dimostra che il suo approccio non fallire completamente.
- La dimensione performativa della lettura del mito. Pedagogia, politica e reincanto del mondo
Il legame di Victor Bérard con i geografi della sua generazione si ritrova forse anche nel suo impegno politico e sociale, considerando la sua teoria sia come mezzo che come fine.
3.1. Tessere nuovi legami tra il mondo del testo e il mondo del lettore
“Numerosi autori antichi e moderni ci fornirebbero la prova che, dal più arido di questi viaggi o portolani, possono emergere le storie più meravigliose” (Bérard, 1930, p. 161-162). Secondo la testimonianza dei suoi ex studenti, Victor Bérard avrebbe saputo, in qualità di insegnante di geografia, far amare ai futuri ufficiali di marina il testo dell’Odissea (discorso funebre pronunciato dal ministro della Marina, Charles Dumont, pubblicato in Victor Bérard, 10 agosto 1864-13 novembre 1931… 1932, p. Il suo approccio all’area mediterranea attraverso la narrativa è stato, inoltre, un mezzo per familiarizzare i suoi studenti con la lettura di carte o istruzioni nautiche, ma anche con la conoscenza di dati geografici precisi sulle correnti marine, sulla divisione delle coste del Mediterraneo, sui loro rilievi, sulla fauna e flora, le vie di traffico, la distribuzione delle società e l’ubicazione dei siti antichi e attuali, ma anche l’immaginario geografico delle diverse società.
Frutto della scuola della Terza Repubblica e dei suoi ideali democratici di accesso al sapere, Victor Bérard prestò particolare attenzione all’educazione e alla circolazione delle idee nella società francese. Prima della sua spedizione con Fred. Boissonnas, era stato per sette anni segretario generale di un’importante rivista francese, la Revue de Paris, dove incoraggiava la pubblicazione di articoli su tutti gli argomenti allo scopo di educare il lettore intrattenendolo, intrattenimento che altrove dovrebbe servire a ” umanizzarlo” (Aubert, 1931, p. 715).
L’uso della fotografia scientifica e “artistica” riecheggiava anche il suo interesse per le arti dello spettacolo come il teatro, come mostrato nella prefazione al suo ultimo libro, La Resurrezione di Omero:
“Durante i lunghi anni che ho dedicato allo studio del testo omerico e alla traduzione dell’Odissea, ho sempre nutrito la speranza di trasformare un giorno il dramma epico nella “lettura scenica”, nella recitazione, e perfino nel mettere di nuovo sul palco. Il meraviglioso progresso del cinema, degli altoparlanti e dei film sonori mi fa credere che si avvicina il giorno non solo di questo dramma, ma anche di altre opere letterarie che, sul suo modello, i nostri giovani o futuri scrittori dovranno creare» (Bérard, 1930, pag.11).
Bérard era preoccupato per la perdita di interesse per Omero da parte del pubblico francese all’inizio del XX secolo. Se ha cercato, attraverso le sue traduzioni, di offrire una versione dell’Odissea in linea con la lingua dei suoi contemporanei, in modo che il testo potesse essere declamato nuovamente – a rischio di prendersi delle libertà con la sua versione greca (Basch, 2015) – l’uso della fotografia di viaggio ha permesso di far rivivere il poema – Resurrect Homer – e di animarlo grazie alla potenza dello sguardo e dei nuovi media, così come il poeta era riuscito, a suo dire, ad animare asciutte descrizioni nautiche per dare “movimento” alle cose e il sentimento alle pietre stesse” (Bérard, 1930, p. 169). Non a caso Albert Thibaudet, amico di Victor Bérard, propose di adattare Omero per il cinema attraverso la sua traduzione dell’Odissea, sul modello dei film di Abel Gance (Thibaudet, 1928; Rabau, 2012). Diverse centinaia di fotografie scattate da Alice Bérard e Fred Boissonnas sono state trasposte su diapositive da proiettare durante le sue lezioni e conferenze, tra cui una decina colorate, prova dell’uso del potere di fascinazione delle immagini.
Le missioni di Bérard nel Mediterraneo sono anche spettacolo: messa in scena in situ di finzioni, spettacolo del mondo, la cui bellezza è spesso sottolineata dall’autore, avventura intellettuale e fisica, racconto di esplorazione.
Gli storici del libro invitano a tenere conto della circolazione dei testi, della loro materialità e delle loro modalità di incontro con il mondo dei lettori, la cui lettura “si incarna sempre in gesti, spazi, abitudini” (Chartier, 1989, p 1510).
Il lavoro di Bérard sull’Odissea aveva lo scopo di rendere il testo antico disponibile a una comunità più ampia di lettori/spettatori, proponendo nuove modalità di accesso alla narrativa e al suo immaginario. Se ha sedotto i lettori con i suoi racconti di viaggio e di avventure come altri geografi che scrivono negli Annales de Géographie (Soubeyran, 1997, p. 118), attraverso la messa in scena della sua opera ha donato un corpo (universale maschile, quello del ricercatore-viaggiatore ) alla conoscenza e alla scoperta del territorio, incoraggiando il lettore a immergersi in questo spazio con il pensiero, o anche con la realtà: il secondo volume de I Fenici e l’Odissea, pubblicato nel 1903, contiene già numerose foto di fotografi-viaggiatori che hanno risposto al richiamo del primo volume partendo da soli alla ricerca dei luoghi dell’Odissea. Lo stesso libro e la traduzione dell’Odissea proposta da Victor Bérard hanno ispirato anche artisti, come James Joyce (Seidel, 1976, p. 4).
Se Bérard ha incoraggiato i lettori ad appropriarsi del testo e del suo immaginario attraverso i nuovi media, il suo approccio scientifico ha anche permesso di creare collegamenti tra il mondo dei lettori e il referente geografico della narrativa, il Mediterraneo degli inizi del XX secolo, poiché avrebbe voluto organizzare viaggi collettivi per turisti accademici per presentare la propria tesi, trasformando questo spazio in un teatro.
3.2. Un’immaginazione performativa: al servizio della politica
La scena dei “lavatoi di nausicaa” illustra il paradossale legame tra le sue missioni sulle orme di Ulisse e l’attualità (Fig. 5). Le lavandaie incontrate sulla riva dell’isola di Corfù vengono fotografate per dimostrare sia la presenza di una fonte d’acqua dolce sia la pratica di costringere le donne a spostarsi diversi chilometri al di sotto del loro villaggio per lavare i propri panni, come i personaggi del canto VI dell’Odissea.
Le donne posano vestite con abiti tradizionali, elemento che facilita implicitamente un parallelo con i personaggi della narrativa omerica. Queste immagini prive di riferimento temporale, tuttavia, non restituiscono le condizioni del loro incontro avvenuto poco dopo lo scoppio della guerra dei Balcani, e raccontato da Bérard nella sua corrispondenza:
“Boissonnas ha potuto scattare le fotografie più belle del nostro viaggio grazie all’intensa conversazione che avevo avviato e che abbiamo dovuto intrattenere con dieci o dodici lavandaie, esasperate dalla mobilitazione e che reclamavano i loro uomini con grandi minacce contro i ministri, contro questo “asino” di Venizelos che sacrifica la Grecia a Creta. Questa è una guerra che non è popolare!”.
- Bérard era profondamente preoccupato per l’attualità politica di una regione sulla quale aveva anche scritto molto a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento, in particolare come specialista di notizie politiche alla Revue de Paris. “Quando tutto sarà profondamente calmo su questa piazza deserta, è probabile che intorno ad Adrianopoli si combatteranno e che migliaia di esseri umani marciranno sotto la pioggia di domani.”
Prima di essere eletto senatore del Giura, nel 1920, dove si specializzò in questioni educative e affari esteri, aveva già offerto i suoi consigli e le sue analisi al Parlamento francese Ministero degli Affari Esteri, come attesta la sua corrispondenza. Nel corso della sua odissea del 1912, seguì da vicino lo sviluppo della guerra dei Balcani leggendo i giornali, discutendo con i diplomatici e con tutte le persone che incontrava sul suo cammino, cercando di comprendere il posizionamento e le strategie dei suoi interlocutori.
Se le sue missioni di ricerca sull’Odissea gli permettono di raccogliere informazioni di prima mano al servizio delle sue analisi politiche – le sue ricerche sull’Antichità fungono occasionalmente da ottimo alibi (E. e R.M. Bérard , 2015) – la sua tesi sull’Odissea Homer non è del tutto disconnesso dalla politica. La sua visione della storia evidenzia il ruolo dei Fenici, la cui cultura era allora descritta come “semitica”, accanto all’eredità greca e latina dell’Europa (Bonnet, 2015). Questa posizione ideologica che propone una nuova condivisione della storia del Mediterraneo non è estranea al suo coinvolgimento nel caso Dreyfus al quale partecipò attivamente come diversi studenti di Paul Vidal de la Blache all’ENS (Berdoulay, 1981, p. 95). Lo stesso Bérard suggerisce un collegamento tra i dibattiti universitari e il movimento antisemita della fine del XIX secolo: “Gli sfortunati Fenici divennero oggetto della profonda antipatia di diversi studiosi, antipatia che si sarebbe quasi tentati di mettere in relazione con il movimento antisemita dei nostri giorni…” (Bérard, 1902, p. 23).
Profondamente nazionalista, come tutti gli uomini della sua generazione segnati dalla guerra del 1870, Bérard intervenne anche sulla scena politica durante la prima guerra mondiale, come Paul Vidal de la Blache (Lacoste, 1979; Robic, 2006, p. 131-132) o come diversi membri della Scuola francese di geografia durante i negoziati di pace di Versailles, che consigliarono i politici sui limiti da definire tra i gruppi etnici (Claval, 1974, p. 33). Si schierò contro la Germania attraverso scritti violenti, ma anche contro il suo alleato, l’Impero Ottomano, di cui aveva criticato la politica nei confronti delle minoranze, in particolare degli armeni, sin dagli anni Novanta dell’Ottocento. Se fa parte dell’ambiente filo-serbo come J. Bruhnes o E. De Martonne, Bérard utilizza attraverso Boissonnas la sua teoria sull’Odissea per sostenere le rivendicazioni della “Grande Grecia”, e anche questo non condivide del tutto le opinioni di il suo Primo Ministro, Eleftherios Venizelos (E. e R.M. Bérard, 2015).
Il racconto della loro missione attraverso il Mediterraneo e parte delle loro fotografie sono utilizzati come parte di una grande mostra itinerante accompagnata da conferenze per dimostrare la coerenza culturale e politica della “Grande Grecia” e la grecità delle regioni appena conquistate (Boissonnas, 1919). Il fascino esercitato dalla sua teoria, l’autorevolezza dell’approccio scientifico e l’ambiguità delle immagini fotografiche di Boissonnas si prestavano perfettamente a un’operazione di propaganda politica.
Conclusione
Il carattere illusorio della lunga ricerca di Victor Bérard è stato dimostrato fin dalla sua morte: “L’Odissea non è né una geografia del Mediterraneo, né un racconto di viaggio, né un’indagine etnografica, né l’ambientazione in versi e musica di istruzioni nautiche (fenicie o altre). Racconta [solo] il ritorno di uno che «vagò per anni […] soffrendo nell’animo molte angosce sul mare». (Hartog, 1982, p. 415).
La sua opera ha però permesso di rinnovare i modi di lettura del testo antico, e di offrire una “presentazione” del passato delle coste mediterranee attraverso un patrimonio diverso dal solo greco – Romani. Mentre alcuni paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono colonizzati e facilmente raggiungibili in battello a vapore, Bérard non cerca un tesoro, come certi archeologi-viaggiatori del XIX secolo, ma iscrive il mito e la sua immaginazione in uno spazio reale.
Il suo lavoro ci permette di esplorare le prove e gli errori dell’uso scientifico della registrazione delle immagini e, oltre a ciò, la forza dell’alleanza tra geografia, fotografie, mappe e finzione per permeare gli spazi mediterranei di significato e di affetti che vivono importanti cambiamenti geopolitici.
La sua teoria è il prodotto della stretta associazione dell’insegnamento francese della geografia con la storia, ma anche del “fermento creativo” della disciplina da cui è emersa la scuola vidaliana (Soubeyran, 1997, p. 193).
Qualunque siano i posteri della sua tesi, Victor Bérard eccelleva nel diffondere la conoscenza geografica ricorrendo alla finzione e al potere di fascino dei suoi strumenti: sapeva far emergere il fantastico nelle istruzioni nautiche, nelle carte topografiche, nei piani di rilievo e nella fotografia di paesaggio. Le immaginazioni geografiche prodotte avevano anche una dimensione performativa, poiché V. Bérard era coinvolto come molti dei suoi colleghi geografi della Terza Repubblica nella vita politica nazionale e internazionale del suo tempo.
7.1 (FENICI E GRECI IN ITALIA SECONDO L’ODISSEA
di PHILIPPE CHAMPAULT
Parigi, Ernest Leroux, 1906
traduzione di Gallura Tour
PREMESSA
Il Nostos di Omero, la parte dell’Odissea dedicata alle avventure di Ulisse, è un documento di prim’ordine da tre punti di vista: geografico, storico e sociologico.
È il poema nazionale della colonia di Ischia, metà fenicia e metà greca, frutto della fusione dei Feaci e dei Calcidesi, e rivela tre pagine di storia altrettanto interessanti e finora ignorate.
Racconta dei Fenici, che lasciarono Tebe e occuparono per primi il sito di Cumae, molto prima della guerra di Troia, poi fondarono Scheria sull’isola d’Ischia e, con il nome di Feaci, divennero padroni del Mar Tirreno. Poi, sulla stessa isola d’Ischia, ci mostra l’arrivo, lo sviluppo e il declino di una colonia greca di Calcide ed Eretria, nota agli storici. Infine, l’antico poema racconta la propria storia, con un episodio della vita errante del suo autore, il divino Omero.
In un secondo ordine di idee, il Nostos descrive l’organizzazione sociale delle colonie fenicie in Occidente; lo mostra interamente plasmato dalla vita delle spedizioni commerciali e delle pericolose avventure di mare.
In terzo luogo, in queste misteriose peregrinazioni di Ulisse finalmente tracciate sulla carta, egli rivela la geografia del Mar Tirreno e dei suoi dintorni, così come l’avevano fatta i Fenici in generale, e i Feaci di Ischia in particolare.
Questo è ciò che abbiamo visto nel Nostos, e ciò che vedrete con noi, se sarete disposti a leggere queste pagine.
Certo, siamo molto lontani dalle conclusioni della critica moderna, che fa dell’opera di Omero un fantasioso intreccio di descrizioni inventate a piacere, dietro il quale ogni realtà sfugge e scompare.
Ma siamo quasi altrettanto lontani dal recente lavoro di M. Bérard, Les Phéniciens et l’Odyssée. Troppo timido nella sua fede nel testo, nonostante le sue proteste di esagerato omerismo, l’eminente professore è rimasto quasi ovunque prigioniero delle localizzazioni classiche. Tranne che in tre punti, la mia interpretazione della geografia del Nostos differisce completamente dalla sua. Il signor Bérard d’altronde tace quasi per quanto riguarda la storia, e tace completamente per quanto riguarda la sociologia.
IV
LA SARDEGNA, PRINCIPALE PAESE PRODUTTORE
Ci resta ancora da trovare, nel Mar Tirreno o nei suoi dintorni, tre siti odissei: Laistrygonia, l’isola di Circe e la Terra dei Morti. La tradizione li ha collocati molto vicini a Napoli; li scopriremo molto più lontano, al nord della Sardegna e nell’arcipelago toscano. Hanno questo tratto comune: costituire l’unico gruppo di nuovi paesi sfruttati dai Feaci che l’Odissea ci fa conoscere.
Il paese dei morti
La Terra dei Morti e l’isola di Circe sono collegate in Nostos. Omero infatti dice chiaramente che la Terra dei Morti si trova a sud-ovest dell’Isola dei Maghi, e che inizia alla distanza di una lunga giornata di navigazione (1).
Partiamo al mattino dalla casa di Circe; navighiamo tutto il giorno sul Mar Tirreno; la sera, «nell’ora in cui le strade sono piene di oscurità», lasciamo questo mare per entrare nel fiume Oceano. La navigazione continua, e durante la notte (siamo arrivati anche nella terra della notte che non finisce mai) la nave tocca la riva dei Morti.
Non possiamo stimare la distanza dai confini dell’Oceano alla Terra dei Morti; ma non è la stessa di Circe all’Oceano. Un giorno estivo (2), che dura fino alla notte oscura, rappresenta quasi diciotto ore, cioè, secondo la velocità ordinaria delle navigazioni antiche, circa 110 chilometri, e circa 160 chilometri secondo la loro velocità massima (3).
(1) Odissea, X, 505-7; Xf, 11-13.
(2) Gli anziani navigano solo durante i mesi estivi.
(3) La velocità ordinaria delle navigazioni antiche è di 145-150 chilometri ogni ventiquattro ore. Tuttavia, per certi itinerari e in maniera costante, Scilace indica 220, Strabone, 216, Erodoto, 230 chilometri (Scillax, in Geogr. Min., p. 90 dell’edizione Didot; Strabone, p. 612, Erodoto, IV, 86; Vedi sopra, pag.
Ora, sembra che qui si debba contare sulla velocità massima, perché il viaggio si compie in condizioni quasi soprannaturali: basta, in partenza, tenere la vela al vento: Borea subito la afferra, e conduce la nave a l’obiettivo, senza che il pilota debba preoccuparsi di nulla (1).
Borea, invece, è il vento di nord-est; è quindi a sud-ovest che ti porta; l’orientamento è molto chiaro, a patto di non accettare l’indicazione “nord-est” con la sua precisione moderna: Omero, infatti, conosce solo quattro direzioni principali dei venti, senza indicazioni divisionali (2).
(1) Odissea, alza il tuo albero maestro, spiega le tue vele bianche e siediti lì. Il soffio di Borea guiderà la nave.»
(2) Sappiamo che questi quattro venti sono quelli del nord-est, del sud-est, del sud-ovest e del nord-ovest. Sarebbe sbagliato, a mio avviso, collocarli esattamente a 90″ l’uno dall’altro; ciò significa le quattro direzioni dei venti che più spesso prevalgono nel Mediterraneo orientale.
Distanza e orientamento ci vengono quindi indicati con sufficiente approssimazione.
Il fiume Oceano alle Bocche di Bonifacio
Sulla strada per la Terra dei Morti, come abbiamo detto, il navigatore, trasportato verso sud-ovest, ha l’impressione che, ad un dato momento, stia cambiando mare; passa dal Mar Tirreno nel fiume Oceano e si sente trascinato dalle correnti di quest’ultimo. Si tratta di un’indicazione molto chiara e ripetuta tre volte (1).
(1) Odissea, X, 508; XI, 13, 639; XII, 1 e 2.
La questione che dobbiamo risolvere è quindi innanzitutto questa: in quali punti possiamo lasciare il Mar Tirreno navigando verso sud-ovest?
In due punti; a sud della Sardegna, a nord delle stesse fecce.
Il Sud della Sardegna innanzitutto; Dovunque altro chiuso dalla Sicilia, dall’Italia, dall’Isola d’Elba, con l’arcipelago toscano, dalla Corsica e dalla Sardegna, qui si apre il Mar Tirreno, tra Trapani e Capo Carbonara, per quasi 300 chilometri; ma il passaggio è così ampio che nulla dà al navigatore la sensazione di cambiare mare; ha bisogno di una mappa moderna per realizzarlo. Inoltre non c’è terra nel nord-est ad una distanza adeguata da cui possa provenire. Per questi due motivi, questo risultato non risponde ai dati della poesia.
Nel nord della Sardegna la situazione è ben diversa. Innanzitutto l’arcipelago toscano presenta diverse terre alla distanza e nella direzione desiderata; Torneremo più tardi. Poi, il marinaio che, scendendo da nord-est, ha costeggiato la Corsica e vede profilarsi davanti a sé le coste sarde a perdita d’occhio, questo marinaio ha dapprima l’impressione di un bastione infinito che gli sbarra la rotta da ovest; ma all’improvviso, alla sua destra, la costa sprofonda; tra i Lavezzi e i Razzoli si fa la svolta.
Qui, a ovest, le onde raggiungono l’orizzonte. La barca viene trascinata dalle correnti dello stretto (altre volte queste correnti sono abbastanza potenti (1) da bloccare l’accesso); man mano che avanza, l’orizzonte si allarga in avanti, mentre la minima deviazione a destra o a sinistra chiude la terra alle spalle.
(1) Vedi Istruzioni Nautiche, n. 563, per la Sicilia e la Sardegna, p. 228.
È un mare nuovo, sono altri cieli.
La situazione è del tutto analoga a quella delle Colonne d’Ercole. Qua e là, seguendo le correnti di uno stretto
stretto, di fronte a un mare infinito a ovest, l’antico navigatore dovette credere di essere arrivato alla fine del mondo, e al fiume Oceano che circonda il mondo con le sue correnti. Qua e là, al di là dello stretto, le terre di destra e di sinistra gli sembravano le ultime terre d’occidente, quelle che, nelle sue credenze, danno asilo ai morti, a coloro che sono andati nell’ombra dell’eterno tramonto.
Al di là delle Bocche di Bonifacio, i Morti abitarono, almeno per un certo periodo, le coste sarde. Senza dubbio i Fenici dell’Africa e dell’Iberia appresero presto dai loro fratelli del Mar Tirreno che l’Oceano era molto più a ovest. Ma bastò l’antica credenza a creare la leggenda che Omero avrebbe poi realizzato. L’inferno dei Feaci era nelle ultime terre dei Feaci, come l’inferno greco c’era stato in Epiro nelle ultime terre greche, come sarà l’inferno mediterraneo nelle ultime terre del Mediterraneo.
La Terra dei Morti oltre le Bocche, nelle terre occidentali. Capo Érébantion
Quindi attraversiamo le Bocche con la nave di Ulisse.
Innanzitutto, in corrispondenza dello stretto stesso, uno dei punti estremi della Sardegna, Capo della Testa porta il nome molto significativo di Érébantion, capo di Erebus, ovvero Erebus opposto. È dunque lì vicino che comincia il paese del tramonto che non finisce mai.
Poi quaranta chilometri a sud-ovest, il Coghinas e i suoi dintorni sono serviti sicuramente da modello per la descrizione omerica.
La descrizione omerica
Rileggiamo innanzitutto, raggruppate e ordinate, le indicazioni topografiche fornite dai testi:
«Sulle rive del fiume Oceano ci sono il popolo e la città dei Cimmeri, sempre avvolti nelle nebbie e nella nebbia; non vedono il sole né al sorgere né al tramontare; una notte perniciosa si stende su questi uomini, tremanti di paura. Lì approdati, seguiamo l’oceano spingendo davanti a noi le nostre pecore, fino ad arrivare (XI, 13-22) ad una riva bassa e presso la quale pioppi e salici sono il bosco consacrato a Persefone (X, 509, 510), poi alla disgustosa dimora dell’Ade» (X, 512).
La sua traduzione in stile geografico moderno
È nel luogo dove nell’Acheronte scorrono il Pyriphlégton (l’incendio), e il Gocita (il pianto), deviazione dell’infernale Stige (1).
(1) Lo Stige su cui giurano gli Dei è un fiume dell’Inferno sotterraneo; è molto probabilmente l’unico fiume dell’Enter preomerico.
La descrizione omerica
C’è una montagna rocciosa, poi la confluenza di questi due fiumi sonori. Avvicinati a tutto nelle vicinanze (X, 513516). Scava una fossa, immola le tue vittime (X, 517-527); vedrai i Morti, precipitarsi dall’Erebo, errare sul prato degli asfodeli, poi scomparire nel tempio dell’Ade (XI, 37, 539, 150, 627).
Traduciamo queste indicazioni in stile geografico moderno:
Nel mare che si estende ad ovest delle Bocche di Bonifacio si trovano una costa e una città esposta a nord (1). Il nome degli abitanti esprime l’idea di terrore e di oscurità.
(1) La prova che qui l’assenza del sole indica innanzitutto e principalmente l’orientamento verso nord, è nel testo. È al mattino o alla sera che un sito esposto a nord ha la possibilità di avere un po’ di sole: e sono proprio il sole che sorge e il sole che tramonta che non si verificano tra i Cimmeri. Se il poeta avesse in mente innanzitutto l’oscurità opaca, parlerebbe qui del sole nel momento in cui è più penetrante, del sole a mezzogiorno. In secondo luogo, la Terra dei Morti, situata qui, gli fa accentuare la nota e lo porta a parlare di nuvole sovrastanti e di notte infinita.
Il tempio di Ade è al massimo a poche ore di cammino. Seguiamo dapprima la sponda marittima, e incontriamo una costa bassa, poi un bosco di alberi che amano i terreni umidi. Non lontano c’è l’Acheronte (fiume pestilenziale o stagno paludoso secondo la tradizione). Più in alto è formato da due fiumi, uno dei quali porta il nome del fuoco e l’altro ricorda i gemiti. Quando risaliamo questo fiume, o quando arriviamo sopra questa palude, troviamo sia una montagna rocciosa che la confluenza dei due fiumi. Qui si trova la «casa di Ilades», vale a dire, secondo tutto l’episodio, un tempio del dio infernale, famoso per le evocazioni dei Morti che vi vengono praticate. I pascoli vicini sono punteggiati di asfodeli. Tra gli alberi della regione si trovano il salice e il pioppo.
E ora trasportiamoci a Castel Sardo, unico porto della costa nord-occidentale della Sardegna insieme a Porto-Torres. Il sito è rivolto a nord, come richiede il testo. Inoltre la città è adagiata su un ripido promontorio, fiancheggiato alle spalle da due marine laterali e attaccato alla terraferma da una regione bassa che la rende facilmente difendibile; ben si adatta quindi ad un insediamento omerico, migliore anzi di Porto-Torres, dove una postazione sarebbe alla mercé degli assalitori provenienti da terra. Non conosciamo il nome originario di Castel Sardo; ma siamo nelle vicinanze, e forse anticamente in dipendenza, di Sassari, il cui nome i Logudoriani pronunciano Tâtari; e per questo nome lo storico Vico propone la forma primitiva Tartari con il significato di gente della Terra dei Morti (1); ora la radice di Tartaro, uno dei nomi greco-italici dell’inferno, esprime soprattutto, per i greci, l’idea di terrore e paura (2): l’epiteto di ozCkzi tremante di paura, applicato da Omero agli indigeni, può trovare lì la sua spiegazione; ed anche il loro nome Cimmeri che, nelle lingue semitiche significa gli oscuri e per estensione, gli infernali (3).
(1) Lo vede come prova dell’invasione degli Iberici da Tartesso e dalla Terra dei Morti in Spagna.
(2) È la ripetizione del radicale xap, guaio, paura.
(3) Questo significato è tanto più chiaro in quanto il poeta stesso ne ha dato la traduzione nell’espressione vû^ ôXoy] (notte perniciosa) alla quale giustappone.
Sei chilometri a est di Castel Sardo, inizia una regione bassa, paludosa, pestilenziale, una delle più malsane dell’Isola.
Lunga parecchie leghe, la sua costa marittima si eleva appena al di sopra delle onde; è costituito da dune aride o invase dalla rachitica vegetazione della macchia mediterranea. Alle spalle si estende un vasto paese pianeggiante di circa trenta chilometri quadrati. Per la maggior parte, a ovest e a nord, è un insieme di paludi, qua e là ricoperte da gruppi di pioppi, da numerosi salici e dalla vegetazione arborescente della maremma; nella parte meridionale, la pianura relativamente arida offre ampi pascoli privi di alberi, ma seminati a profusione con asfodeli e chamterops nani, due piante caratteristiche dell’isola. Nella regione paludosa si snoda, suddiviso in numerosi canali, languido in pigri meandri, uno dei principali fiumi della Sardegna, il Coghinas che poco più in alto delimita la regione arida. Sul margine nordorientale delle paludi, il Coghinas riceve il suo ultimo affluente, il RM Balbara. Al di sopra della confluenza, una serie di costoni rocciosi abbastanza ripidi sviluppano un fronte circolare di diversi chilometri, e portano a un’altezza di seicento metri fino al punto più alto, Punta Bianca. Vigorosamente staccato e ancora alto duecentocinquanta metri, uno di questi crinali si protende sopra il Coghinas e ai suoi piedi si estende il confine comune alle paludi e ai pascoli: è il Monte Nuraghe (1).
(1) Questo sito, peraltro molto largamente disegnato dalla natura, si ritrova molto bene nella mappa dello Stato Maggiore italiano, f° 180, 1.
L’onomastica della regione
Inutile dire che questo paesaggio, unico per vaste dimensioni nel nord dell’isola, si adatta meravigliosamente alla descrizione omerica. Sono le acque pestilenziali, i fiumi fangosi o le paludi nocive, che il nome di Acheronte evoca da sempre. Si tratta dei due fiumi la cui confluenza è dominata da ammassi rocciosi; qui, inoltre, i nomi moderni corrispondono ancora ad appellativi omerici.
Il Coghinas (dal sardo coghere, cucinare) è letteralmente un fiume infuocato; Inoltre deve il suo nome ad una sorgente molto calda (2), abbondante e famosa. Etimologicamente Balbara designa un torrente balbettante o balbettante; non è lontano di là il fiume lamentoso o piangente che è il Cocito; anche il Balbara è un torrente, quindi un fiume rumoroso. Emozionante poi trovare a Punta Bianca una montagna bianca, tutta di tradizione infernale e che riproduce il nome della Petra Leucas dell’Inferno Epirote.
(2) È 74°; si trova ai piedi di Castel Doria, molto vicino alla regione qui descritta.
Infine, il monte Nuraghe, questo sperone che vede in lontananza le ombre errare per il vasto prato, non ha conservato nel suo nome la memoria di un tempio del dio dei Morti? Non è proprio questo ciò che indica questo nome comune nuraghe, divenuto qui nome proprio? I nuraghi, questi misteriosi monumenti di cui è ricoperta l’isola, sono infatti, ancora oggi, per i sardi, domos di Orcu, essendo Orcu il nome generico dei giganti trucidatori e cannibali considerati i più antichi padroni dell’isola. (1). D’altronde non c’è bisogno di ricordare che Orcus è anche l’antichissimo nome latino o italiano del dio infernale, l’equivalente di Ade presso i greci. Questi due nomi sono ancora più vicini nelle loro forme antiche: Verrius Flaccus, il più stimato grammatico del regno di Augusto, indica che la forma primitiva del nome infernale era Uragus e Urgus (2);
(1) La Marmora, Viaggio in Sardegna, p. 121; Spano, vocabolario Sardo,”Orcu”.
(2) In Festiis, XIII, v» Orcus. Uragus è forse legato alla radice ebraica hârag che significa uccidere. Anche l’inferno visto come mostro antropofagico è una concezione molto semitica. — Se accettiamo l’origine semitica di Uragus, forse nuragh diventerebbe il luogo di Uragus {domo de Orcii), la lettera n talvolta serve (ma solo in assiro-babilonese e in casi particolari) come prefisso locativo, ruolo ordinariamente svolto da la lettera m.
dal canto suo Orcus, nome dei primitivi sardi, aveva le forme Orgus e Ogriis (1).
(1) Cfr. Orgilè Città sarda fondata dai Tespi, che fondarono anche TXïi in Beozia. Secondo Festo, originariamente o e u erano usati in modo intercambiabile.
Gli indigeni Orci, costruttori di Nuraghi e adoratori dei Morti
Alla fine i due nomi si fondono e le due leggende sembrano fare lo stesso, essendo il dio della morte per eccellenza il grande divoratore di uomini. — Aggiungo di sfuggita, perché l’informazione non sembra priva di interesse, che possiamo paragonare Horciis, grafia meno comune del nome infernale, a Gorgone; Gorgone ha anche un’altra forma italiana, Urgo, conservata nel nome dell’isola toscana. La Gorgone infernale, di cui Ulisse teme l’aspetto (2), sarebbe quindi una divinità sarda, distinta dalla Gorgone mauritana (3).
(2) Odissea XI, in fine.
(3) A meno che non esista tutto un gruppo di leggende comuni alla regione oltre le bocche di Bonifacio e a quella che è oltre lo stretto di Gibilterra. Questa comunità, che mi sembra probabile, potrebbe senza dubbio spiegarsi con il fatto che esistevano qua e là due estremità del mondo fenicio.
Sua identificazione con i dintorni del Coghinas
Insomma, la toponomastica e la topografia concordano nel ritenere nei dintorni del Coghinas il luogo omerico dell’Evocazione dei morti.
In modo analogo il signor Ettore Pais ha pubblicato un importante studio sui nuraghi, di cui ecco la conclusione, per noi piuttosto interessante (ij: «I nuraghi, che non furono mai abitazioni, furono dapprima monumenti mortuari, eretti per onorare la memoria dei capi defunti e divennero così i centri religiosi degli antichi abitanti della Sardegna, che talvolta adottarono le stesse forme nelle loro opere di difesa. I nuraghi tombe e gli edifici religiosi sono quindi le più antiche, e di gran lunga le più numerose. I nuraghi fortezze non hanno perso, con ogni probabilità, il loro significato funerario. In ultima analisi, i nuraghi sono opera di un popolo particolarmente dedito al culto dei morti, proveniente molto probabilmente dalle coste settentrionali dell’Africa.
Le credenze degli indigeni concordavano dunque con quelle dei navigatori che venivano dall’Oriente per fare delle coste sarde oltre le Bocche il paese di coloro che andavano all’ombra della Morte» (1).
(1) In Sardegna prima del dominio Romano. {Tutto l’Accademia Lincei, serie, t. 7, nota 1880-81). La conclusione del capitolo sui Nuraghi che riporto sopra è riassunta da M. Comparetti nei Transunti, 1881, p. 144.
Pensare di essere arrivati all’estremità occidentale del mondo, dove devono vivere i Manes, e di trovare proprio lì un intero popolo intento a onorare i defunti, ricoprendo il proprio paese di templi funerari e di «dimore dell’Ade» (2), non è forse qualcosa che colpisce vivamente l’immaginazione?
All’epoca in cui canta Omero, senza dubbio anche ai tempi di Ulisse, viveva la credenza della Terra dei Manes nella regione delle Bocche di Bonifacio: si sa che il mondo finisce molto più a ovest. D’altronde la Sardegna assunse, per i Fenici cercatori di metalli, e per i Feaci di Ischia in particolare, un interesse di tutt’altro genere.
(1) Odissea, XI, 155.
(2) Oggi in Sardegna si contano ancora più di 3.000 nuraghi.
Da Castel Sardo si potevano infatti raggiungere, attraverso il Sassarese, i giacimenti di piombo argenteo e zinco della Nurra. Abbiamo incontrato il principale, quello dell’Argentiera, a una cinquantina di chilometri di distanza. Sempre nella Nurra, in un luogo chiamato Rocca de sa Plata, ce n’era un altro: poi un terzo e un quarto, poche leghe a sud vicino a Bosa. Dal giacimento dell’Argentiera si ricavano dai 3 ai 7 chili d’argento per tonnellata di galena. Porta tracce di sfruttamento molto antico.
Un’altra strada, antica quanto i commerci dell’isola, la attraversa da nord a sud passando per Sassari, Ploaghe, Oristano per terminare a Cagliari. Staccandosi da questo, a sinistra a Ploaghe, una strada secondaria si unisce nei pressi di Ozieri, a Nugheddu, ad un altro giacimento, e raggiunge tutto il gruppo intorno a Nuoro, dove oggi conosciamo le miniere di Dorgali, poi quelle dell’Argentiera, Gosurra e Sus Enattos.
A sud, tra Oristano e Cagliari, la strada principale lascia a destra la regione di Iglesias, particolarmente ricca di miniere, e a sinistra la regione di Lanusei, quasi altrettanto dotata.
Che i Fenici delle colonie africane ed i Fenici di Tebe conoscessero e sfruttassero queste miniere non può essere messo in dubbio, secondo quanto ci insegnano Pausania e Diodoro da Aristeo, Dedalo, Norace e Iolao (1). È evidente che né l’uno né l’altro vennero a praticare l’arte pastorale in Sardegna.
La stazione commerciale di Persefoneia
È lo stesso con i nostri Feaci: se vengono nella Terra dei Morti, è per procurarsi argento e piombo, forse anche zinco, che forse sono entrati nella composizione dei loro bronzi. Sicuramente sfruttano i giacimenti della Nurra di cui Castel Sardo è il punto di imbarco sulla costa settentrionale. Non possiamo dire, almeno per il momento, se ne pratichino altri, né se i discendenti di Norax, stabiliti nel sud, diano loro accesso alla regione di Iglesias.
Ma Omero ci insegna, in modo misterioso e tuttavia certo, che i Feaci devono la vera prosperità e la vera ricchezza al paese di Persefoneia.
Questa affermazione, che chiariremo più avanti, non lascia dubbi sul fatto che in gioco ci siano le miniere sarde.
Una semplice osservazione prima di dire addio alla Terra dei Morti.
L’Iliade conosce solo l’inferno sotterraneo, il Tartaro, dove scorre un unico fiume, lo Stige. L’Odissea stessa, oltre a Nostos, conosce altre due terre dei Morti; uno, legato all’episodio egizio-fenicio di Proteo, è presso le colonne d’Ercole; l’altro, appartenente a Mnesterophonia, si trova a nord-ovest di Itaca e della Grecia vera e propria. In questi vari regni delle Ombre, Acheronte, Piriflegetonte e Cocito sono sconosciuti; eppure nel periodo classico tutti e tre saranno parte integrante dell’Inferno greco da dove passeranno nell’Inferno latino. Allo stesso tempo, i luoghi e i templi dedicati all’Ade o a Plutone faranno in modo di avere nei loro dintorni un fiume o un lago Acheronte, o anche un Flegetonte o un Cocito (1).
Ritornando dalla nostra escursione al Coghinas sembra facile spiegare questo contrasto.
(1) Cfr., su questa diffusione postomerica dei nomi infernali, Daremberg e Saglio, Dlcl. delle Antichità, v^ Inferi, sotto la firma Dlrrbach, p. 502.
Influenza della descrizione omerica sulla mitologia infernale
Interpretando la credenza generale che collocava i Morti nell’occidente del mondo, un’antica leggenda feacia li faceva abitare nel nord-ovest della Sardegna. Arriva poi Omero che, in onore di una stazione commerciale stabilita nella regione, inquadra l’antica leggenda nel paesaggio di questa stazione commerciale e dota quello che possiamo chiamare l’ingresso dell’inferno feaciano di paludi e fiumi tratti da Castel Sardo.
Essendo questo inferno estraneo alla razza greca e di interesse tutt’al più per i calcidesi emigrati in occidente, la questione avrebbe dovuto finire lì. Ma per caso, Omero, grazie al suo genio, diventa, pochi secoli dopo la sua morte, il poeta nazionale dell’antica Grecia; non poteva aver cantato che greci e tradizioni greche; di conseguenza, il suo Feacio Acheronte, il suo Cocito e il suo Piriflegetono furono naturalizzati greci e divennero parte integrante della mitologia greca; da lì passarono alla letteratura latina e a tutte le letterature derivate, dove divennero, con molti abbellimenti, fiumi del regno sotterraneo di Plutone.
Fu così che, senza sospettarlo, il divino Omero introdusse nelle credenze dell’oltretomba elementi del tutto nuovi, e costrinse i morti dei secoli successivi ad attraversare fiumi formidabili, per poi salire sulla barca di Caron, e pagargli un diritto di passaggio, che complicò notevolmente il loro viaggio. Così, in ultima analisi, sono nati certi miti greci dalla fantasia di un poeta.
LA TERRA DEI LESTRIGONI
Qui, nel poema, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al momento in cui Ulisse, che ha lasciato Eolo e sta per arrivare a Itaca, viene brutalmente spinto verso ovest a Marittimo da una tempesta di sud-est. Eolo si rifiuta di riaprirgli la strada verso la Grecia e gli dice di andarsene al più presto. Probabilmente ripreso dal vento che lo aveva spinto lungo la Sicilia meridionale, Ulisse prosegue esattamente nella stessa direzione, arrivando nel sud della Sardegna. Da questo punto in poi, la linea generale delle coste è troppo inclinata rispetto al vento e la navigazione finisce in un mare particolarmente difficile e pieno di scogli. Probabilmente per questi due motivi, «bisogna remare molto, come dice Ulisse, tanto che i marinai sono scoraggiati da questa fatica (1)».
(1) Odissea, X, 78.
Grazie a questa osservazione, possiamo capire perché il viaggio dura sei giorni interi, anche se, a uno sguardo alla mappa, sembra che ne occorrano solo quattro.
La Baia del Massacro si ritrova tratto – tratto a Porto-Pozzo
«Il settimo giorno arrivammo all’alta fortezza di Lamos… Qui ci troviamo in un porto incorniciato simmetricamente a destra e a sinistra da nude masse rocciose; alte rive che si fronteggiano si chiudono verso l’ingresso, lasciando solo uno stretto passaggio tra di loro. Le navi affondano e ormeggiano l’una accanto all’altra; tutt’intorno è calma piatta, il mare dorme immobile.
Per quanto mi riguarda, rimango fuori da solo; sul bordo, lego la mia cima a una roccia. Poi salgo su una collina ripida. Da lì non scopro né il lavoro degli uomini né quello dei buoi, così mando due compagni e un araldo a scoprire quale popolo mangia il grano di questa terra. Seguono una strada facile, dove i carri scendono tra i boschi delle alte montagne. All’inizio della città incontrano una fanciulla che va a prendere l’acqua: è la figlia del Laîstrygon Antiphates, che sta scendendo ad Artakiè, la fonte di acque bellissime a cui attingono tutti gli abitanti.
Mostra loro la casa superiore del padre, l’anax locale. In questa nobile casa, si trovarono faccia a faccia con una donna alta come una montagna e furono terrorizzati. Questa donna chiama in fretta suo marito che era nell’agorà. Afferrando uno dei miei uomini, Antifate lo divora. Poi lancia un grido in tutta la città. Alla sua voce, i potenti Lestrigoni corrono a migliaia, non avendo l’aspetto di uomini, ma di giganti. Dalla costa lanciano contro le navi enormi massi e subito, nel profondo del porto, si scatena un terribile tumulto di moribondi e di navi sfasciate. Allora trafiggono come pesci i miei compagni e li portano via per un banchetto ripugnante. Quanto a me, taglio la cima della mia nave e ordino ai miei compagni di chinarsi sui remi. Siamo scappati attraverso una pioggia di sassi, ma tutti gli altri erano morti lì!» (1).
È sulla costa nord-occidentale della Sardegna, di fronte all’isola della Maddalena, nell’insenatura di Porto Pozzo che l’eminente autore de I Fenici e l’Odissea ha scoperto la Baia della Strage (2).
(1) Odissea, X, 81-132.
(2) Di tutte le navigazioni di Ulisse, è l’unica per la quale il secondo volume di M. Bérard, notevole sotto tanti aspetti, mi porta a modificare le mie opinioni personali.
Porto-Pozzo è un lungo corridoio roccioso lungo più di tre chilometri, con sponde alte e talvolta ripide; la sua larghezza massima è di settecento metri; più stretto, il suo ingresso è a meno di quattrocento metri, ed è anch’esso ostacolato da scogli.
Tutte le parole del testo si applicano ai dettagli dei luoghi; possiamo benissimo immaginare, in una simile trappola, il disastro raccontato da Ulisse, tanto più che qua e là, sulle rive, grandi massi di granito, appoggiati a filo del suolo, danno l’impressione di enormi proiettili, usati anticamente in una gigantesca lotta.
Una decina di chilometri più ad est, alla fine dell’insenatura di Palau, sgorga una sorgente che da tempo rifornisce d’acqua la vicina isola della Maddalena. Il signor Bérard fa, non senza plausibilità, la fontana omerica, e colloca nelle sue vicinanze Telepyle, che è, per lui, la città indigena «dalle porte larghe».
Cinque chilometri più in là, la Punta dell’Orso disegna nel cielo la riconoscibilissima sagoma di un orso, e l’autore senza esitazione trova un orso dell’Orso sotto il nome di Artakiè; ma possiamo avere dubbi sul significato di questo termine.
A nord del Pozzo si trova lo scoglio Colombo; qualche decina di chilometri più a sud incontriamo un promontorio noto ai romani come Columbarium promontorium. Tutta la costa è popolata anche da innumerevoli uccelli marini; ora se vogliamo accettare un’etimologia greca per il nome del paese, Laistrygonia è, senza dubbio, uno scoglio o scogliera di Les Palombes.
Certamente, è un insieme sorprendente. Tuttavia, le profonde insenature scavate nella roccia sono numerose nel nord della Sardegna, e anche nel sud della Corsica. D’altra parte gli uccelli occupano un posto grandissimo nell’onomastica del Mar Tirreno, e sarebbe facile trovare su un’altra costa una terra delle colombe.
Infine, Artakié potrebbe essere altrove una fontana sospesa o una cascata, così come qui una fontana dell’Orso.
Per rafforzare la sua tesi, in un capitolo meravigliosamente scritto, l’autore [Bérard] aggiunge collegamenti a collegamenti. Ma poi lo troviamo più ingegnoso che persuasivo, e cominciamo a pensare che una o due indicazioni topografiche in più servirebbero molto meglio allo scopo.
Uno dei collegamenti da lui proposti riguarda un passaggio enigmatico, il più oscuro dell’intero episodio, e che ho omesso nella mia traduzione precedente. Alcuni vi ritrovavano le brevi notti estive dei paesi settentrionali, altri un regime pastorale metà diurno e metà notturno. Il signor Bérard preferisce vederlo come un’allusione a un genere letterario: la poesia bucolica già in onore tra i pastori sardi.
Le due mandrie al pascolo davanti alla Porta Profonda
Torniamo a questo brano che, all’inizio dell’episodio dei Lestrigoni, interrompe o ritarda le indicazioni topografiche di cui questo sarebbe il luogo. Faccio l’ipotesi semplicissima che, invece di ritardare queste indicazioni, questo brano le inizi; in altre parole, che anch’esso descriva un aspetto del luogo, ma velandolo sotto un’immagine; in questo modo ottengo un significato molto comprensibile: «Arriviamo all’alta cittadella di Lamos, e alla [baia chiamata] la Porta Profonda, sulla costa delle Colombe; in questo luogo dove [le rocce rappresentano] due pastori che camminano l’uno verso l’altro, il primo che ritorna con le sue mucche, il secondo che esce al suo richiamo con le pecore; certamente un uomo attento guadagnerebbe facilmente i loro due stipendi, perché i sentieri che seguono, uno verso occidente (1), l’altro verso oriente, sono molto vicini [e confonderanno le due mandrie]. Qui siamo in un porto incorniciato simmetricamente a destra e a sinistra da cumuli di rocce, ecc. ».
(1) Chi va verso occidente ritorna e va a tramontare come il sole (è il pastore che è sulla sponda orientale, ma è rivolto verso il tramonto).
Così intesa, la storia inizia in modo semplice e naturale: Ulisse nomina la siepe dove arriva, descrive l’ingresso con le sue caratteristiche rocce; poi entra nel porto e lo descrive a sua volta.
Eliminando le parole tra parentesi quadre che il testo suggerisce ma non scrive, il significato proposto diventa meno chiaro, ma resta, e la nostra ipotesi è ammissibile: è la descrizione dell’ingresso della baia che Omero ci ha appena fatto leggere; ed è proprio questo ingresso che egli chiama Telepyle il Lestrigone, cioè la Porta Profonda sulla costa degli Uccelli.
Facciamo ora riferimento al resoconto della visita che il signor Bérard ha fatto al sito; è tanto più convincente in quanto l’autore non sospetta ciò che sta descrivendo: «Ecco l’ingresso del Pozzo: la bocca, molto stretta, ha da ogni lato una sorta di mole naturale, la quale, perpendicolare alla riva, sporge i suoi blocchi caduti nel passo. Attraverso questo stretto, alcuni scogli rendono l’ingresso molto difficoltoso, a paiY] oWuoToç èo-TLv » (1).
(1) I Fenici e l’Odissea, II, p. 255.
I blocchi caduti, che avanzano gli uni verso gli altri, attraverso il passo, sono, secondo il contesto e le fotografie, rocce granitiche le cui forme sono state smussate, poi arrotondate, su tutti i lati e anche nelle loro fondamenta, dal tempo.
In un bel disordine di fianchi inclinati e creste arrotondate, sembrano appoggiati semplicemente sul terreno; al centro o in prossimità delle macchie di verde che coronano la scogliera, danno abbastanza bene l’illusione di una mandria al pascolo. Le rocce che pascolano sul lato del pilastro orientale sono le più grandi, e la carta dello Stato Maggiore italiano le chiama proprio le Vacche (1), le mucche, in perfetta conformità con Omero che colloca da questa parte il Bouvier. Ovviamente i sedici scogli a filo d’acqua indicati dall’Idrografia Italiana rivolti ad ovest, e quelli che, sulla riva, sono immediatamente sopra di essi, sono, per il poeta, le pecore che scendono dalla scogliera dirigendosi ad est.
(1) Vedi la carta 1:25.000.
Sembra certo, inoltre, che la fantasia dei pastori galluresi veda sempre le pecore omeriche sulla sponda occidentale. Percorrendo la regione in barca, il signor Bérard constata che, per il pescatore che lo conduce, il promontorio tracciato da questa riva si chiama Pointe aux Raies, punta dei Raggi. Ma per i marinai terrestri che hanno poco interesse per le zone di riproduzione dei pesci, i tre punti di questo promontorio hanno nomi completamente diversi; questi sono i suoi Cunchedda, li Roccii e sos Strupiddos.
Ora, in gallurese, una cunchedda è una di quelle grotte, così numerose sull’isola, che servono per ricoverare il bestiame; “lu rocciu” è il bastone del pastore; e “sos strupiddos” sono gli sfrenati, il gregge in libertà. Ovviamente questi tre nomi rispondono a dettagli topografici. Il parroco della vicina parrocchia di San Pasquale, signor Sotgiu, nel segnalarmeli, fa espressamente notare che Punta Cunchedda prende il nome da una grande grotta utilizzata per ospitare le mandrie.
Una stalla sotto la roccia, un pastore in piedi sulla scogliera, un gregge di pietre sparse lungo il pendio, non è forse questa tutta la parte occidentale della scena omerica? Inoltre, indipendentemente da questa convenzione universale che fa dell’occidente il tramonto, ecco una nuova e decisiva spiegazione delle mucche che entrano e delle pecore che escono: mucche e pecore hanno la loro stalla comune nella grotta di Punta Cunchedda.
In sintesi, qui sono perfettamente riconoscibili le due mandrie che camminano in direzioni opposte, una verso ovest e verso il ricovero notturno, l’altra verso est e i pascoli, le due mandrie molto vicine, e alle quali basterebbe un pastore attento a guardia.
E ora la fontana dell’Orso e la Costa delle Colombe, uniamole nella Porta Profonda questo nome così espressivo quando lo applichiamo all’ingresso della nostra baia, nome del resto quasi conservato nel nome moderno di Pozzo, il pozzo; riuniamo anche le due mandrie di pietre che ancora oggi pascolano accanto a questa porta; aggiungiamo tutto questo alla baia stessa così minuziosamente descritta; arriviamo ad un accordo dimostrativo dei dettagli, e Laistrygonia è veramente ritrovata.
Trasporto con carri
Che ruolo ebbe questa stazione della Sardegna nord-orientale per i nostri Fenici del Tirreno? Una parola del testo ci suggerisce tre ipotesi: «Recandosi verso la città, disse Ulisse, i miei inviati seguono la via facile per la quale i carri scendono dai boschi degli alti monti».
In una narrazione abbastanza breve, questo dettaglio è comprensibile solo se di particolare interesse.
Cos’è questo legno su cui Omero vuole attirare l’attenzione? Era forse legname per riparare le navi? Certamente no; le riparazioni devono essere effettuate in tutte le stazioni, ed è solo qui, per la prima e ultima volta, che Omero allude a tali trasporti. Non sarebbe piuttosto combustibile destinato ad una fonderia calcidese? È una legge costante della metallurgia del legno che i minerali trovino il combustibile molto più ingombrante da trasportare. Poverissima di metalli, la Gallura è ancora oggi ricoperta di foreste (1).
(1) A pochi chilometri da Porto Pozzo, l’attività principale della cala di Palau è l’esportazione del carbone.
D’altronde il territorio della Nurra è soprattutto un paese di pascoli. È quindi presumibile che i minerali provenienti dall’Argentiera giungessero qui via mare per trovare una fonderia stabilita nella terra dei boschi.
Ma la parola ulr, che abbiamo appena tradotto legno con tutti i commentatori, potrebbe avere un significato più interessante. In un senso abbastanza comune, significa in realtà qualsiasi materia di cui è fatta una cosa (1).
(1) Nell’Odissea, V, 257, sembra significare ciottoli che servono da zavorra.
Non si tratta forse, in qualche modo misterioso, di minerali portati su carri dal centro e dal sud dell’isola e che i nostri Feaci, prima della fondazione di Castel-Sardo, avrebbero imbarcato prima con i Laistrygon, costringendoli a un viaggio più lungo via terra?
Le due ipotesi di una fonderia e di un porto di metalli nella Sardegna nord-orientale sono perfettamente conciliabili.
Ma c’è di più. Antiche leggende registrate da Pausania ci dicono che, non lontano dal sito poi occupato da Olbia (2), i Tespiesi di Iolao vi avevano fondato, molto prima di Omero, una stazione, mentre i loro fratelli, rimasti in Beozia, vi avevano fondato una città].
Ogrile
La fondazione della Sardegna corrispondeva quindi, con ogni probabilità, a Hylé tra gli Ogri. Ora gli Ogri o Orci sono questi primitivi abitanti dell’Isola che abbiamo già incontrato, e ai quali le leggende attribuiscono una forza straordinaria e dimensioni gigantesche, questi primitivi abitanti imparentati con l’Orcus, l’insaziabile divoratore di uomini, e dai quali potrebbe discendere l’Orco dei nostri vecchi racconti (1).
(1) Questo collegamento esiste da molto tempo.
I Lestrigoni omerici sono ovviamente un’interpretazione di questo tipo fantastico. Sono sia giganti che uomini come voi e me. La figlia del re, incontrata alle porte della città, non è niente di straordinario, ma sua madre è come una montagna. La città e i suoi edifici non hanno nulla di anormale nelle loro dimensioni; ma, quando i loro abitanti arrivano alla riva, sono veri e propri giganti e, per di più, giganti cannibali. Sono proprio questi gli Ogri che ci ritrae Omero, e mi chiedo se non sia proprio Ogrhylé a mostrarceli, soprattutto allo scopo di ricordare il nome della vecchia fondazione tespica.
Il brano assume così l’aspetto di un rebus; ma cosa c’è di inverosimile in questo, dopo l’enigma delle due mandrie, soprattutto dopo il gioco di parole su “Nessuno”, che è ben caratterizzato, un po’ pesante, e piuttosto ciclopico? Non dobbiamo dimenticare che i greco-fenici, ascoltatori del poeta, annoveravano tra le loro glorie nazionali il famoso Edipo che doveva la salvezza e il trono di Tebe alla soluzione di un enigma. È evidente che avevano un certo gusto per questo genere poco letterario. Non rimpiangiamolo, però, perché è a una manifestazione molto superiore di questo stesso genere che dobbiamo, come vedremo tra poco, tutto il meraviglioso simbolismo di Nostos, e le cento allegorie affascinanti o terribili di cui il poema è pieno (1).
(1) Vedi oltre, p. 563 e segg.
In un testo misterioso e chiaro allo stesso tempo, Omero racconta quali stretti rapporti uniscono la Sardegna e Pianosa; allo stesso tempo conferma, e va oltre, quanto da me sostenuto sull’importanza delle miniere sarde per i Feaci:
«Circe, la potente dea, è sorella di padre e madre del saggissimo Aietes; entrambi sono nati da Helios che illumina i mortali, e da Perse che è figlia di Oceano» (2).
(2) Odissea, X, 137-139.
Qui siamo in presenza di una genealogia geografica, che è importante comprendere bene.
Spieghiamo innanzitutto i termini:
Circe è la femmina del falco. Sappiamo dove collocare Circe; questa traduzione quindi ci importa poco; tuttavia, ci fa supporre che anche il fratello sia un uccello rapace. — Infatti, è l’Aquila. Potrebbe anche essere che quest’aquila fosse un falco: scientificamente imparentati, il falco e l’aquila sono stati spesso confusi nel linguaggio comune. —.
Helios può designare, lo sappiamo, una città del Sole, e altrettanto facilmente una regione situata a sud.
Non sarebbe forse da escludere il Sole che illumina i Morti, e di conseguenza una regione abitata dai Morti? — La figlia di Oceano è una città bagnata dal mare al di là delle Bocche di Bonifacio. Il nome Persia non ha significato in greco; ma nelle lingue semitiche designa un rapace di specie indeterminata; quindi è difficile tradurlo esattamente.
Ma questa traduzione sembra superflua; infatti la Persia ad ovest delle bocche di Bonifacio, si identifica molto bene con «il porto presso il bosco di Persefoneia». È infatti facile notare che questo cognome, Ilspasçoveia o Ihpai, significa letteralmente Persiano l’assassino. Una variante del nome della dea infernale prova che questa scomposizione è legittima; è detto anche IlspasçaTTa, Persiano il Gabbiano o il Piccione; la traduzione così data del termine semitico può essere imprecisa (1), ma non è meno dimostrativa della composizione del nome. La Persia oltre le Bocche è quindi Castel Sardo. Ciò sembra certo, poiché il gabbiano non è omicida.
«Il Sole che illumina i vivi», se indica una regione diversa da Castel Sardo come è probabile, sembra essere lì a designare non tanto le miniere della Nurra, troppo vicine tra loro, quanto quelle della Sardegna meridionale, nella terra dei vivi, con cui i Feaci comunicano attraverso la stazione di Castel Sardo, moglie, cioè associata subordinata, delle miniere meridionali. Quest’ultimo termine indica chiaramente il ruolo essenziale, ma secondario, dei trasporti accanto alla produzione. Del resto né in Sardegna né nelle terre vicine sappiamo di nulla che possa essere una feccia o una città del Sole.
Resta infine l’Aquila o il Falco, fratello di Circe, nato dagli stessi genitori, cioè per la sua prosperità dalle stesse cause geografiche e sociali, e senza dubbio trovandosi nella sua stessa regione. Sembra facile riconoscerlo a Porto Ferrajo, il principale porto dell’Isola d’Elba, che si trova sulla penisola e ai piedi dello Scoglio del Falcone. La cittadella della città, sostenuta da questa altura, è ancora oggi Fort du Faucon (Forte del Falcone). Questa identificazione è ordinata per due motivi: in primo luogo il miglior porto dell’Isola d’Elba è, proprio come Pianosa, tappa indicata della rotta marittima che collega le coste della Corsica, e quindi della Sardegna, alle coste italiane. Omero poi, nell’unico accenno che fa agli Argonauti, dice che essi passarono per Stromboli «di ritorno da Aiètes» (1).
(1) Odissea, 70.
È tanto più presumibile che non si tratti del re della Colchide, ma del fratello di Circe residente a Porto Ferrajo, poiché quest’ultimo porto fu per lungo tempo chiamato porto Argô; «gli Argonauti», ci dice Strabone (1), «si erano fermati lì nel momento in cui cercavano di scoprire la residenza di Circe”.
(1) Strabone, 224
Non è interessante vedere questo nome di porto e questa leggenda ricordare all’Elba il dimenticato quartiere di Circe, mentre per secoli la maga fu collocata trecento chilometri più a sud?
In definitiva, la genealogia geografica di Circe è stabilita come segue: «Lo sparviero ha le stesse ragioni di prosperità del Falco, suo fratello e suo vicino. La loro ragion d’essere, per entrambi, sono le miniere del sud e il porto della Persia». O : «Gli stabilimenti di Pianosa e Porto Ferrajo devono la loro esistenza e prosperità alle miniere della Sardegna, i cui prodotti vengono spediti a Castel Sardo.»
Da questo testo emergono chiaramente due cose: da un lato, l’importanza della via insulare per le antiche marinerie, che erano così riluttanti a perdere di vista le coste, e trovavano impraticabili, nella pratica attuale, i vasti spazi che separavano la Sardegna dalla Campania in linea retta; d’altra parte è il notevole traffico mantenuto con le miniere sarde dai nostri Feaci, maestri della navigazione tirrenica: si trovò sulla loro rotta un’isola molto modesta, e questo bastò perché si arricchisse; Omero non disdegnò di cantarla e gli Argonauti partirono alla sua ricerca.
È vero che, sulla strada per le miniere sarde, quest’isola non era una tappa qualunque. Situata enh-e rilalica a Oriente, Corsica e Sardegna a Occidente, Circe era allo stesso tempo l’anello di congiunzione tra queste due parti del piccolo mondo tirrenico, l’ultima stazione prima delle grandi terre d’occidente, e la sentinella preposta a impedirne l’accesso. agli stranieri.
Il ruolo che la Sardegna ha giocato qui in miniatura, Cuba lo giocherà più tardi, in forma molto più grande, per la Nuova Spagna di Cortez, le isole di Capo Verde per l’Africa di Barthélémy Diaz, il Capo di Buona Speranza per le Indie di Vasco da Gama, Malacca per l’Insulindia dei portoghesi e degli olandesi. Ciò spiega l’imprevista importanza di Pianosa nelle navigazioni dei Feaci. Successivamente, i cambiamenti negli itinerari la porteranno nell’ombra. Allo stesso modo, ai nostri giorni, e per ragioni simili, Cuba, le isole di Capo Verde, Capo e Malacca hanno effettivamente perso il loro ruolo storico.
In un ordine di idee molto diverso, notiamo ora che, per Omero e certamente anche per i suoi ascoltatori Feaci, la famiglia di Circe non è altro che un’espressione geografica rivestita di forme poetiche. Tuttavia, il caso non è isolato nell’Odissea. Sappiamo che ad esso sono legati tutta una serie di antropomorfismi, il cui vero significato si è perso prima dell’epoca classica e che i mitografi antichi e moderni hanno preso, del tutto erroneamente, alla lettera.
Cogliamo così infatti la nascita di alcuni miti greci risalenti all’Odissea; e questa è un’osservazione più interessante che mai, ora che è del tutto naturalmente simile a quelle che abbiamo fatto prima a proposito del meraviglioso che riguarda Circe. In questi due casi, come anche in un terzo, nel caso dei fiumi infernali, ci troviamo di fronte a semplici processi poetici di cui Omero non sospettava le conseguenze. Si comincia, mi sembra, a intravedere una sintesi che formuleremo poco più avanti. È in relazione alle nostre tre sedi in nuovi paesi che la spudoratezza delle identificazioni tradizionali si manifesta più ingenuamente. I Lestrigoni sono collocati a Mola di Gaeta, l’ancien Formies. Ora, a questo punto, la costa declina in una curva ad ampio raggio, senza il minimo taglio; non c’è, e non c’è mai stata, una baia che si estenda nella terra. Per trovare una laguna tutta sabbiosa bisognerebbe percorrere sei leghe ed oltrepassare Fondi. Con la migliore volontà del mondo, Ulisse non avrebbe potuto commettere a Mola l’imprudenza che fu così fatale alle sue navi.
È Monte Circello, una quindicina di leghe a ovest, che solitamente ha l’onore di ospitare la maga Circe. Eppure questo promontorio alto e largo, collegato alla massa del continente da una base molto più ampia e che si allarga sempre, non ha nulla in comune con «un’isola bassa, piccola, circondata da una vasta distesa di mare». Sarebbe necessario attribuire a questo sollevamento una grandezza non plausibile; infatti, da un lato, l’altitudine dietro al Monte-Circello. Monte-Circello, oscilla tra i sedici e i ventiquattro metri e non è mai inferiore ai tredici metri; dall’altro lato, questa regione non solo non si è innalzata, ma al contrario si è abbassata, come dimostra la recente formazione delle vicine Paludi Pontine, e la sommersione del lago romano sommerso nel Lago di Paola, proprio ai piedi del Monte-Circello.
Infine, la Terra dei Morti si trova nei Campi Flegrei tra Pozzuoli e Baia; e anche in questo caso non c’è nulla a sostegno del testo. Non solo non c’è un cambio di mare, né oceano con grandi correnti, ma non ci sono né paludi, né due fiumi, né un solo fiume; nessuna confluenza, nessuna roccia al di sopra della confluenza, nessun prato di asfodeli, nessuna regione insalubre.
E quanto è improbabile collocare i Morti in questa esuberanza di vita, in questo splendore di luce, accanto ai luoghi incantevoli di Baia, che Roma, così opportunamente, ha reso un luogo di delizie! Va da sé che l’orientamento relativo di Circe e della Terra dei Morti, l’orientamento così chiaramente indicato dal testo, è diventato completamente impossibile. Invece di trovarsi a nord-est dell’Inferno, Circe è semplicemente a 90” da lì, nel mezzo del nord-ovest. Infine, non ha senso tornare indietro passando per Monte-Circello, come farebbe Ulisse, per dirigersi verso sud (1).
(1). M. Bérard propone le identificazioni che ho appena indicato per i Lestrigoni, i Ciclopi e Cariddi-Scilla (per quest’ultima tutti sono d’accordo). Ma colloca l’Inferno al Lago d’Averno nei Campi Flegrei, Circe al Monte Circello, le Rocce Vaganti a Saiina, le Sirene ai Galli, Eolo a Stromboli, il porto del Sole a Messina, i Lotofagi a Djerba e Calipso a Péréjil.
Rimane, ovviamente, fedele ai suoi Feaci di Corfù. Del resto a Ischia lanciò soltanto uno sguardo distratto. Perché prende Porto di Bagno per un porto naturale e naturalmente troppo aperto. Tuttavia, sempre e fino al 1856, Porto di Bagno fu un lago interamente chiuso e senza comunicazione con il mare. Fu aperto nel 1856, ma ovviamente il meno possibile; Ho notato che è ancora molto chiuso; Del resto la mappa non lascia spazio a dubbi.
Non posso fornire qui una critica dettagliata delle identificazioni del signor Bérard. Mi limito a notare in generale che egli attribuisce troppa importanza alla toponomastica. D’altra parte, nonostante le sue proteste di oltraggioso omerismo, spesso trascura le realtà geografiche, i dettagli della topografia, le direzioni e la durata degli itinerari. Tuttavia, quando ammettiamo, come lui, che Omero lavora su documenti scritti, redatti da marinai, dovremmo credergli; distanze e direzioni, questo è ciò che interessa di più agli scrittori di viaggi!
Io ho fatto il contrario, attenendomi pedissequamente al testo e utilizzando le etimologie solo con sobrietà. Penso di averlo trovato buono. — Anche le indicazioni sociologiche, sistematicamente disprezzate dal signor Bérard (I, 578), mi furono molto preziose […]
Da lì, su indicazione di Eolo che «prepara il suo ritorno», tenta di raggiungere la Grecia attraverso le coste meridionali della Sicilia. È già lontano quando un uragano di sud-est lo riporta a Eolo. Ciò gli vieta quindi ogni ulteriore tentativo verso la sua patria. Raccolto dal vento di sud-est, Ulisse arriva nel sud della Sardegna, risale verso nord, e si ferma a Porto-Pozzo tra i Lestrigoni. Dopo il disastro prese la strada del nord e arrivò a Pianosa. Lì, dopo tre giorni, si ricompose, ma dichiarò ai suoi uomini che era assolutamente perduto, disorientato, che tutte le strade sembravano chiuse sia a nord che a sud e che non sapeva più quale direzione prendere (1).
Per fortuna siamo a casa di Circe. Il mago lo manda prima ai Morti, alle Bocche di Bonifacio e a Castel-Sardo, da dove, come lei afferma, potrà tornare solo per vie costiere, passando di nuovo per lei. Poi accetta anche di prepararsi per il suo ritorno, cioè di dettargli la rotta. Gli rivela poi che l’unica via praticabile per raggiungere la Grecia, senza abbandonare la sua nave, è, nonostante i pericoli, quella dello Stretto di Messina. […]
Importanza imprevista della Sardegna in tutto questo
Ora, in questo mare, i paesi da sfruttare dovrebbero essere le miniere toscane, ricche di rame, anche d’argento, e perfino di stagno; il Nostos non se ne occupa. Potrebbero estendersi alla Corsica dove i giacimenti sono ancora molto apprezzabili; il Nostos non se ne occupa più. Si può supporre che le miniere corse, appartenenti soprattutto al nord-ovest dell’isola, non siano state scoperte. Quanto a quelli dell’Etruria, i nostri Feaci non possono né ignorarli né considerarli trascurabili.
Se Omero le passa sotto silenzio è perché la Sardegna assorbe tutta la sua attenzione.
A cosa è dovuta questa preferenza esclusiva?
Non possiamo dirlo per il momento, ma il fatto è lì; dei paesi produttori del Mar Tirreno, la Sardegna è l’unico a cui ci conduce il Nostos.
E subito viene in mente un collegamento: questa preferenza esclusiva di Omero per la Sardegna è in perfetto accordo con la più antica tradizione greco-tirrenica, secondo la quale le prime spedizioni partite dalla Grecia per i mari d’Occidente, portavano anche in Sardegna (l) .
È soprattutto attraverso le coste dell’Africa e della Sicilia che sembrano esservi giunte le spedizioni di Aristeo, Dedalo e Iolao, ma anche quella del fenicio dell’Iberia, Norace. Ma Iolao fondò anche le stazioni di Ogrhylé e di Olbia al nord, orientate verso le isole toscane e la rotta verso l’Italia; inoltre fu attraverso Cuma che Aristeo ritornò in Grecia; e più tardi i discendenti di Iolao, in seguito alle sconfitte in Sardegna, emigrarono in parte a Cuma, lasciandone però alcuni in Sardegna.
Naturalmente la critica, con grande disprezzo, tratta tutto questo come favole; ritiene dimostrato che i primi coloni partiti dalla Grecia per Cuma vi arrivarono solo nell’VIII secolo; e il buon senso vuole che la Corsica e la Sardegna non sarebbero state raggiunte se non molto tempo dopo.
Sappiamo anche che la dominazione fenicia in alcune regioni della Grecia, e l’espansione fenicia dalla Grecia, non esistono per molti dei nostri signori. Ma già per la prima volta, a proposito di Cuma e Ischia, Omero, questo sognatore, questo fantasista come tutti sanno, diede a queste belle affermazioni una smentita tanto netta quanto inaspettata. Conosceva i Greci di Calcide che giunsero ad Ischia intorno all’XI secolo, e lì si unirono ai Tebano-Fenici, che si erano stabiliti a Cumes in epoca molto precedente.
Ed ora, questo stesso Omero registra, tra la Sardegna ed i discendenti di questi antichi fondatori di Cuma trapiantati ad Ischia, stretti rapporti, così stretti anche che ritiene inutile parlare, dopo di ciò, degli altri parenti di Scheria. La precedente espansione della razza verso la Sardegna e gli antichi rapporti dei Cumani con le colonie fondate su quest’isola da Iolao e Aristeo sono così giustificati, e diventa impossibile trattare come favole le storie di Pausania e Diodoro. Ma non si può andare oltre e supporre che gli ascoltatori del poeta siano, in parte, i discendenti dei Tespi di Iolao che un tempo tornarono dalla Sardegna a Cuma, come vuole Diodoro? Questi attori non dovrebbero considerare la Sardegna come la loro patria? In certe miniere e nei porti di Perseplioneia e di Telepyle non hanno ancora là connazionali e parenti?
Ciò spiega nel modo più naturale ciò che, poco fa, era inspiegabile: la predilezione di Omero per la grande via dell’occidente, e il fatto che, dopo averne parlato a lungo, lascia tacere altri rapporti con i feaci. Ancora una volta la poesia conferma la tradizione. Pertanto, attraverso alcuni risultati, il presente studio va ben oltre il quadro omerico. Dai fatti conservati da Omero in Sardegna, come a Taranto e Metaponto, come a Ischia e Cuma, come in Grecia, emerge una conclusione, sempre la stessa: che, nonostante il disprezzo dal quale sono oggi avvolte, le leggende dell’antica Grecia, hanno un reale valore documentario e devono essere raccolti e discussi con cura.
È quindi necessario, attorno al grande bardo, restringere il campo della favola; ma è particolarmente opportuno ridurlo nella sua opera stessa; Voglio dire che Nostos è molto più amico della realtà di quanto comunemente si creda, e che lascia ben poco spazio al meraviglioso e alla leggenda. Già preparata da più di una precedente osservazione, questa affermazione necessita però di qualche sviluppo.
Distinguo anzitutto dal meraviglioso, come lo intendo qui, il soprannaturale propriamente detto. È chiaro infatti che Omero crede fermamente nel soprannaturale. Crede negli dei, nella loro immortalità, nel loro potere superiore, nel loro intervento nelle cose umane sia in modo mediato e nascosto, sia in modo diretto e apparente. Crede in un’altra esistenza in cui l’uomo sopravvive a se stesso, almeno sotto forma di doppio; crede infine nei rapporti con il mondo invisibile, instaurati mediante preghiere, sacrifici, incantesimi ed evocazioni.
Ma, se ricordiamo una per una le conclusioni dettagliate formulate nel corso di questo studio, vediamo che Omero non crede a nessuno di questi esseri meravigliosi di cui tuttavia, come con piacere, popolò ogni angolo del Mar Tirreno; le famiglie di Eolo, Circe, Scilla e Polifemo, i giganti cannibali della Laistrygonia, i Ciclopi con un occhio solo alti come montagne, la divoratrice Scilla dai colli enormi e dalle bocche insaziabili, le ninfe ridotte al ruolo di servi e gli strani animali di l’isola di Aiaié, le navi incantate che si rendono invisibili, si guidano e percorrono tutte le distanze in poche ore, le divinità di Ino, di Circe, di Calipso, di Lampétiè e di Phaethousa, nulla di tutto ciò esiste, nemmeno per poeta, né per i suoi ascoltatori: per loro come per lui esistono solo processi esecutivi, trucchi poetici e antropomorfismo convenzionale. […]
Il navigatore dei Feaci, non lo ripeterò mai abbastanza, conosce a fondo i luoghi e gli uomini di cui canta Omero, e sarebbe assolutamente impossibile farglielo credere. D’altra parte, è per lui un grande piacere, un piacere rinnovato ad ogni episodio, svelare le realtà nascoste sotto enigmi trasparenti. Questa ingegnosità è molto più accessibile alle masse dell’armonia di un verso o dell’elevazione di un sentimento. Così Omero li usa senza contare, e varia le sue creazioni con infinita arte. Qui parla di lupi feroci e di leoni divoratori; Stiamo tranquilli però che questi terribili animali non faranno del male a nessuno. Sono questi, potresti chiedere, puri frutto dell’immaginazione? Niente affatto, perché sono pieni di vita e si alzano quando ti avvicini. Quindi sono davvero pericolosi? No, perché sono indomabili per natura, si accarezzano come cani… In mezzo a tutto questo, i non iniziati esitano incerti. Ma con quale piacere i vecchi marinai trovano sotto questa descrizione pittorica le sfingi dall’aspetto così vivace davanti al castello del mago! Anche loro tremarono davanti a queste meraviglie dell’arte! ‑ I Lestrigoni della Gallura sono, si dice, uomini belli, diversamente disaccoppiati rispetto ai loro gracili vicini della Nurra; ma perché il poeta li fa giganti e cannibali? Te lo dirò, io che ho trascorso molti mesi tra questi barbari; è perché credono di essere i discendenti di una razza colossale, che trafigge un uomo come io infilzo un tonno. Questa razza ha lasciato nel paese anche tombe di dimensioni prodigiose (1). Il bardo fece rivivere gli antenati nei loro discendenti, ed è per questo che dà ai Lestrigoni di oggi le dimensioni dei Ciclopi. — Questi, se li rende «più simili a montagne che mangiatori di pane», e se dona loro un unico occhio enorme, è perché personifica in essi i crateri vulcanici del loro paese. Nel Ciclope alle prese con Ulisse, non ha dipinto mirabilmente i formidabili eruttazioni di questi vulcani, nel momento in cui i loro occhi si riempiono di fuoco e di fiamme! ‑ E le nostre valorose navi, così abili nell’individuare gli stranieri, come le ha caratterizzate bene dando loro la conoscenza del marinaio e la rapidità di pensiero! […]
Ciò che infatti è decisivo nell’avventura tra i Lestrigoni, dal punto di vista che ci riguarda, non è l’esattezza, per quanto rigorosa, della topografia; è per questo che l’intero episodio, nella sua prima concezione, come nei suoi dettagli, scaturisce dalla conoscenza intima e penetrante dei luoghi, degli abitanti e delle tradizioni; e tale conoscenza, che riesce a incarnare fino a tal punto in un racconto di pochi versi l’anima delle cose, non si acquisisce a distanza.
All’occhio sintetico del poeta, ciò che occorre qui è lo spettacolo suggestivo di questo corridoio lungo e stretto, formidabile pi’ison per le navi, di questi enormi graniti appena appoggiati al suolo e che sembrano buttati giù ieri, di queste “tombe di giganti” sparse per le campagne, alle quali sono legate tante spaventose leggende. Questa natura, che toccherebbe semplicemente una mente ordinaria con la sua pittoresca, deve far vibrare un’anima creativa nelle sue profondità. E per questo, tra la natura e quest’anima, deve esserci un’azione diretta e reciproca, una sorta di comunione.
Ben chiara nell’avventura tra i Lestrigoni, questa comunione del genio con la poesia delle cose appare in modo non meno intenso nella Ciclopia; si ritrova ancora molto sensibile nell’episodio Circe. Qua e là Omero visse almeno qualche giorno, di fronte alla natura e in mezzo agli uomini.
7.2) Ulisse e Nausica in Sardegna
di Massimo Pittau
Capo 1.
L’AREA GEOGRAFICA DEI VIAGGI DI ULISSE
Sul tema generale dell’Odissea c’è da fare una prima considerazione di carattere geografico. Dovendosi ovviamente considerare l’isola di Itaca – patria di Ulisse vicina alla costa occidentale della Grecia, quella volta al Mare Ionio come ideale centro geografico dei numerosi viaggi che il poeta dell’Odissea attribuisce all’eroe itacense, risulta quasi del tutto pacifico fra gli interpreti, sia quelli antichi che quelli moderni, che l’area geografica di quei viaggi era fondamentalmente il Mediterraneo posto a occidente di Itaca e della Grecia e quindi fondamentalmente il Mediterraneo centrale, coi suoi bacini del Mare Ionio e del Mare Tirreno. In questo quadro geografico e marittimo è evidente che la Sardegna trovava una sua posizione effettiva e importante, nel senso che ogni e qualsiasi navigazione che si svolgeva soprattutto nel Mar Tirreno trovava nella nostra isola un suo necessario riferimento, cioè una tappa quasi obbligata.
A maggior ragione si deve supporre questa situazione per la Sardegna di quei lontani secoli, a motivo della tecnica navale che vigeva allora, quando la autonomia delle navi era molto ridotta rispetto a quella delle navi moderne, per cui era pressoché impossibile che un navigante che si muovesse nel Mare Tirreno non toccasse anche la nostra isola. Egli cioè doveva raggiungere la Sardegna sia che lo volesse per motivi di commercio, sia che vi fosse costretto perché spintovi da una tempesta ed avesse necessità di attendere che si calmasse e anche di riparare gli eventuali danni della sua imbarcazione.
Capo 8
I LESTRIGONI NELL’ANTICA GALLURA
C’è da ricordare che Victor Bérard aveva localizzato la terra dei Lestrigoni nella Sardegna settentrionale e precisamente nella odierna insenatura Longone/Lungoni, nei pressi di Santa Teresa [NON E’ ESATTO! Pittau ha per errore scritto Longone per Porto Pozzo: che sia una svista lo dimostra che nel testo successivo scrive correttamente Porto Pozzo]
Il poeta dell’Odissea narra che Ulisse e i suoi compagni, arrivati alle isole su cui regnava Eolo (le Isole Eolie), erano stati da lui accolti con benevolenza e inoltre erano stati equipaggiati a dovere per consentire il loro ritorno in patria. Ma dopo furono da Eolo respinti quando costui constatò che i compagni di Ulisse avevano aperto l’otre dei venti che egli aveva donato all’eroe per consentirgli una navigazione tranquilla per il suo ritorno ad Itaca. Dice testualmente l’Odissea: “Va’ via dall’isola, subito, ignominia dei vivi; non è mio costume ospitare e scortare un uomo che è in odio agli Dèi”. Vattene, perché arrivi qui in odio agli Dèi”. Così dicendo mi cacciò dalla casa tra gemiti cupi. Navigammo oltre da lì, col cuore angosciato. Il faticoso remare spossava il vigore degli uomini per la nostra stoltezza, perché era sparita la scorta. Navigammo sei giorni, di notte e di giorno: al settimo fummo alla rocca scoscesa di Lamo, la Lestrigonia Telèpilo (….). Quando arrivammo al celebre porto, attorno a cui s’alza scoscesa la roccia ininterrotta ai due lati e coste sporgenti si allungano opposte fra loro all’imbocco è angusta l’entrata i compagni arrestarono tutti le navi veloci a virare. Erano dunque ormeggiate all’interno del porto incavato, vicine: in esso non s’alza mai l’onda, né molto né poco, e intorno c’era chiara bonaccia» (Odissea, X 72-94).
Di certo Victor Bérard si era deciso per l’insenatura di Longone [NO, PORTO POZZO] sia per le sue precise caratteristiche geomorfiche, sia perché sei giorni e sei notti di navigazione potevano ben essere necessari e sufficienti per percorrere il tragitto fra le Isole Eolie e la Sardegna. A me sembra molto verosimile l’ipotesi di Victor Bérard sui Lestrigoni, come uomini capaci di lanciare grandi massi sulle navi dei compagni di Ulisse e distruggerle, mentre ovviamente è da trascurare, come mitologico, il loro essere “giganti” e addirittura “antropofagi”.
Inoltre, a mio avviso, l’etnico Laistrygónoi molto probabilmente significa «pirati, predoni» dato che appare connesso con l’appellativo greco lyster «brigante, predone, pirata». E di fatto i Tyrrhenói o Tyrsenói e pure i Pelasgói = «costruttori di torri», corrispondenti ai Sardi Nuragici, erano conosciuti come temibili “pirati”. Inoltre le Bocche di Bonifacio, con la loro relativa strettezza e col frequente passaggio di navi nell’importante tragitto fra la Grecia, l’Italia da una parte e la Gallia dall’altra, costituivano un sito ideale per gli agguati dei pirati.
D’altra parte, piuttosto che all’insenatura di Longone, si potrebbe pensare meglio al lungo “Golfo di Arzachena” e ciò in virtù di una connessione linguistica che è stringente ed insieme stupefacente: i tre compagni che Ulisse mandò per esplorare «Fuori della città s’imbatterono in una fanciulla che andava alla fonte, la nobile figlia del Lestrigone Anfiate. Ella era scesa alla fonte Artachia dalla bella corrente» (Odissea, X 105-108). Si vede subito e chiaramente che il toponimo odisseico Artachia collima strettamente con l’attuale toponimo Arzachena! Infine c’è da osservare che il suffisso -on- è di chiara matrice tirrenica, cioè sardo-nuragica ed etrusca insieme (LLE, Norme 7).
Capo 9
OLBIA CAPITALE DELLA SCHERIA
L’aver identificato la mitica nave pietrificata dei Feaci dell’epopea odisseica con la odierna e reale isola di Tavolara ci consente di procedere a un’altra importante identificazione: la capitale della Scherìa o dell’Isola dei Feaci, la città del re Alcinoo, della regina Arete e della principessa Nausicaa, era quella che in seguito, per effetto di uno stanziamento greco molto più tardo, finì col chiamarsi Olbía in greco ed Olbia in latino (Pausania (X 17, 2).
Io respingo con decisione la tesi sostenuta da un archeologo secondo cui Olbia sarebbe stata fondata dai Cartaginesi nel 350 a. C. (28) e sostengo invece che non si possa dubitare per nulla del fatto che il sito di Olbia fosse stato occupato in epoca molto più antica già dai Sardi Nuragici. Lo dimostra all’evidenza innanzi tutto il fatto che il territorio olbiese è molto ricco di monumenti e resti sardo-nuragici – ad es. il pozzo sacro che si trova ancora entro la cerchia urbana, il pozzo sacro di sa Testa e inoltre il santuario fortificato di Cabu Abbas (29), in secondo luogo la circostanza che ai Sardi Nuragici non poteva sfuggire l’importanza enorme della baia di Olbia come insenatura difesa dai venti e quindi adattissima alla navigazione, alla pesca e all’estrazione del sale.
Oltre a ciò, è senz’altro irragionevole pensare che ad un loro insediamento coloniale i Cartaginesi avessero dato un nome dei Greci, che erano i loro nemici secolari, il nome di Olbía, che è sicuramente greco e significa «felice, fortunata». Sarebbe come se attualmente i Russi riuscissero a stabilire una stazione spaziale nel pianeta Marte e gli dessero il nome statunitense di “Washington” o, viceversa, gli Statunitensi gli dessero il nome di Mosca …
Ciò detto e precisato, anche la descrizione che l’Odissea fa della città di Alcinoo si adatta quasi esattamente alla situazione geografica di Olbia. Il poeta dell’Odissea dice che la città dei Feaci aveva “ai due lati un bel porto e stretta una entrata» (Odissea, VI, 263- 264); il che fa intendere che la città era come su un piccola penisola che si infilava nel mare<30>. Ebbene questa situazione corrisponde esattamente a quella di Olbia, la quale, prima che venisse costruito il lungo molo artificiale che la unisce all’Isola Bianca per consentire l’approdo delle moderne motonavi, aveva un lungo porto a forma di ferro di cavallo, che andava dall’attuale Poltu Romanu «Porto Romano», a nord, fino all’altro nella sua riva volta a sud-est, Poltu ‘Etzu «Porto Vecchio» (31). La «stretta entrata del porto potrebbe essere quella del Poltu Romanu, attualmente scavalcata da un ponte.
Oltre a ciò il poeta dell’Odissea ci dice che la città aveva la «agorá costruita di pietre trasportate e conficcate nel terreno» (Odissea, VI 266-267): e anche questa è una notazione che si adatta perfettamente con le usanze costruttive dei centri abitati della Gallura, nei quali le piazze lastricate con granito sono una caratteristica inconfondibile.
Ma nel racconto fantastico fatto dall’Odissea circa l’ira di Posidone contro i Feaci perché avevano riportato l’odiato Ulisse nella sua patria Itaca, c’è un altro particolare che probabilmente trova anch’esso una esatta conferma nella conformazione della insenatura di …
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
L’Odissea e la Sardegna nuragica
di Massimo Pittau ⇒
L’AREA GEOGRAFICA, LA DATAZIONE E LA ROTTA DEI VIAGGI DI ULISSE
Nell’antico mondo greco, già in epoca classica e dopo in quella postclassica, riguardo ai poemi omerici e soprattutto riguardo all’Odissea si determinò un movimento esegetico-culturale molto caratteristico: numerosi interpreti, commentatori, storici e geografi si diedero da fare per indicare la rotta esatta del viaggio fatto da Ulisse nel suo peregrinare da una terra all’altra del Mediterraneo e più precisamente per individuare le diverse tappe da lui fatte e cioè le terre da lui toccate. La motivazione di fondo di questa affannosa esegesi di carattere geografico stava nel fatto che – come tutti sappiamo – i due poemi omerici costituivano ormai i “libri” per eccellenza della etnia greca, la loro Bibbia nazionale, gli strumenti essenziali della paideia dei Greci e cioè della loro educazione e della loro cultura. Quelle identificazioni delle varie «tappe» del viaggio di Ulisse pertanto erano promosse dal desiderio di dare decoro e gloria alla propria patria locale, alla propria isola, alla propria città o regione, decoro e gloria che scaturivano appunto dall’essere stata essa raggiunta dall’eroe di Itaca.
Senonché la identificazione di quelle tappe non risultava affatto univoca, bensì variava da interprete a interprete, ovviamente in funzione ed a vantaggio delle rispettive patrie locali; col risultato finale che circa la identificazione di alcune tappe, perfino di quelle fondamentali, venivano indicate decine di differenti località…\1\
Il quale modo di procedere dei vari interpreti fu criticato e anche deriso dal grande filologo e geografo Eratostene di Cirene, con la seguente frase che ci viene tramandata da Strabone (I, 2, 15): «Si ritroverà dove Ulisse ha navigato, quando si troverà il pellaio che ha cucito l’otre dei venti» (evidentemente quello datogli da Eolo). Senonché questa critica e questa derisione di Eratostene non fu affatto recepita dagli interpreti successivi, nemmeno dallo stesso Strabone che ce l’ha tramandata; e molti ancora continuarono nelle loro identificazioni delle varie tappe del viaggio di Ulisse: nel mondo greco, fino al suo trapasso in quello bizantino, e anche nel mondo romano, dopo che Livio Andronico nel secolo III a.C. Aveva proceduto a tradurre in latino l’Odissea.
Non solo, ma i tentativi di ricostruire l’esatto itinerario del viaggio di Ulisse vennero ripresi in epoca moderna, a iniziare dall’età umanistica, di secolo in secolo, fino ai giorni nostri, con innumerevoli e purtroppo assai differenti proposte di identificazione.
In epoca recente c’è stato persino chi ha localizzato qualche episodio del viaggio di Ulisse nello Jutland e chi addirittura ha pensato di costruirsi una barca alla foggia di quella usata da Ulisse e, munito di perfezionati apparecchi fotografici, ha deciso di ripercorrere e di fotografare l’itinerario dell’antico navigatore, ovviamente finendo col giurare che quella effettivamente era stata la precisa rotta del peregrinare dell’eroe itacense…
Ma a prescindere da queste amenità, per i tempi recenti sia sufficiente citare due opere molto impegnate, alle quali i rispettivi autori hanno voluto dare tutti i crismi della acribia scientifica: Victor Bérard, Les Navigatione d’Ulysse\2\, e Hans-Helmut & Armin Wolf, Der Weg des Odysseus. Tunis-Malta-Italien in den Augen Homers, con nuova edizione dal titolo Die wirkliche Reise de Odysseus. Zur Rekonstrution des Homerischen Weltbildes\3\. Senonché soprattutto quest’ultima opera dei fratelli Wolf, nonostante ed anzi proprio per l’impegno esegetico profuso nella loro ricerca, si è attirata una sostanziale condanna da parte dei filologi\4\.
D’altra parte il tema della “ricostruzione della rotta del viaggio di Ulisse” è ormai diventato un topos della stampa quotidiana e periodica, tanto che non passa anno in cui non si annuncino le strabilianti “ricostruzioni scientifiche” fatte dagli immancabili capitani di mare o navigatori o ingegneri od avvocati…
E tutto questo ha pure avuto le sue ovvie conseguenze pratiche: ad esempio, «nel 1974, il Golfo di Squillace è stato denominato, in base alla localizzazione wolfiana, “Riviera di Nausicaa”, con tanto di lapide nel luogo del fatidico incontro tra Odisseo e la figlia di re Alcinoo»\5\.
E pure la nostra Sardegna ha fatto la sua parte: evidentemente a seguito delle indicazioni di Victor Bérard, che aveva localizzato la terra dei Lestrigoni nella Sardegna settentrionale, nella insenatura di Porto Pozzo, di recente è stato ufficialmente trovato e battezzato un «Porto di Ulisse»…
LA IMPOSSIBILITÀ NAUTICA DEI VIAGGI DI ULISSE
Dal modo in cui ho finora condotto il mio discorso sarà apparso chiaro che io non credo affatto alla “scientificità” dei tentativi di ricostruzione del viaggio di Ulisse; io non ci credo per una grossa difficoltà che espongo subito.
C’è da premettere che ciò che ha spinto innumerevoli interpreti, antichi e moderni, a ritenere realmente avvenuto il viaggio di Ulisse, è di certo la forma di racconto autobiografico che il poeta dell’Odissea ha adottato nel raccontarlo. Si è pertanto ritenuto che il racconto fatto da Ulisse al re Alcinoo e alla sua corte non sia altro che il resoconto di un viaggio compiuto realmente da un navigante antico, quasi il resoconto trascritto nel suo «diario di bordo».
Senonché l’ipotesi che quel viaggio sia realmente avvenuto cade di fronte a questa grave difficoltà: il viaggio di Ulisse quale viene descritto nell’Odissea, pur prescindendo del tutto – ovviamente – dai riferimenti a fatti mitici, fantastici e portentosi, quali i Ciclopi, giganti con un solo occhio, i Lestrigoni giganti ed antropofagi, i mostri di Scilla e Cariddi, Eolo col suo otre dei venti, la maga Circe, la ninfa Calipso, la fascia di Leucotea, ecc. ecc., dal punto di vista strettamente nautico presenta una lunga serie di difficoltà ed incronguenze insuperabili, quali sono, ad esempio, il resistere di Ulisse in mare per 9 giorni aggrappato alla chiglia della nave infranta dal fulmine, il suo nuotare per 2 giorni, il suo salvarsi nonostante l’essere stato sbattuto agli scogli (Od., VII 250-253, 267-268, V 279, 388, 425-430), ecc. ecc.
Non è da accettarsi l’ipotesi che quel lungo viaggio di mare, nella sua interezza, sia stato realmente effettuato da un navigatore antico. Dunque, in termini strettamente nautici, quel viaggio, così come viene descritto dall’Odissea, risulta intrinsecamente impossibile. Al massimo si può concedere che tutte quelle tappe e alcuni di quegli episodi narrati nel poema non siano il resoconto di un solo viaggio effettuato da un solo navigatore, bensì siano la somma di vari resoconti di differenti viaggi effettuati da diversi navigatori precedenti. Uno di questi sarà stato Ulisse nativo dell’isola di Itaca, alla cui reale esistenza storica si può anche dare credito, dato che Itaca era famosa in tutto il mondo greco per questa sola circostanza: l’aver dato i natali appunto al famosissimo Ulisse\5 bis\.
La qual cosa risulta confermata dalla circostanza che – come tutti sappiamo – secondo numerosi studiosi moderni l’unità di composizione dell’Odissea è soltanto apparente, dato che il poeta che effettuò la composizione scritta e quasi definitiva dell’Odissea, in realtà fece un’opera di assemblaggio di canti più antichi, tramandati per via orale, i quali narravano i viaggi di altri navigatori precedenti. In via più specifica è quasi pacifico tra gli studiosi recenti che l’Odissea costituisca la sintesi di tre lunghi racconti differenti: la Telemachia o il racconto del viaggio effettuato da Telemaco per rintracciare il padre, i Viaggi di Ulisse o il racconto di Ulisse alla corte di Alcinoo ed infine la Vendetta di Ulisse sui Proci. A questi tre lunghi racconti, che costituiscono la parte essenziale dell’Odissea, in seguito furono aggiunti altri racconti di estensione molto minore.
Ho fatto questa abbastanza lunga premessa con l’intento di precisare che col mio presente studio, io non mi sono affatto prefisso il compito di tentare una nuova ricostruzione dell’«itinerario» dell’intero viaggio di Ulisse e nemmeno quella di procedere alla identificazione di una o di alcune tappe di quel viaggio. Escludo del tutto questo proponimento per il motivo essenziale che io sono dalla parte di quegli studiosi i quali ritengono che Ulisse sia fondamentalmente una creatura fantastica e poetica e che pertanto non sia mai esistito un Ulisse reale ed unico che abbia fatto quell’impossibile viaggio che l’Odissea gli attribuisce. Il compito che mi sono prefisso è uno enormemente più modesto, ma insieme – così almeno mi sembra – molto più “scientifico”; ed è quello che ora mi accingo ad esporre.
* * *
IL RISO SARDONICO DI ULISSE
C’è innanzi tutto da premettere e precisare che i due poemi omerici, l’Iliade e l’Odissea, non citano mai la Sardegna. È ben vero che un riferimento alla Sardegna sembrerebbe implicito nella famosa locuzione «riso sardanio o sardonio», cioè “riso amaro e forzato”, col quale Ulisse avrebbe risposto alla grave provocazione di uno dei Proci (Od., XX 302); «riso sardanio o sardonio» che numerosi interpreti antichi hanno di fatto riferito proprio alla Sardegna, come terra in cui esiste la velenosa «erba sardania o sardonia» che provocherebbe la morte di un uomo, costringendolo prima a fare un riso doloroso, oppure come terra in cui c’era l’usanza di uccidere i vecchi settantenni ed essi avrebbero affrontato la morte ridendo, in maniera artefatta, per dimostrare coraggio nell’affrontare la loro tragica fine\6\. Già da tempo però io ho escluso che in origine, per quanto realmente risulta dal contesto dell’Odissea, la locuzione «riso sardanio» si riferisse alla Sardegna; è molto meno costoso ritenere che si riferisse ai Sardiani abitanti di Sardeis, capitale della Lidia, terra strettamente contigua alla Ionia, in cui sono nati e maturati i due poemi omerici, che non alla lontanissima Sardegna\7\. Non solo, ma a prescindere dal problema della sua esatta origine e motivazione, è del tutto evidente che la frase implicava una notazione negativa da parte dei Greci della Ionia, notazione negativa che era molto più ovvia nei confronti degli abitanti della vicina Sardeis, loro confinanti ed intesi come “nemici”, che non nei confronti degli abitanti della lontanissima Sardegna. Il fatto poi che i tardi interpreti greci dell’Odissea abbiano invece riferito la locuzione «riso sardanio» alla Sardegna costituisce solamente una delle prove del fatto che nella memoria storica dei Greci resisteva ancora il ricordo della emigrazione dei Lidi e quindi anche degli abitanti di Sardeis o Sardiani non soltanto verso l’Etruria, secondo il notissimo racconto di Erodoto (I 94), ma anche verso la Sardegna, alla quale addirittura essi avevano dato il nome\8\.
Dunque lo ripeto: né l’Iliade né l’Odissea citano mai la Sardegna. Ebbene, col presente studio io mi propongo il compito di appurare se, nonostante questo silenzio dei due poemi omerici rispetto alla Sardegna, almeno in quello più recente, l’Odissea, si possa affermare che la nostra isola risulti presente in forma implicita, sia nella sua realtà geografica, sia nella sua realtà culturale. Ed anticipo che il risultato della mia ricerca a me sembra essere positivo od affermativo.
* * *
L’ODISSEA E LA SARDEGNA NURAGICA
Una prima considerazione di carattere geografico. Dovendosi ovviamente considerare l’isola di Itaca – che è vicina alla costa occidentale della Grecia, quella volta al mare Ionio – come ideale centro geografico dei numerosi viaggi che il poeta dell’Odissea attribuisce ad Ulisse, risulta quasi pacifico fra gli interpreti, sia quelli antichi che quelli moderni, che l’area geografica di quei viaggi era fondamentalmente il Mediterraneo posto ad occidente di Itaca e della Grecia e quindi fondamentalmente il Mediterraneo centrale, coi suoi bacini del mare Ionio, di quello Adriatico, di quello Tirreno e di quello posto fra la Sicilia, l’Africa settentrionale e la Sardegna. In questo quadro geografico e marittimo è evidente che la Sardegna trovava una sua posizione effettiva e importante, nel senso che ogni e qualsiasi navigazione che si svolgeva soprattutto nel mare Tirreno e anche lungo le coste dell’odierna Tunisia trovava nella nostra isola un suo necessario riferimento, cioè una tappa quasi obbligata. A maggior ragione si deve supporre questa situazione per la Sardegna di quei lontani secoli, a motivo della tecnica navale che vigeva allora, quando la autonomia delle navi era molto ridotta rispetto a quella delle navi moderne, per cui era pressoché impossibile che un navigante che si muovesse nel mare Tirreno e lungo le coste dell’Africa centro-settentrionale non toccasse, volente e nolente, la nostra isola.
Il poeta dell’Odissea caratterizza il quadro marittimo e geografico del Mediterraneo dove si svolgono i viaggi di Ulisse e cioè quello che egli conosce, ovviamente in maniera piuttosto nebulosa, dicendo che era il luogo dove «i sentieri della notte e del giorno sono vicini» (Od., X 86), dove cioè – dico io – il sole, morendo, si predispone a rinascere il giorno successivo, sia pure alla parte opposta. Siamo dunque nell’area del Mediterraneo occidentale, della quale evidentemente la Sardegna costituiva un punto centrale e perfino essenziale. Dunque già in termini strettamente geografici è del tutto legittimo ritenere che, nonostante che la Sardegna non sia mai citata dall’Odissea in maniera esplicita, l’isola risultava essere una delle terre presso le quali si svolgevano i viaggi di Ulisse o, meglio, quelli dei naviganti reali che avevano effettuato viaggi in tempi precedenti alla composizione dell’Odissea.
Una seconda considerazione, questa di carattere cronologico e storico. Alcuni storici moderni avevano sostenuto che il racconto dei viaggi attribuiti dall’Odissea ad Ulisse non erano altro che i riflessi letterari e i ricordi poetici della colonizzazione che le varie stirpi greche avevano fatto sia in Sicilia sia nell’Italia meridionale o Magna Grecia ad iniziare dalla metà dell’VIII secolo avanti Cristo. Senonché l’autorevole storico Jean Bérard, nella sua importante opera La colonisation grecque de l’Italie méridionale et de la Sicilie dans l’antiquité. L’histoire et la légende\9\ ha ampiamente e convincentemente dimostrato che i viaggi di Ulisse in effetti sono di molto anteriori a quella colonizzazione, per cui, più che essere il resoconto di quella colonizzazione, al contrario sono stati quasi la “guida” per i coloni greci che si mettevano in viaggio alla volta dell’Italia meridionale e della Sicilia. Secondo il Bérard i mitici viaggi raccontati dall’Odissea sono l’effetto ed il ricordo di precedenti viaggi effettuati dai Greci nei secoli precedenti nel Mediterraneo centrale e soprattutto nel Tirreno, secondo le modalità di una precolonizazione greca in quell’area geografica.
I viaggi di quella «precolonizzazione greca» sono da attribuirsi in maniera preminente ai Micenei, e quindi risalgono anche ai secoli XIII e XII avanti Cristo. In linea di fatto le scoperte dell’archeologia successive alla citata opera del Bérard hanno dato piena ragione e conferma all’illustre studioso francese: reperti micenei sono stati trovati e si vanno tuttora trovando in quasi tutte le terre bagnate del Mediterraneo centrale, la Sardegna compresa\10\.
Rispetto a questi reperti micenei trovati di recente in Sardegna a me sembra che non si debba pensare soltanto a viaggi effettuati dai Miceni in Sardegna, probabilmente in cerca di quei minerali che la nostra isola aveva in abbondanza, come dimostra anche il fatto che essa, prima che venisse denominata Sardó dai Sardiani venuti da Sardeis della Lidia, veniva chiamata Argyróphlebs, ossia «Vena d’Argento», secondo la lingua greca\11\; ma si debba pensare anche a una certa frequentazione dei Sardi Nuragici nel Peloponneso, sede della civiltà micenea, nei loro viaggi di andata e di ritorno che li legavano alla madrepatria lidia\12\. I Greci di Micene, Argo, Tirinto, Pilo, ecc. conoscevano pertanto da antica data la Sardegna ed i Sardi; ma li conoscevano anche i Greci dell’isola di Creta e quelli dell’isola di Cipro, come dimostrano in maniera incontrovertibile sia il ritrovamento in Sardegna di ben 17 talenti di rame a forma di pelle bovina distesa, del tutto simili a quelli trovati appunto a Creta ed a Cipro, sia il ritrovamento in Sardegna della statuetta di bronzo di Nule, che di certo raffigura il Minotauro sotto forma di toro con la testa umana\13\.
Dunque, come dimostrano i reperti micenei rinvenuti nell’isola e soprattutto i citati talenti di rame, sul piano cronologico risulta del tutto certo che i Greci conoscevano la Sardegna e la sua civiltà nuragica almeno dal XIII secolo avanti Cristo.
D’altra parte è cosa abbastanza nota che i due poemi omerici hanno trovato la loro sistemazione scritta e quasi definitiva nei secoli VIII-VII a.C., ma conservavano e conservano il ricordo di avvenimenti dei tre o quattro secoli precedenti, relativi per l’appunto alla civiltà micenea.
E traggo una prima conclusione dicendo: sia per le considerazioni di carattere geografico sia per quelle di carattere archeologico e cronologico or ora esposte, è pressoché impossibile ritenere che il poeta che ha composto i Racconti della corte di Alcinoo non avesse alcuna notizia della Sardegna, tanto nella sua posizione e configurazione geografica quanto e soprattutto per la civiltà nuragica che essa aveva prodotto ed ospitava. Ed a maggior ragione doveva egli avere una certa conoscenza almeno indiretta della Sardegna nei suoi aspetti geografici ed in quelli culturali sia per il fatto che la civiltà nuragica in effetti era una figlia di quella civiltà della Lidia, che era una terra contigua alla patria di origine dei poemi omerici (la Ionia), sia per il fatto che proprio nei secoli che vanno dal XIII all’VIII a.C. la civiltà nuragica aveva raggiunto l’apice del suo sviluppo e del suo splendore, non ancora toccato ed infirmato dall’arrivo dei Fenici e dei Cartaginesi in Sardegna.
Senonché sta di fatto che l’Odissea – come abbiamo visto prima – non cita mai la Sardegna. Come può pertanto essere superata questa grossa e singolare incongruenza di carattere storico-documentario? Può essere superata ritenendo e dicendo che il poeta dell’Odissea cita effettivamente la Sardegna, ma non chiamandola con la sua denominazione, quella che in seguito diverrà tradizionale e definitiva, bensì con qualche altra denominazione relativa a una sua regione oppure a una sua popolazione. Ed è per l’appunto questo il mio punto di vista, quello che mi appresto ad indicare e a dimostrare: il poeta dell’Odissea cita la Sardegna e la sua civiltà nuragica quando parla della «Scherìa o isola dei Feaci».
Una prima importante considerazione: «la Scherìa o isola dei Feaci», la loro civiltà e la corte del loro re Alcinoo giocano un ruolo molto importante nell’Odissea, come dimostra chiaramente il fatto che la parte più importante ed anche quella più bella del poema viene dai moderni esegeti chiamata – come abbiamo visto sopra – Viaggi di Ulisse oppure Racconti della corte di Alcinoo. Ebbene questa importanza del ruolo dell’isola dei Feaci, della sua popolazione e della sua civiltà risulta del tutto congruente con la importanza che la Sardegna con la sua «civiltà nuragica» aveva nel Mediterraneo centrale nei secoli XIII-VIII. Si consideri che per quei lontani secoli Giovanni Patroni ha definito la Sardegna, in virtù della sua «civiltà nuragica», «la perla dell’occidente mediterraneo»\14\; si consideri che quella nuragica è stata la prima grande civiltà non solamente dell’Italia ma anche di tutto il bacino centro-occidentale del Mediterraneo, civiltà precedente di quattro secoli a quella «civiltà etrusca», che troppi autori si ostinano a definire la «prima civiltà dell’Italia» (d’altronde molti sanno che io vado sostenendo da una quindicina d’anni che la civiltà nuragica e quella etrusca erano geneticamente affini, perché entrambe derivate e scaturite dalla civiltà lidia, e che addirittura quella nuragica ha promosso il primo sorgere di quella etrusca!). A ciò va aggiunto che ha di certo un enorme significato storico la denominazione di mare Tirreno acquistata dal bacino centrale del Mediterraneo: la quale appunto deriva dall’etnico Tyrrhenói, Tyrsenói, che propriamente significava «Costruttori di torri», e questi inizialmente erano i Sardi Nuragici, costruttori delle circa 7 «torri nuragiche» della Sardegna. Il mare Tirreno dunque dovette la sua denominazione al predominio o «talassocrazia» che prima i Sardi Nuragici o Tirreni della Sardegna e dopo anche i loro parenti Etruschi o Tirreni d’Italia esercitarono a lungo su quel bacino del Mediterraneo centrale\15\.
Dunque la descrizione abbastanza circostanziata, cordiale e perfino ammirata che il poeta dell’Odissea fa del popolo dei Feaci e della sua civiltà si adatta perfettamente alla importanza, alla grandezza ed alla magnificenza della «civiltà nuragica» della Sardegna, mentre non si vede a quale altro popolo e a quale altra civiltà del Mediterraneo centrale e dei secoli XIII-VIII a.C. potesse essere riferita con ugualmente esatta congruenza.
Numerosi interpreti greci dell’età classica e di quella postclassica avevano identificato l’«isola dei Feaci» descritta dall’Odissea con l’isola di Corcira, cioè con l’attuale Corfù\16\.
Senonché a tale identificazione si oppongono quattro gravi difficoltà:
1ª) L’Odissea mette l’isola dei Feaci nel lontano occidente mediterraneo, «lontano dagli uomini» e «in disparte, ultimi nel molto ondoso mare» (Od., VI 8, 204-205) e questa di certo non era la posizione geografica di Corcira, che invece è vicinissima ad Itaca;
2ª) Non risulta per nulla che l’antica Corcira abbia mai ospitato una civiltà di così alto tenore, quale è quella dei Feaci descritta dal poeta dell’Odissea;
3ª) Costui fa chiaramente intendere che il popolo dei Feaci era molto civile ed avanzato, ma anche “altro” o “diverso” e cioè xénos o «forestiero» rispetto alla etnia greca, mentre ai Greci non risultava affatto che Corcira avesse mai ospitato una civiltà dissimile da quella greca;
4ª) L’Odissea dice che nell’isola dei Feaci regnavano 12 re più Alcinoo, il tredicesimo (Od., VIII 390-391); orbene è da escludersi del tutto che nell’isola di Corcira potessero regnare contemporaneamente 13 re, sia pure sovrani di altrettanti piccoli regni.
Uno degli argomenti che gli esegeti moderni mettono avanti per sostenere che i due poemi cosiddetti “omerici” sono usciti dalle mani di almeno due differenti poeti si ha nel fatto che nell’Odissea, a differenza dell’Iliade, trova largo spazio l’elemento soprannaturale, cioè magico e portentoso, costituito da mostri, giganti, ciclopi, semidei, ecc. Di passaggio faccio notare che questo elemento soprannaturale trovava nei tempi antichi le sue ragioni di fondo in due fatti principali: da una parte l’esistenza nei mari di fenomeni che in quei tempi risultavano del tutto inspiegabili in termini razionali, quali maremoti, correnti impetuose, vortici, trombe marine, grotte profonde sulle coste, pesci mostruosi, ecc., dall’altra il tentativo dei mercanti delle varie etnie di allontanare i concorrenti dalle diverse zone di commercio fruttuoso.
Ebbene questo elemento soprannaturale si incontra in quasi tutti gli episodi che costituiscono altrettante tappe del viaggio di Ulisse, e cioè i Lotofagi, Polifemo, Eolo, i giganti Lestrigoni, Circe, il regno dei Morti, le Sirene, le rupi erranti, Scilla e Cariddi, Calipso.
Tutto al contrario, nell’episodio relativo all’isola dei Feaci, che – lo ripeto e ribadisco – gioca un ruolo di primissimo piano nell’Odissea, l’elemento soprannaturale non compare quasi mai.
Nel racconto relativo all’isola dei Feaci ci sono, sì, i tre episodi di Atena che si presenta ad Ulisse sotto le mentite spoglie prima di una ragazza, dopo di un araldo ed infine di un giudice di gara, ma questo modo di procedere della potente dea amica di Ulisse si ritrova in tutta l’Odissea e si ritrova di frequente anche nell’Iliade. Nel lungo Racconto di Ulisse nella corte di Alcinoo un solo elemento veramente magico e portentoso si incontra, ed è l’episodio della nave dei Feaci che, al ritorno dal viaggio che aveva riportato Ulisse ad Itaca, in vista ormai della terra da cui era partita, viene da Poseidone irato contro i Feaci pietrificata e trasformata in un’isola saldamente connessa al fondo del mare. Ebbene quest’unico episodio portentoso o miracoloso relativo ai Feaci, non solo non distrugge né attenua il carattere realistico della descrizione dell’isola dei Feaci e della loro civiltà fatta dall’Odissea, ma addirittura finisce, come vedremo più avanti, col caratterizzarsi come uno degli indizi più consistenti a favore della realtà geografica e storica dell’isola e del popolo dei Feaci.
La descrizione dell’isola e del popolo dei Feaci, come risulta fatta dall’Odissea, non solo non presenta elementi magici e portentosi, ma tutto al contrario è realistica, precisa, abbastanza circostanziata ed inoltre presenta elementi che danno al lettore la sensazione che si riferisca ad una terra e ad un popolo realmente esistiti ed effettivamente conosciuti – sia pure in maniera quasi di certo indiretta – dal poeta dell’Odissea. Ed infatti è stato giustamente affermato che «Sebbene remoti e isolati (….), i Feaci saranno i primi uomini che Odisseo incontrerà da quando ha perso i compagni, otto anni prima»\17\. La stessa descrizione della ricchezza della reggia di Alcinoo e quella del suo giardino hanno certamente la nota della esagerazione, ma non quella del portentoso o miracoloso.
Nella descrizione dunque dell’isola dei Feaci si incontrano molti elementi realistici, alcuni dei quali si stagliano in maniera esatta e – direi – sorprendente con la realtà culturale dei Sardi Nuragici, quale la archeologia e la storiografia moderne hanno ricostruito e delineato.
Il racconto relativo ai Feaci inizia con una importante notizia: essi in origine abitavano altrove e rispetto alla Scherìa, lontana terra circondata dal mare (Od., VI 204), risultavano nuovi arrivati (Od., VI 4-10). Ed anche i Sardi Nuragici – come ho accennato prima – in origine vivevano nella Lidia e nella loro nuova sede, la grande isola del Mediterraneo centrale, risultavano nuovi arrivati.
Ripetutamente il poeta dell’Odissea dice che i Feaci erano grandi navigatori (Od., VI 270; VII 36, 108, 328; VIII 247, ecc.); ed anche i Sardi Nuragici erano grandi navigatori, come dimostrano l’essere arrivati in Sardegna dalla lontana Lidia, l’avere a lungo mantenuto rapporti con la loro lontana madrepatria, l’avere partecipato alle numerose imprese che i «Popoli del Mare» fecero in Egitto e in tutte le terre del Mediterraneo orientale, l’essersi impadroniti delle Baleari, l’avere stabilito loro stanziamenti nella Corsica meridionale, sulle coste della futura Etruria e su quelle dell’Iberia nord-orientale, l’avere probabilmente tentato la conquista di una grande isola nell’Oceano Atlantico – forse Madera – impediti però dai Cartaginesi\18\.
Nel descrivere la reggia di Alcinoo, re dei Feaci, il poeta dell’Odissea mette in grande evidenza l’abbondanza di metalli preziosi con cui essa era fatta e la ricchezza degli oggetti che vi erano contenuti (Od., VII 81-102). Ebbene l’intera civiltà nuragica è stata caratterizzata dal largo uso dei metalli, dei quali i Nuragici si sono dimostrati ottimi lavoratori; e questo in virtù del fatto che tutta l’isola era, nell’intero Mediterraneo, uno dei maggiori centri di produzione di metalli: argento, rame, piombo, zinco e ferro, tanto che – come abbiamo visto sopra – prima di chiamarsi Sardó per effetto dell’arrivo dei Sardiani della Lidia, veniva chiamata dai Greci Argyróphlebs, cioè «Vena d’Argento».
I Feaci conoscevano l’usanza dei giochi ginnici e militari (Od., VIII 120 segg.); ed anche i Sardi Nuragici avevano questa usanza, come dimostrano i bronzetti di pugili, di lottatori, di cavalieri che tirano d’arco inginocchiati sul dorso del cavallo\19\.
I Feaci avevano una grande passione per la danza e addirittura si vantavano di essere i migliori in questa attività diversiva (Od., VIII 253); la loro danza poi prevedeva una catena di giovani di forma circolare, al cui centro si metteva il suonatore che dava il tempo per la danza (Od., VIII 262, 380). Ebbene, pure i Sardi hanno sempre dimostrato e tuttora dimostrano vivissimo interesse e gusto al loro ballo tradizionale, il quale prevede anch’esso una catena circolare di giovani, al cui centro si metteva, fino all’inizio del secolo XX, il suonatore delle antichissime launeddas o flauti multiplici, che sono di probabile origine lidia\20\, mentre attualmente si mette il suonatore di fisarmonica.
Circa il sistema di governo dei Feaci il poeta dell’Odissea segnala che essi venivano retti da dodici re, mentre Alcinoo era il tredicesimo (Od., VIII 390-391). Ebbene, anche per i Sardi Nuragici giustamente si è parlato di un sistema di governo di forma “cantonale” e cioè “federativa” delle varie popolazioni, le quali venivano governate da altrettanti piccoli sovrani; rispetto ai quali il capo supreno – probabilmente eletto soltanto in occasioni di guerre contro popoli invasori – risultava essere solamente un primus inter pares. Non solo, ma perfino nel numero dei re che regnavano sui Feaci possiamo riscontrare una nuova notazione realistica: perché risultavano essere 13 e non, ad esempio, 12, che per tutta l’antichità e presso numerosi popoli è stato un numero canonico e sacrale, in dipendenza dal numero delle 12 lunazioni che si hanno in un anno solare. In linea di fatto, dopo uno studio accurato, io ritengo di avere di recente individuato ed elencato le seguenti 10 tribù o popolazioni nuragiche: Rubresi in Ogliastra, Galillesi nel Gerrèi, Salchitani nel Sarcidanu, Alchitani presso San Nicolo d’Arcidanu e nelle pendici del monte Arci, gli Ipsitani presso Fordongianus, i Giddilitani abitanti di Citil in Campeda, gli Uddadhaddi presso Cuglieri, gli Iliesi nella Barbagia di Ollolái, i Lesitani presso le terme di san Saturno di Benetutti, i Nurritani nella attuale Nurra oppure presso Nurri\21\.
Il poeta dell’Odissea, parlando di Arete, moglie del re Alcinoo, si dilunga nel parlare dell’alta stima e del grande prestigio che essa godeva presso il marito e presso i sudditi, tanto che veniva richiesta di pareri e perfino dirimeva le loro liti (Od., VII 65-74). D’altronde sia Nausicaa sia Atena consigliano Ulisse di rivolgersi, per la richiesta di aiuto, prima e piuttosto ad Arete che non ad Alcinoo (Od., VI 305-315; VII 53-54) e inoltre l’ultimo saluto di commiato Ulisse lo rivolge ad Arete e non ad Alcinoo (Od., XIII 59-62). E sono tutte notazioni che da una parte non corrispondono affatto alla posizione che la donna aveva nel mondo omerico e greco, dall’altra, al contrario, sembrano stagliarsi meglio nella lunga tradizione dei Sardi, quella per la quale essi hanno avuto una regina come Eleonora d’Arborea, quella per cui in epoca medioevale e fino a settant’anni fa nelle zone interne dell’isola c’era l’usanza di denominare un individuo col nome della madre e non con quello del padre\22\ ed infine nel grande prestigio che tuttora ha la donna, soprattutto la madre, nel mondo agro-pastorale. Per la figura della odisseica regina Arete si è parlato di un ricordo di un antichissimo matriarcato, e pure per la Sardegna se ne deve, almeno in una certa misura, ugualmente parlare.
* * *
TAVOLARA E LA NAVE PIETRIFICATA DEI FEACI
Ho già detto che nel lungo racconto dell’Odissea relativo ai Feaci esiste un solo elemento magico-portentoso: la pietrificazione, effettuata da Poseidone irato, della nave con cui i Feaci avevano riportato Ulisse nella sua patria Itaca e la sua trasformazione in un’isola saldata al fondo del mare. Ed ho pure anticipato che quest’unico elemento magico-portentoso del lungo racconto odisseico in effetti si caratterizza come uno degli indizi più forti della realtà storica dei Feaci e inoltre della loro identificazione con gli antichi Sardi Nuragici.
Io sono del parere che esista effettivamente lungo le coste della Sardegna un’isola che poteva essere interpretata come una nave pietrificata, e quest’isola è Tavolara.
Tavolara è un’isola dalla conformazione geologica molto caratteristica, in virtù della quale essa si impone a un qualunque navigante vi passi vicino in maniera immediata e vistosa e più che qualsiasi altra isola. Intanto è un’isola molto lunga (circa 7 chilometri) e viceversa molto stretta (poco più di 1 chilometro), inoltre è costituita da una lunga cresta montana che si eleva quasi a picco sul mare, raggiungendo la considerevole altezza di 564 metri nella Punta Cannone\23\. Effettivamente l’isola di Tavolara poteva e può dare l’impressione e l’immagine di una grande nave che è stata pietrificata nella sua veloce corsa sul mare, assieme al suo apparato di grandi vele spiegate al vento. La sua lunga ed alta cresta di montagna si presenta infatti frastagliata e mossa, per cui l’immaginazione dello spettatore può essere spinta a intravedervi il susseguirsi e il vario muoversi di più vele. Ma che l’isola di Tavolara si presenti effettivamente in questo modo ai naviganti è dimostrato in maniera sorprendente soprattutto da una precisa ed esatta circostanza: la sua appendice nord-orientale ha il nome di «Punta su Timone», “il timone”, evidentemente, di una nave!
Questa denominazione del piccolo promontorio di Tavolara costituisce nel mio discorso una prova di straordinaria importanza, dato che dimostra chiaramente e senza ombra di dubbio che l’intera isola era dagli antichi naviganti vista come una grande nave di pietra calcarea, rispetto alla quale il suo piccolo promontorio nord-orientale costituiva appunto il timone. Su questo argomento mi piace riportare quanto ha scritto quell’acuto e attentissimo studioso che era Dionigi Panedda: «Se, tenendo presente la configurazione orizzontale di Tavolara e del timone, si scorrono le illustrazioni che, di navi dell’antichità e del medioevo, riportano enciclopedie e pubblicazioni specializzate, non potranno non saltare agli occhi le due somiglianze che corrono tra le dette navi e la grande isola olbiese. L’una, la somiglianza tra lo strumento di direzione di quelle antiche navi – il gubernaculum dei romani – e la configurazione sia orizzontale che verticale del promontorio del Timone. L’altra, la somiglianza tra la posizione dell’antico timone direzionale, rispetto alle navi a cui veniva applicato, e la posizione del detto promontorio, rispetto all’isola di Tavolara»\24\.
Dalla quale attenta considerazione del Panedda si deve dedurre che la denominazione di Punta su Timone deve essere molto antica. E infatti c’è da considerare che per i naviganti antichi, privi come erano dei moderni strumenti di orientamento astronomico e radiogoniometrico, il riconoscere una determinata isola o un determinato promontorio, con la sua esatta denominazione derivante dalla figura che essi vi vedevano, era una questione di enorme importanza, anche una questione di vita e di morte nel caso che essi cercassero un approdo per sfuggire ad una tempesta.
Ovviamente, come ho dichiarato di ritenere che non sia mai esistito un Ulisse greco che abbia fatto tutti quei viaggi sul mare che l’Odissea gli attribuisce, a molto maggiore ragione dichiaro di non concedere proprio nulla al “portento” della pietrificazione della nave dei Feaci al loro ritorno da Itaca nella loro isola. Io semplicemente interpreto che l’isola di Tavolara apparisse come una grande nave in pietra, con le vele spiegate al vento e col suo timone a poppa sia ai Feaci e cioè ai Sardi Nuragici, sia ai naviganti greci che arrivavano in Sardegna per motivi di commercio oppure perché sbattutivi dalle tempeste. Però nei racconti di questi naviganti greci l’isola di Tavolara finì con l’essere interpretata come la nave dei Feaci che aveva riportato Ulisse nella sua patria, ma che era stata pietrificata da Posidone irato contro i Feaci….
Ed esiste un altro particolare del racconto odisseico che si adatta alla perfezione alla conformazione geologica e geografica dell’isola di Tavolara: secondo il racconto dell’Odissea la nave dei Feaci fu pietrificata da Poseidone nel suo viaggio di ritorno ed inoltre quando già tutti gli abitanti della città la vedevano (Od., XIII 155). E infatti, in primo luogo il fatto che la Punta su Timone e cioè la poppa della nave sia rivolta a nord-est, cioè verso l’Italia, spingeva a intendere che la nave, quando venne pietrificata, era sulla via di ritorno in Sardegna, in secondo luogo l’isola di Tavolara era ed è tuttora veduta da coloro che si trovino nella costa della Sardegna….
Ma c’è un altro particolare almeno curioso: nella costa orientale di Tavolara esiste un ampio arco di calcare, ben visibile da tutti i naviganti che si avvicinano all’isola: lo si è chiamato l’ “arco di Ulisse”. Ma ad iniziare da quando?
* * *
[OLBIA CAPITALE DELLA SCHERIA]
L’aver identificato la mitica nave pietrificata dei Feaci dell’epopea odisseica con la odierna e reale isola di Tavolara ci consente di procedere a un’altra importante identificazione: la capitale dei Feaci, la città del re Alcinoo, della regina Arete e della principessa Nausicaa, era la città che in seguito, per effetto di uno stanziamento greco molto più tardo, finì col chiamarsi Olbia….
Io respingo con decisione la tesi sostenuta di recente da un archeologo secondo cui Olbia sarebbe stata fondata dai Cartaginesi nel 350 a.C.\25\, e sostengo invece che non si possa dubitare per nulla del fatto che il sito di Olbia fosse stato occupato in epoca molto più antica già dai Sardi Nuragici. Lo dimostra all’evidenza innanzi tutto il fatto che tutto il retroterra olbiense è risultato ricco di monumenti e reperti nuragici – si pensi al pozzo sacro di sa Testa ed inoltre al santuario fortificato di Cabu Abbas\26\ -, in secondo luogo la circostanza che ai Nuragici non poteva sfuggire l’importanza enorme della baia di Olbia come insenatura difesa dai venti e quindi adattissima alla pesca, all’estrazione del sale ed alla navigazione.
Ebbene, anche la descrizione che l’Odissea fa della città di Alcinoo si adatta abbastanza bene alla situazione geografica di Olbia. Il poeta dell’Odissea dice che la città dei Feaci aveva “dall’una e dall’altra parte un bel porto, con una stretta entrata» (Od., VI, 263-264); il che fa intendere che essa era come su un piccola penisola che si infilava nel mare\27\. Orbene questa situazione corrisponde esattamente a quella di Olbia, la quale, prima che venisse creato il lungo molo artificiale che la unisce all’Isola Bianca per consentire l’approdo delle moderne motonavi, aveva un lungo porto a forma di ferro di cavallo, che andava dall’attuale Póltu Romanu, a nord, fino all’altro nella sua riva volta a sud-est, Póltu ‘Étzu\28\. La «stretta entrata» del porto potrebbe essere quella del Póltu Romanu, ora scavalcata da un ponte. Inoltre il poeta dell’Odissea ci dice che la città aveva la «agorá costruita di pietre trasportate e conficcate nel terreno» (Od., VI 266-267): e anche questa è una notazione che si adatta perfettamente con le usanze costruttive dei centri abitati della Sardegna settentrionale, nei quali le piazze lastricate con granito sono una caratteristica inconfondibile.
Ma nel racconto fantastico fatto dall’Odissea dell’ira di Poseidone contro i Feaci c’è un’altro particolare che probabilmente trova anch’esso una esatta conferma nella conformazione della insenatura di Olbia: racconta l’Odissea che Poseidone ottenne da Zeus non solamente il permesso di pietrificare la nave dei Feaci, ma anche quello di nascondere la loro città con un grande monte (Od., VIII 569, XIII 152, 158, 177, 183). E’ probabile che in questo particolare del racconto ci sia un riferimento a quel promontorio costituito dal Monte Maladrommì, il quale effettivamente chiude in parte la vista di Tavolara agli Olbiesi e inoltre sembra chiudere la insenatura di Olbia. Oppure nel citato particolare odisseico può darsi che ci sia un riferimento alla circostanza che l’imboccatura della baia di Olbia ha sempre conosciuto il pericolo di essere interrata dai detriti del fiume Padrogianu; tanto è vero che, per consentire il passaggio delle moderne motonavi, l’imboccatura è stata spesso sottoposta a dragaggio.
E pure la circostanza per cui, mentre Poseidone ottiene da Zeus il permesso di «nascondere la città dei Feaci con un monte», alla fine sembra che egli abbia accolto la preghiera dei Feaci stessi di non portare a compimento la sua grave decisione (Od., XIII 182-183): non potrebbe darsi che i naviganti greci che conoscevano effettivamente, per averla praticata, l’antica capitale dei Feaci, si fossero accorti che il pericolo dell’interramento della imboccatura della baia di Olbia in certi periodi, a seconda del movimento delle onde e delle correnti marine, era particolarmente grave, mentre in altri periodi lo era molto di meno?
Infine il poeta dell’Odissea, quando si dilunga nel presentare le meraviglie dell’orto-giardino di Alcinoo, lascia intendere che l’intera zona fosse particolarmente adatta alla agricoltura: di certo questo particolare non sembrerebbe corrispondere alle attuali condizioni dell’agro dell’odierna Olbia, ma potrebbe adattarsi alle condizioni dei tempi antichi, quando il retroterra di Olbia sicuramente sarà stato molto più fertile di adesso, per il fatto che le acque che vi confluivano saranno state molto più abbondanti e più regolari di adesso in virtù del molto più vasto e più denso manto boschivo dei monti circostanti.
[monti circostanti. D’altra parte la particolare fertilità del sito di Olbia potrebbe essere testimoniata dal bel giardino che era, sino a poco tempo fa, quello della Casa Tamponi, vicinissimo alla riva del mare. L’Odissea e la Sardegna…
Un’ultima considerazione e un’ultima domanda che mi propongo io stesso: se fosse vero che effettivamente l’isola dei Feaci non era altro che la Sardegna dell’età nuragica, per quale motivo il poeta dell’Odissea parla dell’isola dei Feaci per l’appunto e non affatto dell’isola dei Sardi? La facile risposta si potrebbe trovare in una circostanza che ho indicato in precedenza: nella Sardegna nuragica non è mai esistito un potere centrale e una capitale dell’isola intera. La Sardegna nuragica era fondata e governata secondo un sistema cantonale o federativo di più tribù o popolazioni. Ebbene i Feaci saranno stati i Sardi che vivevano nella zona che fa capo ad Olbia e alla sua baia. I Feaci e il loro re Alcinoo avranno avuto una notevole importanza nella Sardegna settentrionale, sia perché Olbia, o – meglio – il centro abitato nuragico che esisteva nell’attuale Olbia, era aperto ai contatti marittimi col mondo italico e con quello greco, sia perché avrà costituito un’importante base di appoggio per tutti i naviganti, sardi e non sardi, che tentavano di attraversare l’importantissima e pericolosa via di mare che erano le Bocche di Bonifacio, via che, ad esempio, portava alla foce del Rodano, dove giungeva il tragitto continentale e fluviale che lo stagno delle isole Cassiteridi e l’ambra dei paesi del Baltico seguivano per arrivare nel Mediterraneo\29\.
E anche per questa precisa circostanza geografica non può sussistere alcun fondato dubbio sul fatto che gli antichi Greci conoscessero da epoca molto antica le coste nord-orientali della Sardegna e quelle settentrionali che danno sulle Bocche di Bonifacio. Ebbene, in quella importante zona della Sardegna nord-orientale i Feaci saranno stati la popolazione più potente e più ricca, tanto che col nome della loro Scherìa il poeta dell’Odissea avrà preferito indicare l’intera isola anziché con quello di Sardó, che con ulteriori svolgimenti diventerà quello tradizionale e definitivo di Sardegna.
E c’è da aggiungere un’altra notazione prettamente linguistica: anche l’etnico Feaci, cioè Pháiakes, probabilmente dimostra di appartenere al fondo linguistico nuragico, in virtù del suo suffisso –ak, che si ritrova ad esempio, anche negli appellativi protosardi nuráke «torre di pietra» e neuláke «oleandro», ecc.
Concludo riassumendo quelli che mi sembrano essere i risultati effettivi della mia odierna ricerca:
1°) Dato che il mondo dell’Odissea risulta avere avuto come spazio geografico il Mediterraneo centrale e come tempo cronologico i secoli XIII-VIII a.C. e d’altra parte la Sardegna in quello spazio e in quel periodo risulta avere avuto un ruolo notevole e addirittura un primato civile e culturale sulle altre terre circostanti, è pressoché assurdo ritenere che questa non abbia avuto un qualche ruolo anche in quel poema. Per eliminare questa singolare incongruenza e quasi vera e propria assurdità, si deve ritenere che il poeta dell’Odissea abbia, sì, fatto riferimento alla Sardegna, ma chiamandola in un altro modo, cioè Scherìa o isola dei Feaci. E questo mi sembra un risultato della mia ricerca che si presenta con un elevatissimo grado di probabilità.
2°) In virtù della conformazione geomorfica dell’isola di Tavolara, che sembra tuttora una “nave pietrificata” come quella mitica dell’Odissea, si può pensare che i Feaci fossero una delle popolazioni della Sardegna nord-orientale e che la loro capitale fosse quel centro abitato che più tardi si chiamerà Olbia. E questo mi sembra un risultato della mia ricerca che si presenta con un discreto grado di probabilità.
* * *
NOTE
1 – Cfr. A. Heubeck, Omero, Odissea, I-V, Fondazione Lorenzo Valla, Milano, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, vol. III, pag. XI.
2 – Paris, 1927-1929.
3 – Rispettivamente Tübingen, 1968; München-Wien, 1983.
4 – Cfr. W. Marg, in «Gnomon», XLII, 1970, pagg. 225-237; A. Heubeck, art. e loc. cit.
5 – Così G. Chiarini, Odisseo. Il labirinto marino, Roma, 1991, pag. 55, (libro di esegesi omerica pur’esso molto discutibile…).
5 bis – La notevole differenza fonetica che esiste tra la forma greca Odysséus e quella lat. Ulixes ci induce a ritenere che l’antroponimo greco sia entrato nel latino per il tramite etrusco.
6 – Cfr. i recenti studi: E. Cadoni, Il Sardonios gelos: da Omero a Giovanni Francesco Fara, in «Sardinia antiqua, studi in onore di P. Meloni», Cagliari, 1992, pagg. 223-238; G. Paulis, Le “ghiande marine” e l’erba del riso sardonico negli autori greco-romani e nella tradizione dialettale sarda, in «Quaderni di Semantica», XIV, 1 giugno 1993, pagg. 9-50.
7 – Cfr. M. Pittau, La lingua dei Sardi Nuragici e degli Etruschi, Sassari, 1981, pag. 33. Con la quale considerazione viene del tutto meno il sospetto che il passo relativo al «riso sardanio» sia interpolato.
8 – Cfr. Platonis dialogi, curante C.F. Hermann, Lipsia, 1877, scholia in Timaeum 25 B.
9 – Paris, 1957; tradotta in italiano col titolo La Magna Grecia, Torino 1963, VII ediz., cap. VIII.
10 – Cfr. M.L. Ferrarese Ceruti, Ceramica micenea in Sardegna, in «Rivista di Scienze Preistoriche», XXXIV, 1979, fasc. 1/2, pagg. 243-252; Eadem, Documenti micenei nella Sardegna meridionale, in Autori Vari, Ichnussa – La Sardegna dalle origini all’età classica, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano, 1981, pagg. 605-612; F. Lo Schiavo, in «Archeologia viva», XII, 35, gennaio/febbraio 1993, pagg. 14-16.
11 – Cfr. nota 8.
12 – Cfr. M. Pittau Origine e parentela dei Sardi e degli Etruschi. Saggio storico-linguistico, Sassari, 1994, Delfino Editore, 39.
13 – Cfr. M. Pittau, op. cit., 41, 46.
14 – G. Patroni, La Preistoria, Milano, 1951, pag. 474. Cfr. E. Pais, Sardegna prima del dominio romano, in «Atti della R. Accademia dei Lincei», VII, 1880-1881 (ristampa anastatica, Cagliari, ediz. Trois, senza data), pagg. 300-301.
15 – Cfr. M. Pittau, La lingua dei Sardi Nuragici e degli Etruschi, Sassari, 1981, 9 e pag. 266; M. Pittau, Lessico Etrusco-Latino comparato col Nuragico, Sassari, 1984, pagg. 18-19.
16 – Cfr. J. Bérard, op. cit., pag. 311, con relative citazioni antiche nella nota 25.
17 – Così J.B. Hainsworth, Omero, Odissea cit., vol. II (1982), pag. 183.
18 – Cfr. M. Pittau, op. cit., 49-51, 63.
19 – Cfr. M. Pittau, op. cit., 61.
20 – Cfr. M. Pittau, Lessico Etrusco-Latino cit, pagg. 61-63.
21 – M. Pittau, Origine e parentela ecc. cit., 25. Per i Salchitani e gli Alchitani vedi M. Pittau, Studi Sardi di linguistica e storia, Pisa, 1958, cap. III. Lascio cadere i Campitani (= attuali Campidanesi) perché la loro denominazione mi sembra che avesse solo un valore geografico, ed i Tibulati, che probabilmente erano soltanto gli abitanti di Tibula = Castelsardo (vedi M. Pittau, Castelsardo-Tibula, in «La Grotta della Vipera», Cagliari, 1987, num. 38/39, pagg. 53-55).
Ritenere che i Nurritani fossero gli abitanti dell’antica città di Nura e cioè della attuale Nurra oppure, in subordine, dell’attuale villaggio di Nurri, sulle pendici meridionali del massiccio del Gennargentu, mi sembra molto più verosimile che non ritenere che fossero gli abitanti della zona di Núoro. Questa seconda ipotesi è stata sostenuta in base ad un cippo terminale rinvenuto presso Orotelli, che porta la dicitura FIN NURR, la quale è stata interpretata come FINES NURRITANORUM [cfr. M. Bonello Lai, in La Tavola di Esterzili, Atti del «Convegno di studi, Esterzili, 13 giugno 1992» (Sassari, 1993) pagg. 175-177]. Io invece interpreto questa scritta come FINES NURDOLENSIUM «confini dei Nurdolesi», ossia di un villaggio Nurdòle, che esisteva ancora nel Medioevo (CSP 43, 194, 195, 269, 270, 324) e di cui rimangono ancora il toponimo ed inoltre i resti ad una decina di chilometri dal luogo di rinvenimento del cippo, nella medesima lunga e larga vallata che porta dal fiume Tirso a Núoro.
22 – Cfr. G. Spano, nel «Bullettino Archeologico Sardo», III (1857), pagg. 169-170; G.D. Serra, Etruschi e Latini in Sardegna, in «Mélanges de philologie romane offerts a M.Karl Michaëlsson», Göteborg, 1952, pag. 412; S. Satta, Il giorno del giudizio, Padova, 1977, I ediz., passim; M. Pittau, Origine e parentela ecc. cit., 30.
23 – Cfr. E. De Felice, Le coste della Sardegna. Saggio toponomastico storico-descrittivo, Cagliari, 1964, pagg. 31-32; A. Papurello Ciabattini, Il profilo geografico di Tavolara. Sardegna, Cagliari, 1973; D. Panedda, I nomi geografici dell’agro di Olbia, Sassari, 1991, pagg. 614-615.
24 – D. Panedda, op. cit., pag. 625, num. 2161. Numerose raffigurazioni di navi antiche si trovano nel libro di O. Höckmann, Antike Seefahrt, München, 1985, trad. ital. La navigazione nel mondo antico, Milano, 1988.
25 – R. D’Oriano, in Autori Vari, Olbia e il suo territorio – Storia e archeologia, Olbia, 1991, pag. 53.
26 – Cfr. la stessa op. cit., Olbia e il suo territorio, pagg. 35-49.
27 – «Il luogo è pensato come una penisola con insenature portuali su entrambi i lati dell’istmo», così J.B. Hainsworth, op. cit., pag. 221, a proposito di Od., VII 43.
28 – Cfr. D. Panedda, op. cit., pag. 475 num. 1663 bis e pag. 476 num. 1668.
29 – Cfr. M. Pittau, Origine e parentela ecc. cit., 52.
L’ODISSEA COM’È: CANTI I-XII ⇒
di Mario Zambarbieri
Milano, Edizioni universitarie di lettere economia diritto, 2002
Presentazione di Gallura Tour: Un ottimo libro che fa un ottimo excursus storico-letterario sull’Odissea e i viaggi di Ulisse
ben 31 citazioni di Victor Bérard (48. 111. 112. 139. 169. 194-195. 206. 240. 259. 272. 276. 282. 291. 299. 303. 318. 321. 332. 333. 358. 362. 450. 452. 524. 661. 726. 729. 733. 738).
Il mondo di Odisseo. Cosmologia e geografia omerica
I poemi omerici sono opera di fantasia e documenti storici in senso vichiano; e con- tengono la testimonianza del sapere umano dei tempi in cui furono composti. Per questo la ricerca cosmologica e geografica che abbia per fondamento la poesia omerica è pienamente giustificata, anche se essa deve porsi dei limiti precisi. Necessario per il lettore lo studio di G. Arrighetti, Cosmologia (1966, 1975), che offre un valido contributo di dottrina su tre piani: storico, metodologico, ermeneutico.
Il saggio presuppone la conoscenza critica di una vastissima letteratura scientifica che negli ultimi due secoli ha indagato i principi della cosmologia e della geografia omerica; e nelle note offre indicazioni preziose su autori come Völcker, Berger, Kranz, Hennig, Kopp, oltre naturalmente a Kirchhoff, Wilamowitz, Focke, Von der Mühll. Sul piano metodologico Arrighetti propone di fissare alcuni punti fermi circa le seguenti questioni: 1) quali sono i dati veramente validi che Omero offre ai fini di un orientamento nell’itinerario avventuroso di Odisseo; 2) se il testo omerico è ovunque in armonia con essi (p. 165). Nel saggio vengono toccati i problemi suscitati dagli Apologhi; Omero concepisce la terra in forma di disco privo di profondità, circondata da un fiume che le gira intorno, e che in relazione all’Ade assume connotazioni occidentali (pp. 147 e 180); del mondo fisico egli ha una visione unidirezionale: nel senso est-ovest (p. 148). Notte e Giorno sono delle realtà esistenti di per sé, di natura demonica, che apportano la luce o le tenebre (p. 151).
In contrasto con Kirchhoff, Wilamowitz e Lesky, l’Autore sostiene giustamente che le avventure di Odisseo si svolgono tutte nel mondo occidentale: l’Ade ha un posto fisso e immutabile nella visione del cosmo, e questo è ad ovest (p. 167). Nelle peripezie di Odisseo, superato il capo Malèa (IX 80), tutto diventa oscuro, se non che la direzione prevalente è l’ovest, dove se déroulent les eaux mystérieuses de l’épouvant e de la nuit (Bérard, Odyssée, p. 263). Dimensione fantastica del racconto e indeterminatezza geografica: ecco due motivi che inducono alla prudenza, ma non impediscono di dare alla navigazione odisseica il significato di un’ardimentosa esplorazione dell’Occidente, come il viaggio degli Argonauti lo era stato dell’Oriente.
Su questo tema è interessante la relazione Omero e l’etnologia, tenuta da Oswyn Murray al VII Congr. Internaz. Studi sulla Sicilia antica (Palermo 1988): «Se vogliamo capire la risonanza che l’Odissea ebbe per il pubblico contemporaneo, dobbiamo imparare a leggerla come l’espressione poetica dell’esplorazione dell’ovest, non semplicemente come un viaggio nell’immaginario» (Magna Graecia 24, 9-10, 1989, pp. 1-6, qui p. 3).
Sono note le riserve di Strabone (Geogr. 1 24) e l’ironia di Seneca (Epist. 88, 7) circa lo zelo degli antichi eruditi; e solo a fini pratici credo utile lo schema geografico proposto da Valgimigli (IX, p. 8 Poeti II, p. 51).
Quanto ai moderni, mi limito a ricordare alcuni nomi.
- Bérard è il più illustre: non dico qui della sua Introduction à l’Odyssée (Paris 1924-1925), e della discussa edizione e traduzione del poema in 3 tomi (1924-1933), bensì dei volumi di geniali, avventurose, ricerche mediterranee sulle orme di Odisseo: Les Phéniciens et l’Odyssée, Paris 1902-1903, 1927; Les navigations d’Ulysse, Paris 1927-1929; Dans le sillage d’Ulysse. Album odysséen, Paris 1933.
Un riassunto delle sue idee è tracciato dal figlio Jean in La colonisation grecque de l’Italie méridionale et de la Sicile dans l’antiquité. L’bistoire et la légende, Paris 1957, trad. it. P. Bernardini Marzolla, La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell’Italia meridionale, Torino 1963, pp. 307-313.
Forse il meglio del suo insonne lavoro è raccolto nella sintesi, L’Odyssée d’Homère, Paris 1931. Guidato dall’idea che le avventure di Odisseo siano la trasfigurazione delle esplorazioni semitiche nel Mediterraneo occidentale, Bérard cerca di identificarne le tappe favolose in luoghi, isole, coste, promontori della geografia reale, e si fonda su due elementi di identificazione: la duplice denominazione (semitico/greca) e i dati della realtà.
Nel numero citato di Magna Graecia (pp. 14-16) si può leggere un istruttivo Omaggio alla memoria di J. Bérard, nel cui testo, di E. Manni, è inserita una bellissima fotografia dei due Bérard, padre e figlio.
I rapporti tra dati fantastici e geografia reale sono esaminati con acume da W. Kranz, Die Irrfahrten [errori des Odysseus (Hermes 50, 1915, pp. 93-112), che, a prescindere da identificazioni rischiose (Scheria Creta, p. 96), di fronte all’irreducibilità dei caratteri nord-orientali dell’isola Eèa, immagina l’esistenza di due modelli dell’Odissea, un Mittelmeergedicht, o poema mediterraneo, e un Pontosgedicht, o poema pontico (p. 109).
L’impossibilità (e perciò l’irrilevanza ai fini della critica) di giungere alla conciliazione dell’esigenza fantastica propria della poesia e di quella scientifica che ispira la ricerca geografica è ribadita in forme di raffinata erudizione e di eleganza espressiva nelle varie opere geografiche ed etnografiche di A. Lesky: Θάλασσα, «Hermes 78 (1943), pp. 258-269 (- Ges. Schrift., pp. 468-478); Thalatta. Der Weg der Griechen zum Meer (Il cammino dei Greci verso il marel, Wien 1947; Aia, WS 63 (1948), pp. 22-68 (26-62); Aithiopika, – Hermes 87 (1959), pp. 27-38 (410-421).
Ben lungi dal realismo illusorio di Bérard, che vedeva l’isola Eèa nel promontorio del Circeo, Lesky colloca la dimora di Circe nella regione dove sorge il sole, e dove il sole torna ogni notte, secondo l’intuizione poetica di Mimnermo. Un’Aia occidentale non esiste (Aia, p. 49). La localizzazione nel Mediterraneo occidentale è più recente di Omero, ma relativamente antica. Fantasia e geografia si intrecciano in modo inestricabile nella poesia omerica. Tra il capo Malea e i Lotofagi e tra Scheria e Itaca si stendono i confini tra il mondo conosciuto e quello dei mostri e delle isole incantate (p. 58).
Nonostante lo scetticismo dei classicisti, la ricerca degli appassionati è continuata ben oltre; cfr. le opere citate da Lesky in AAW. 13 (1960), p. 20: L.G. Pocock, The Landfalls of Odysseus, Christ Church 1955, e The Sicilian Origin of the Odyssey, Wellington 1957; G. Baglio, Odisseo nel mare mediterraneo centrale, Roma 1957, 1958, e Sommario illustrato dei viaggi marittimi di Ulisse, Roma 1959; O. Zeller, Auf des odysseus und der argo spuren, Aalen 1959.
Una produzione che suscita un senso di sincera disperazione, se si pensa quanto amore per l’argomento, quanta fatica e quanta ostinazione vanno sprecati per cose che alla fine non sono niente altro che scintillanti bolle di sapone (A. Lesky, AAW 13, 1960, p. 20). Ерpure queste ricerche che continuano l’intento ispiratore di R. Wood, di andare in traccia di Omero on the spot- hanno un fondamento nella diffusione storica delle tradizioni post-omeriche sulle avventure di Odisseo in Occidente e soprattutto in Italia. È la tesi di E.D. Phillips, Odysseus in Italy, JHS-73 (1953), pp. 53-67.
I Greci portarono con sé, colonizzando agli inizi dell’VIII secolo a.C. l’Italia e la Sicilia, non soltanto l’Iliade e l’Odissea e i poemi del Ciclo, ma anche altre tradizioni su Odisseo, provenienti dalla Grecia occidentale e meridionale, che erano indipendenti dall’epica ionica (p. 53). Questi antichi colonizzatori dell’Occidente mediterraneo furono i primi a cercare di stabilire un nesso tra l’Odissea e i luoghi che sarebbero stati teatro delle avventure di Odisseo.
Fondato su un’ammirevole conoscenza dei poemi e dei problemi, il libro di L. Moulinier, Quelques hypothèses relatives à la géographie d’Homère dans l’Odyssée (1958), offre un quadro di considerazioni storiche e teoriche sempre valide, accanto a lodevoli rinunce (non localizza la terra dei Lotofagi, p. 50) e a identificazioni discutibili (i Feaci in Libia, pp. 109-118).
Tra le idee più costruttive, l’ipotesi già ricordata che Omero disponesse di due specie di dati geografici, quelli della tradizione poetica e quelli dell’esperienza marinara (pp. 9 e 13); e l’enunciazione di quattro criteri utili per l’identificazione dei luoghi: durata delle navigazioni e direzioni indicate dal poeta, paesaggio, scoperte archeologiche, leggende locali (pp. 15-31). Nella sua recensione Broccia (Paideia 15, 1960, pp. 192-198) riconosce la validità di queste ricerche e, rifacendosi a Germain (pp. 511, 514, 572, 574), ne ricorda i mòniti circa il rapporto tra geografia e poesia, e la prudenza necessaria al critico che si avvicina alla geografia odisseica.
Degna di attenzione per le conoscenze pratiche del mare e della navigazione a vela, più che per la (scarsa) originalità delle soluzioni proposte nel nostro caso, un pregio – è l’opera di un ufficiale di marina inglese, E. Bradford, Ulysses Found (London 1963, trad, ted. Reisen mit Homer, DTV 1967), un libro fondato su innumerevoli osservazioni dal vivo e sulla convinzione che sia possibile identificare le tappe del viaggio di Odisseo, come ci viene raccontato dal poeta. Conclusioni: i Lotòfagi vivono a Djerba, i Ciclopi presso Trapani; l’isola di Eolo è Ustica, la terra dei Lestrigoni, Bonifacio; l’isola di Circe è il Circeo, l’Ade si trova oltre Gibilterra, Taormina è il porto di Trinacia. La ricerca di Bradford contiene troppe contraddizioni con i dati offerti da Omero per poter essere riconosciuta come soluzione del problema.
La critica si legge in un’opera (p. 182) che può essere considerata continuazione e antitesi di Bradford: A. e H.-H. Wolf, Die wirkliche Reise des Odysseus. Rekonstruktion des homerischen Weltbildes [Il viaggio reale di Odisseo. Ricostruzione della concezione omerica del mondo, München – Wien 1968 (2ª ediz. 1990, a cura di A. Wolf). L’opera contiene una rassegna delle teorie geografiche dall’antichità ai nostri giorni, e molti utili dati storici, cartografici e fotografici raccolti sull’argomento. Giusta l’affermazione che alla base del poema sono conoscenze della geografia reale (p. 115); le riserve cominciano quando dalle idee generali si passa all’applicazione pratica.
Si veda in Gnomon 42 (1970), pp. 225-237, la recensione di W. Marg all’edizione del 1968 che, pur tra severe critiche, salva il ragguaglio storico di Arnim Wolf (pp. 143-206) e lo schema costruito con criteri puramente geometrici (p. 226) delle direzioni di viaggio (p. 16).
Segnalo di R. Salinas Price, Atlas of Homeric Geography (San Antonio, Texas, 1992), testo storico ricco di carte geografiche, diagrammi e bibliografia, la cui prefazione comincia con queste parole: «The fundamental premise of his atlas is that Homeric Troy and Homeric Ithaka evinced in the text of the Iliad and the Odyssey, respectively – are to be identified with the central portion of Yugoslavia’s Adriatic Coast» (p. 7).
Tra i più recenti studi italiani concepiti come avventurose esplorazioni nella preistoria (mitologia e geografia), ricordo V. Manfredi L. Braccesi, Mare greco. Eroi ed esploratori del Mediterraneo antico (Milano 1992), opera avvincente e ricca di informazioni (i primi tre capitoli riguardano Odisseo, le esplorazioni antiche dell’Occidente e il mondo dei ritorni), e un breve saggio di M. Pittau, L’Odissea e la Sardegna nuragica (Quad, bolotanesi 20, 1994, pp. 301- 318), che rivendica all’Odissea come spazio geografico il Mediterraneo centrale e come periodo cronologico i secoli XIII-VIII a.C., quando la Sardegna esercitava un primato civile e culturale sulle altre terre circostanti (p. 318).
La dimensione temporale dell’Odissea
«Tre dimensioni conosce lo spazio; due il tempo, la contemporaneità e la successione». Con queste parole si inizia lo studio di Th. Zielinski, Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse im antiken Epos (La trattazione degli avvenimenti contemporanei nell’epos antico], Philologus, Suppl. VIII (1899-1901), pp. 407-419. Prevedendo obiezioni filosofiche alle sue tesi, dalle quali prende avvio la ricerca sulle conseguenze di un fatto evidente, l’impossibilità per il poeta epico di narrare due azioni contemporanee, egli avverte: il filosofo metafisico contesterà la seconda proposizione e affermerà con Kant l’unidimensionalità del tempo; in realtà l’idea della contemporaneità non è meramente temporale, ma nel caso di stati o condizioni è spaziale, nel caso di processi, spazio-temporale (p. 407). La tesi più nota di Zielinski si riassume in poche righe: «Se il poeta non voleva rinunciare a nessuna di due azioni (contemporanee), le narrava».
© Tutti i diritti riservati