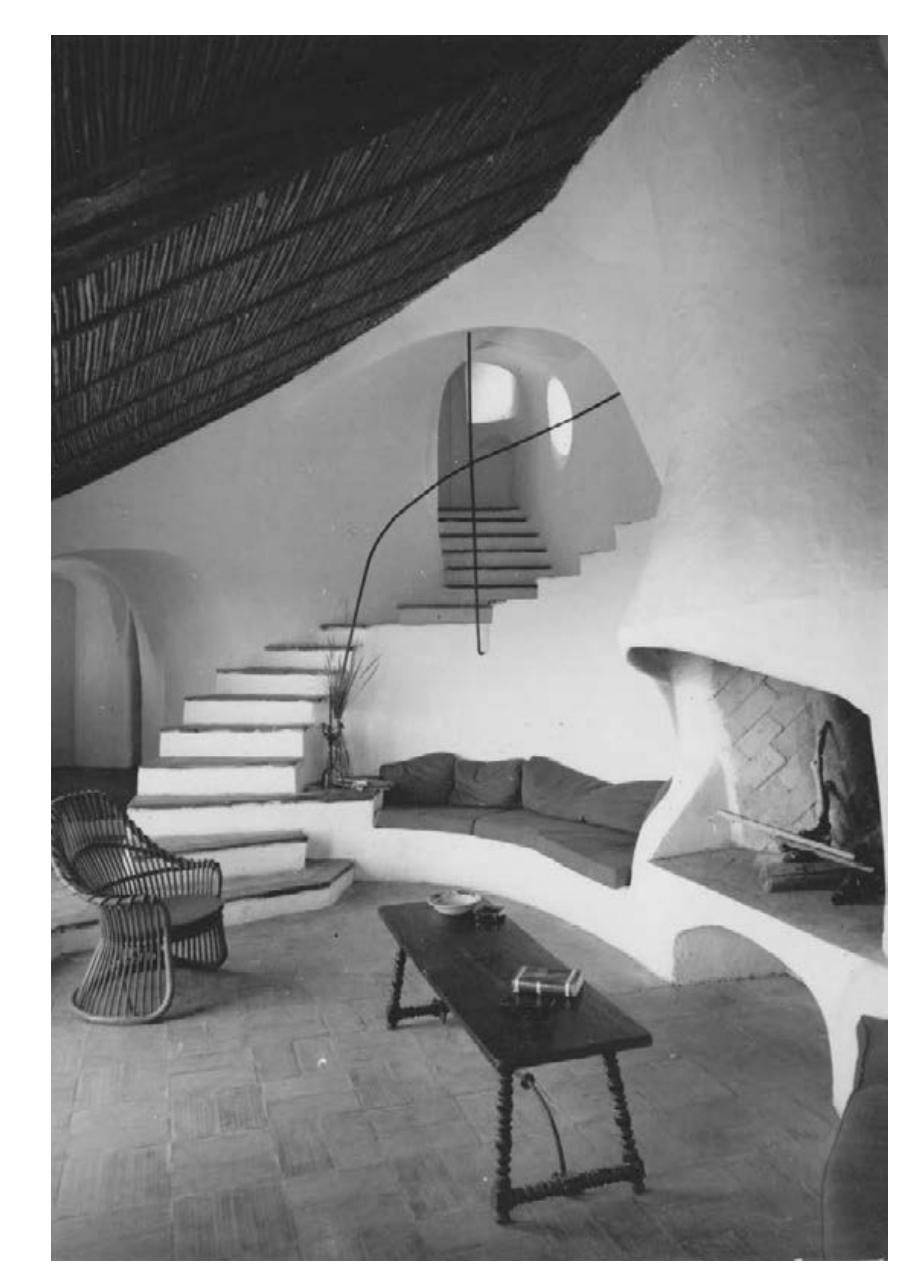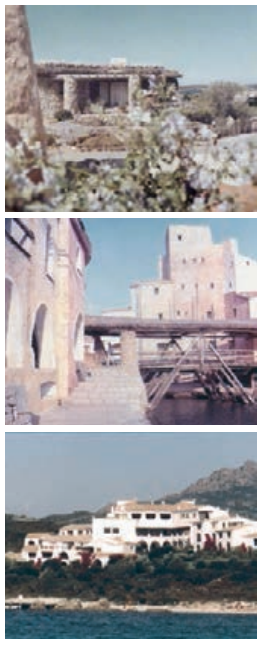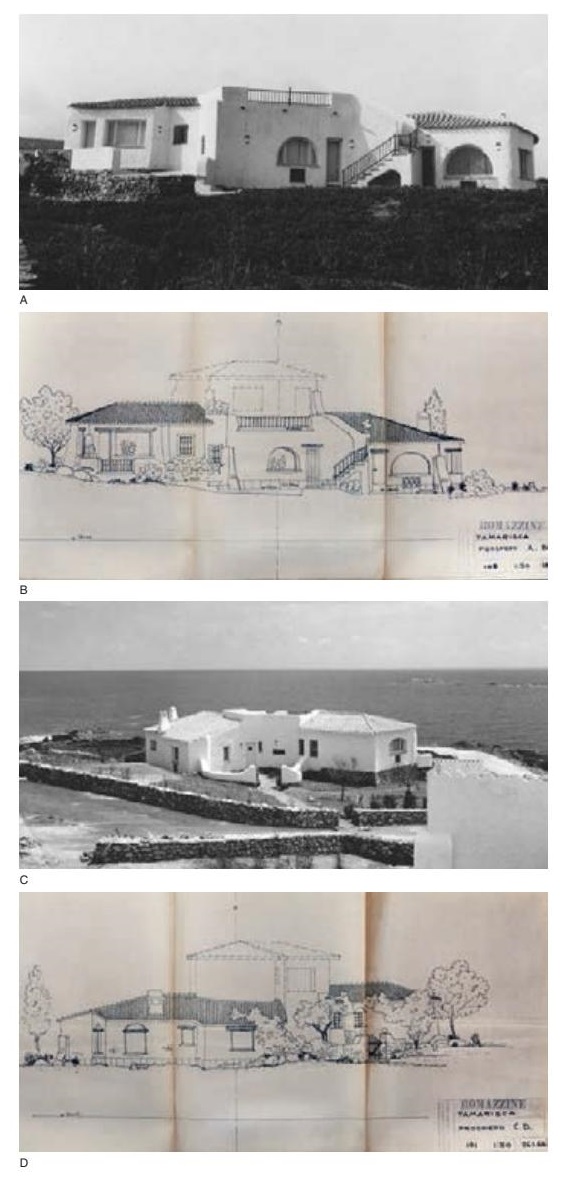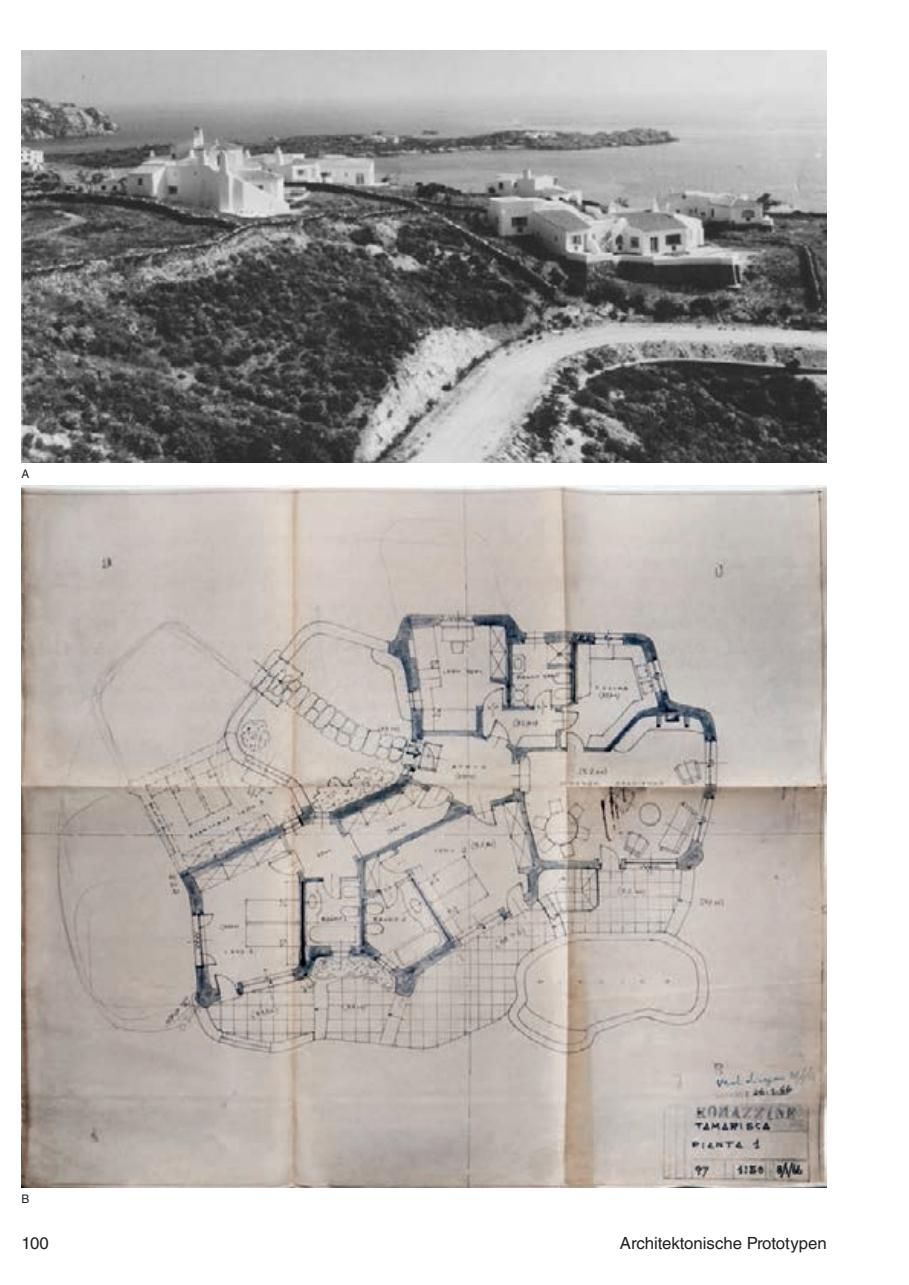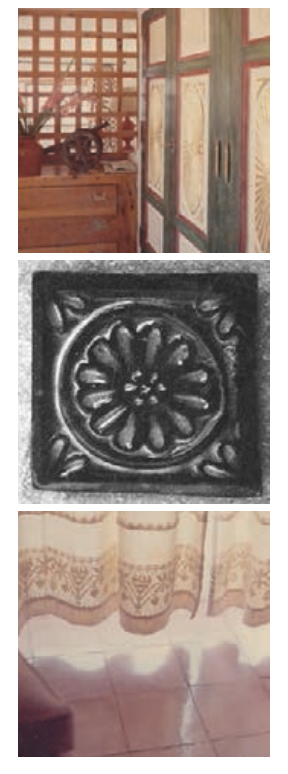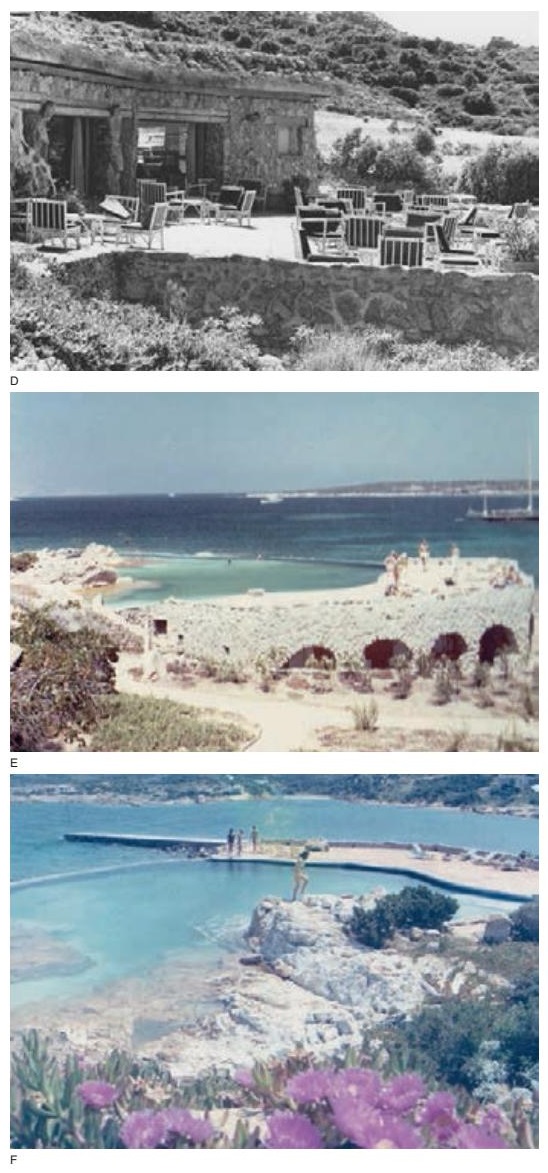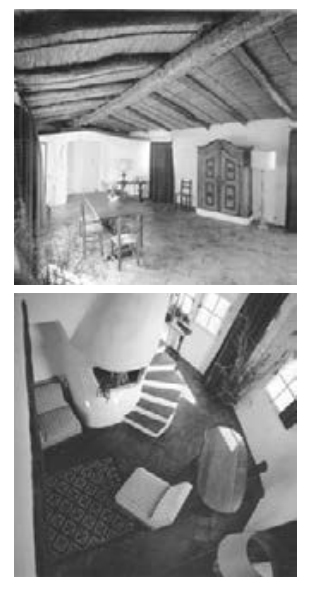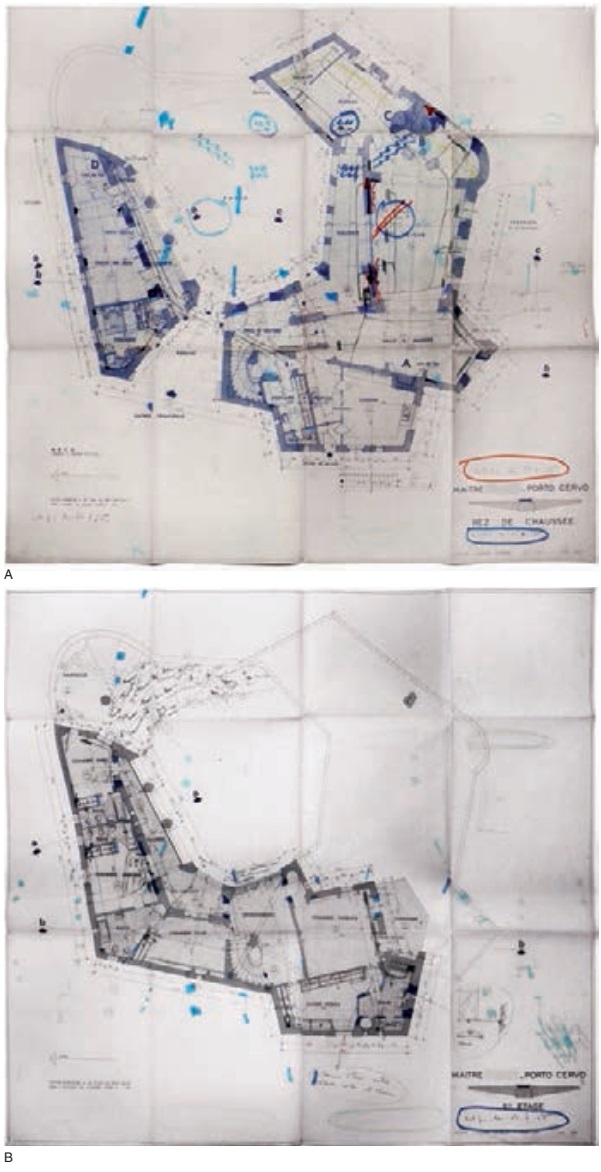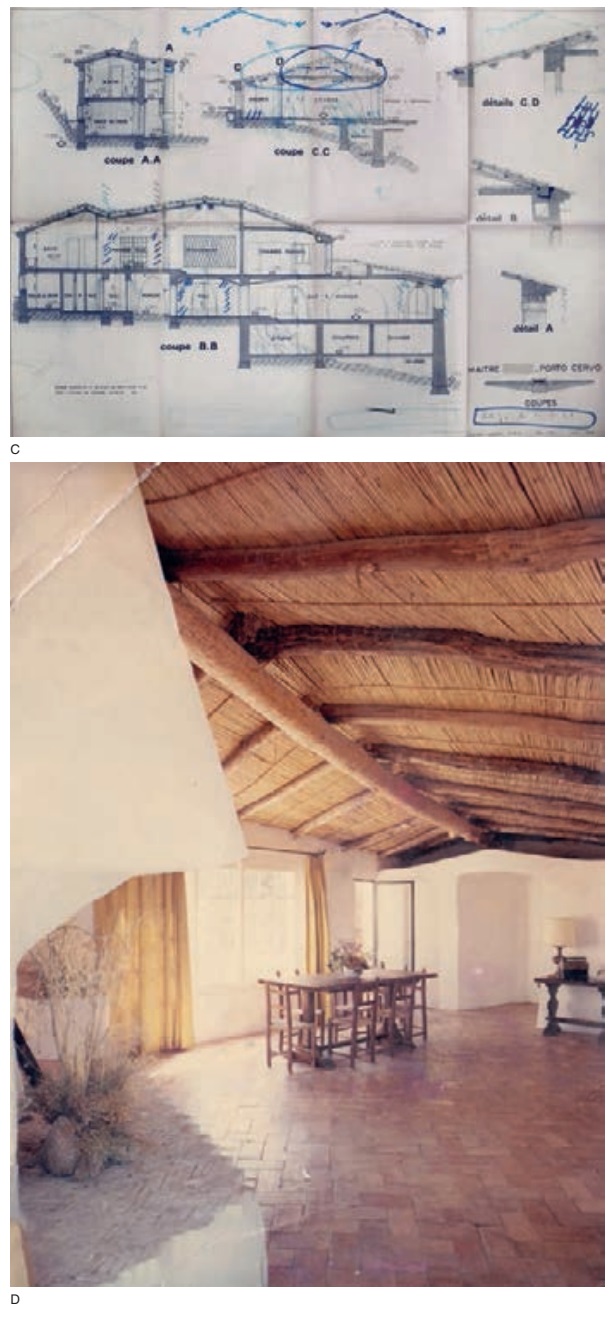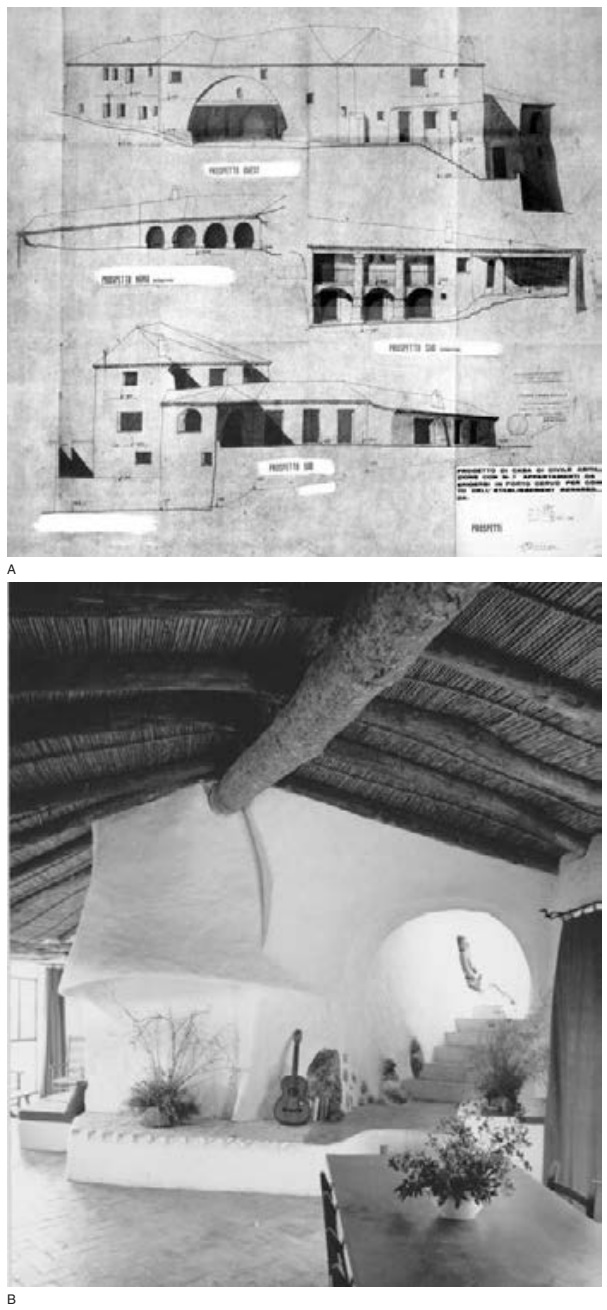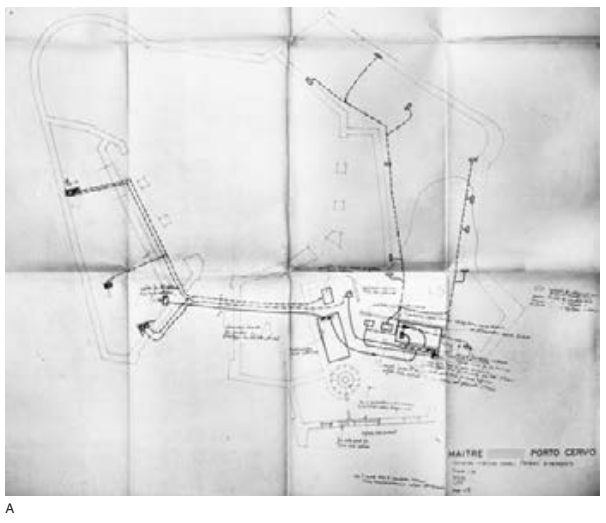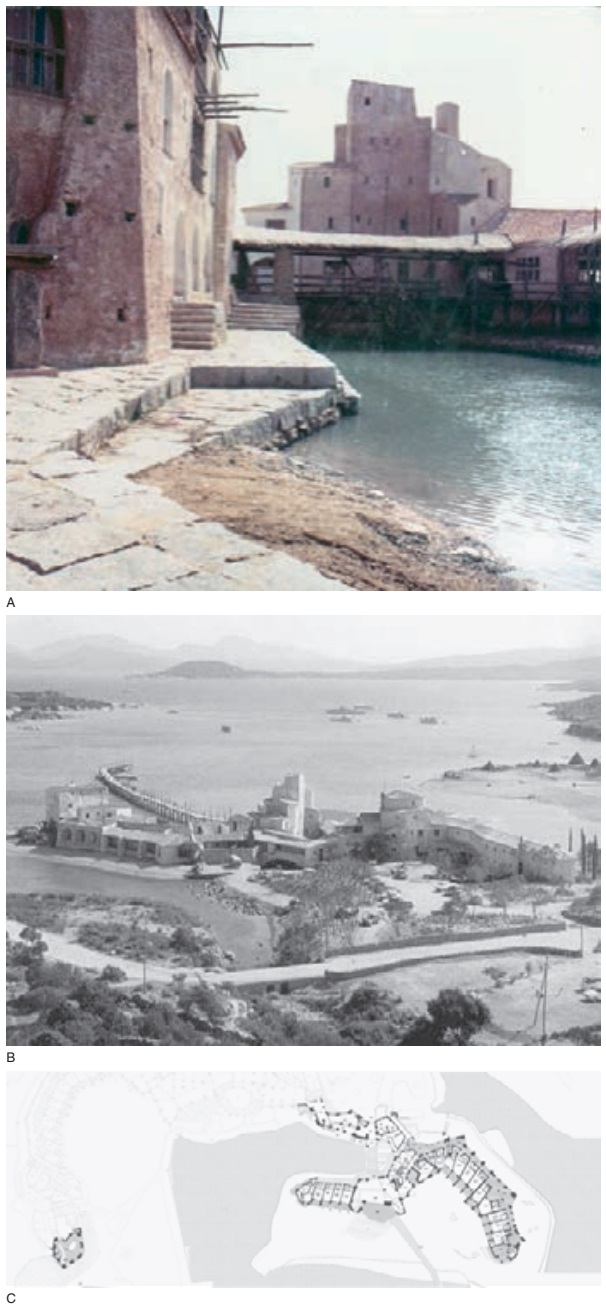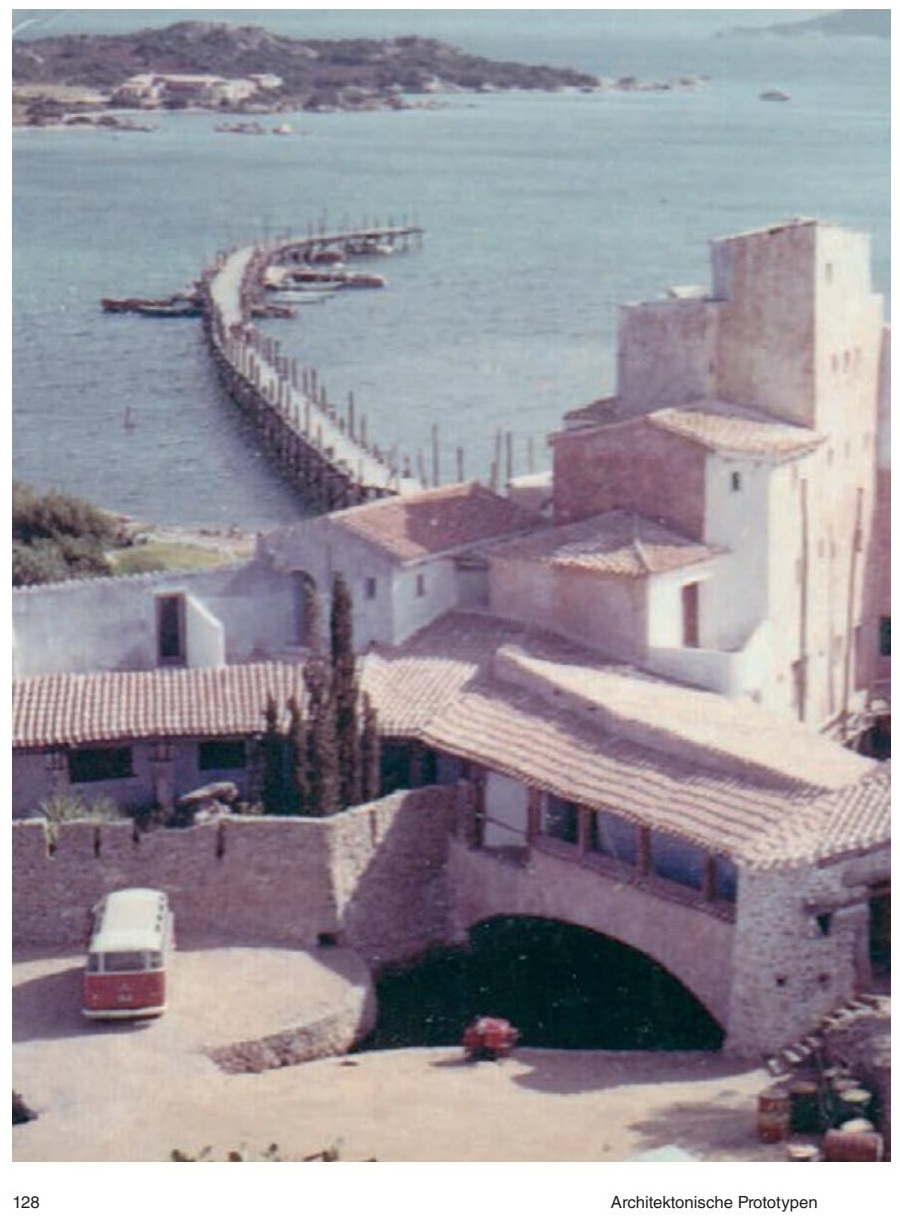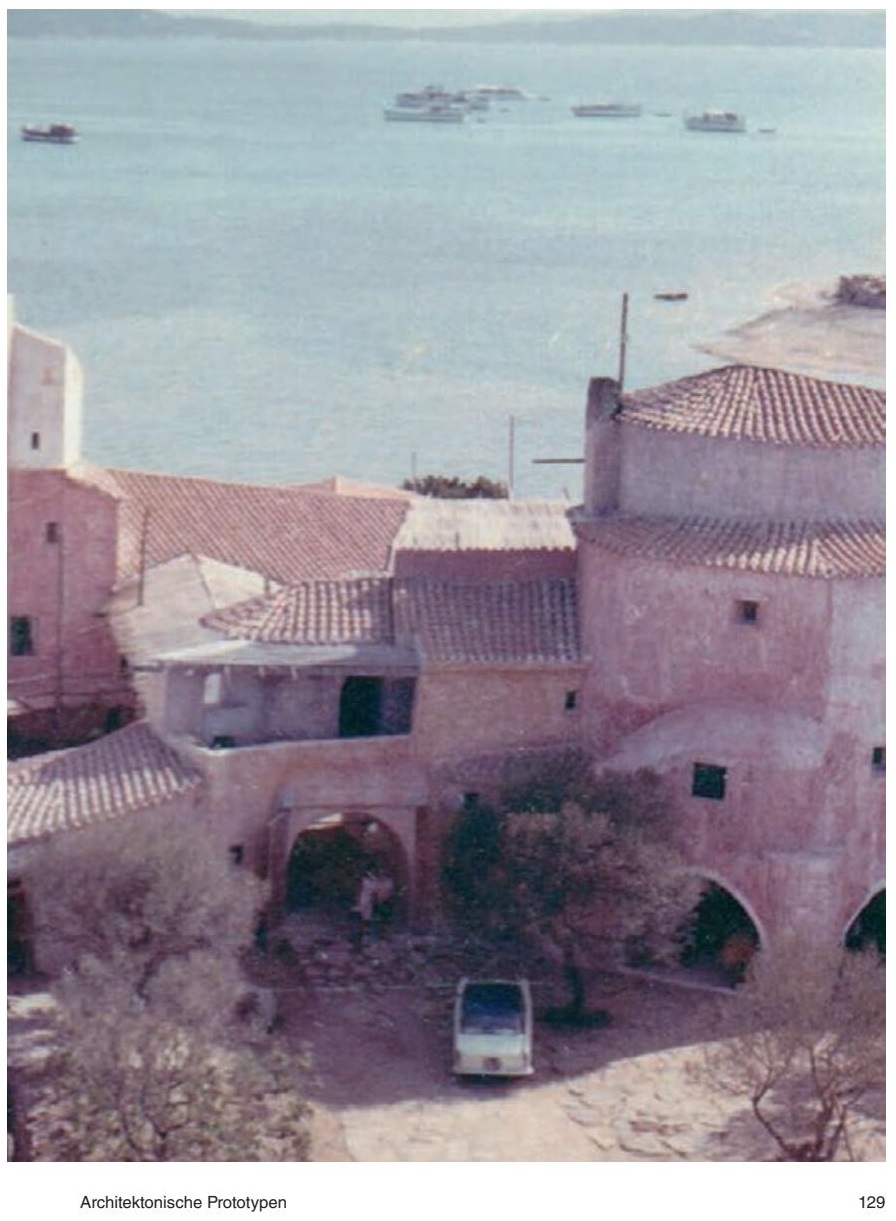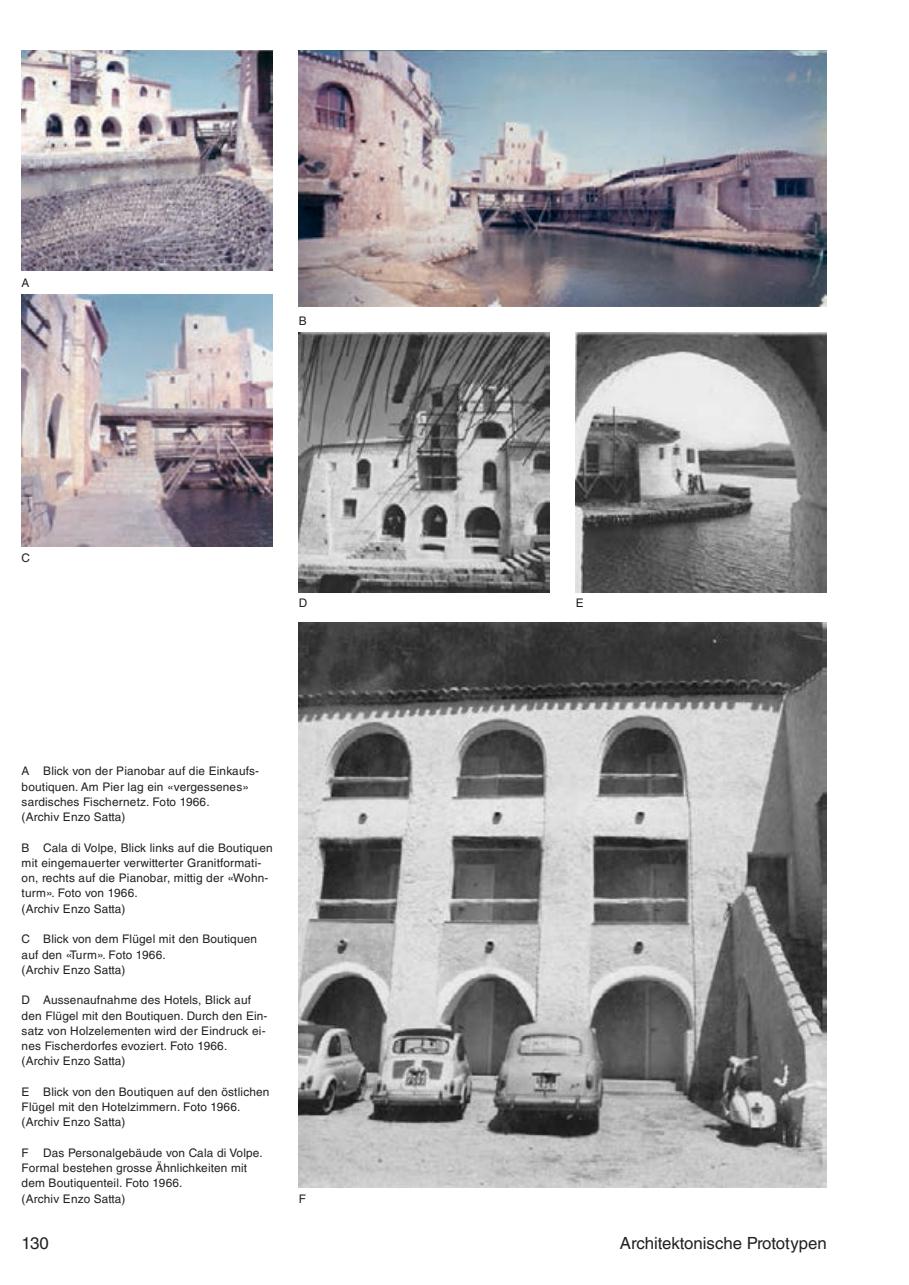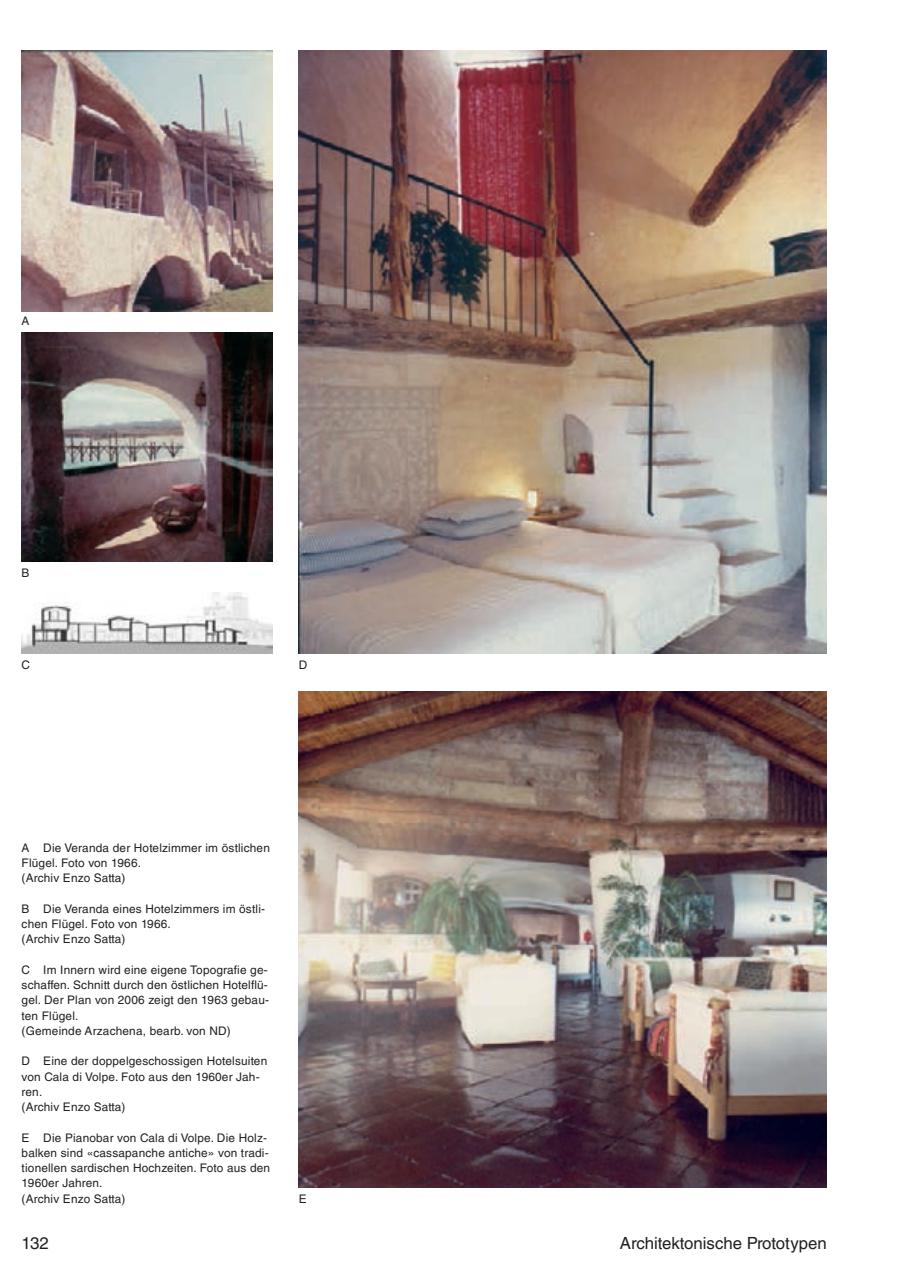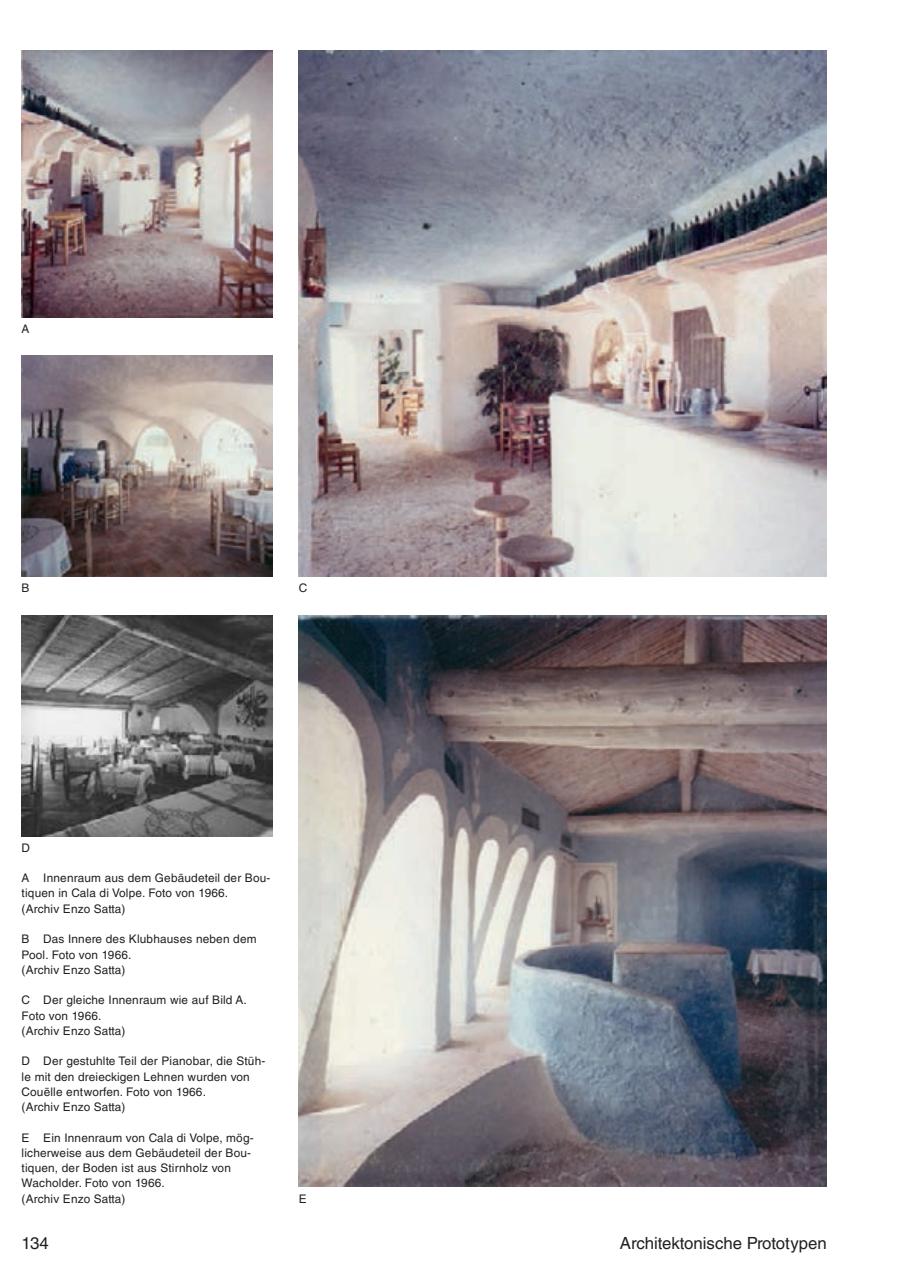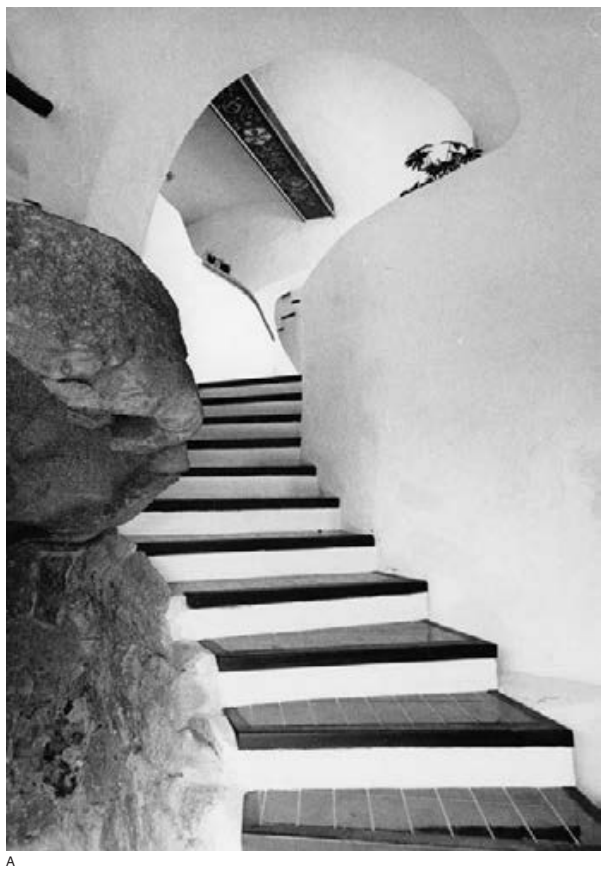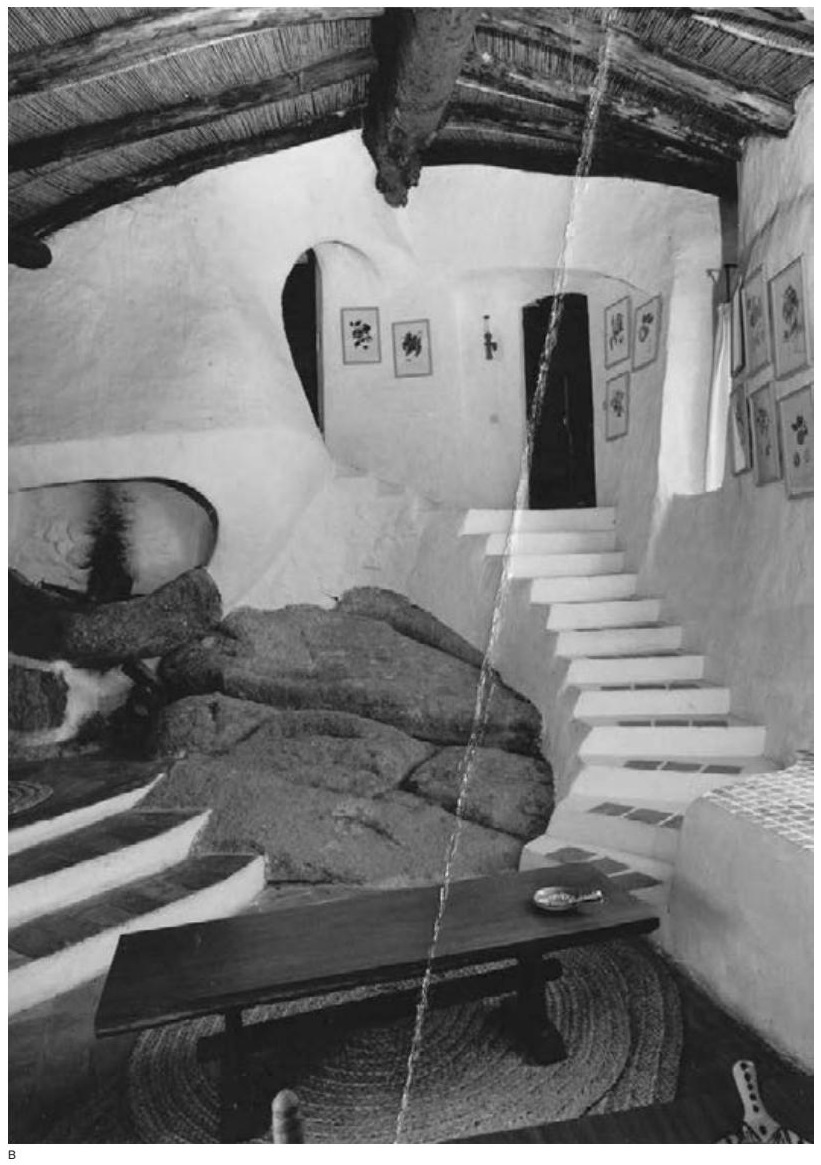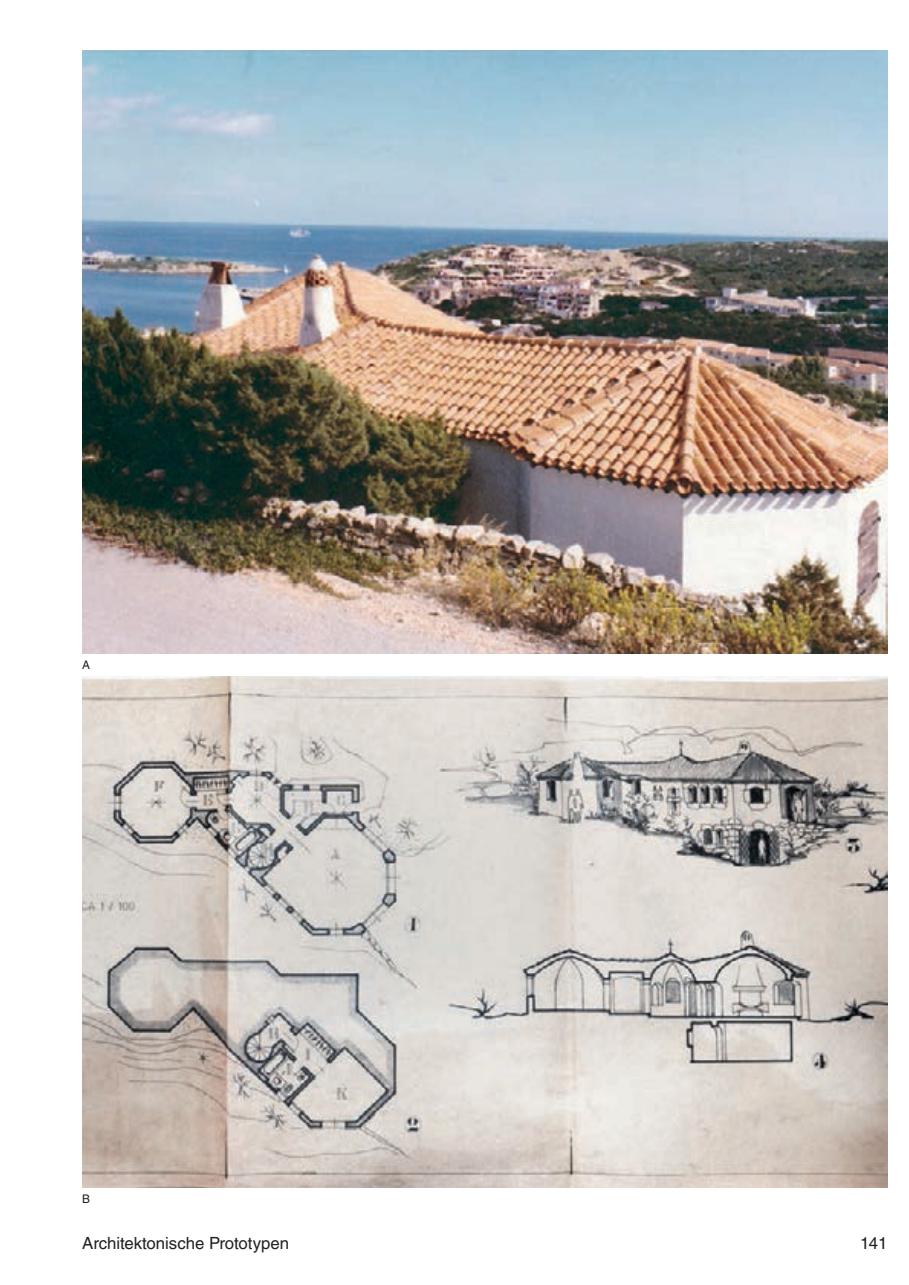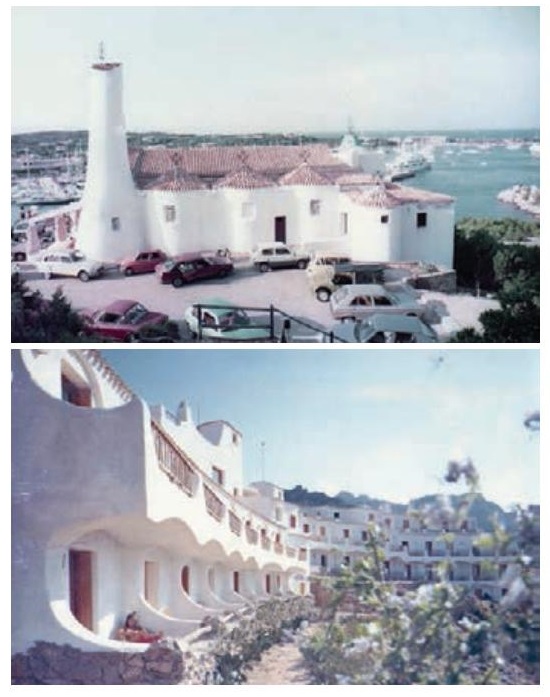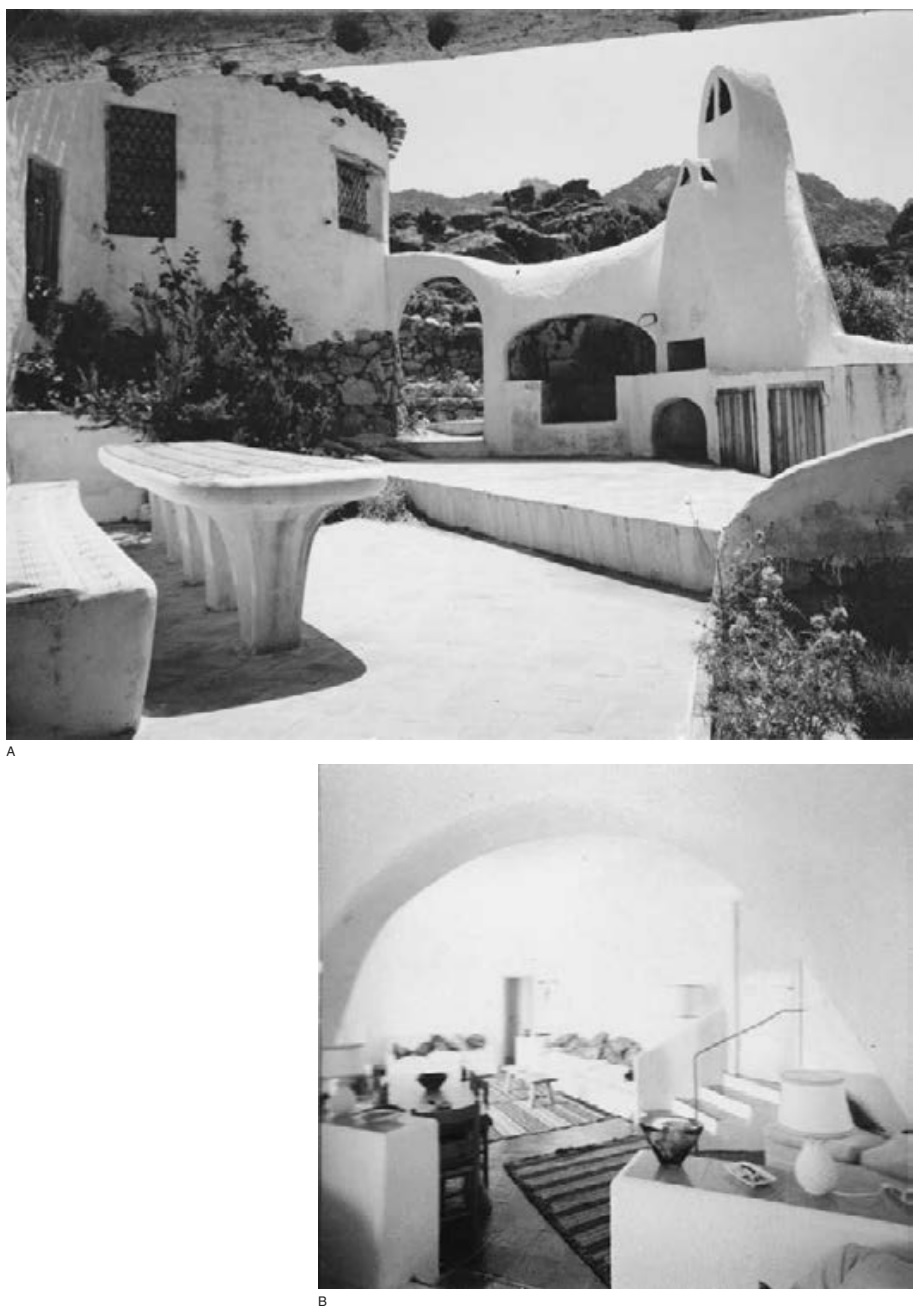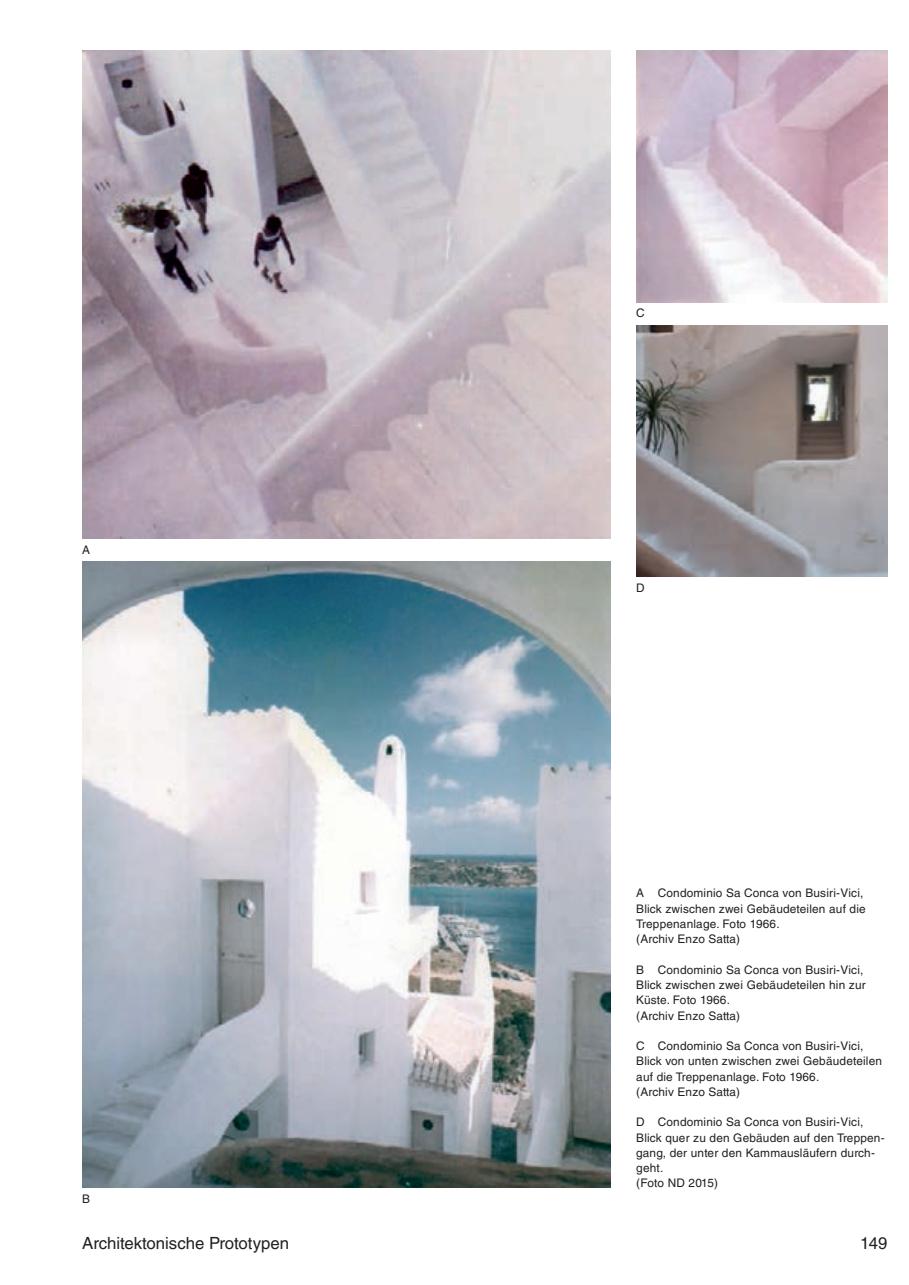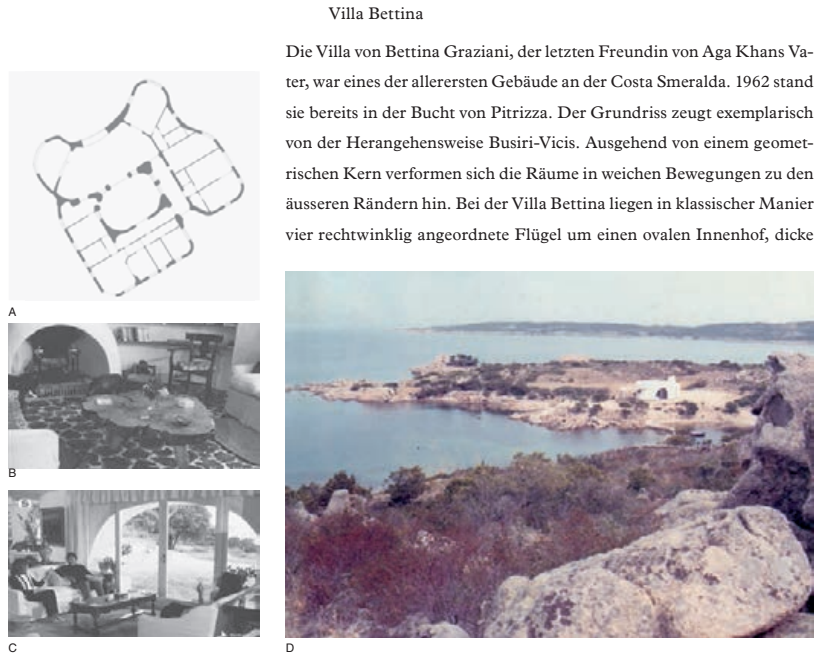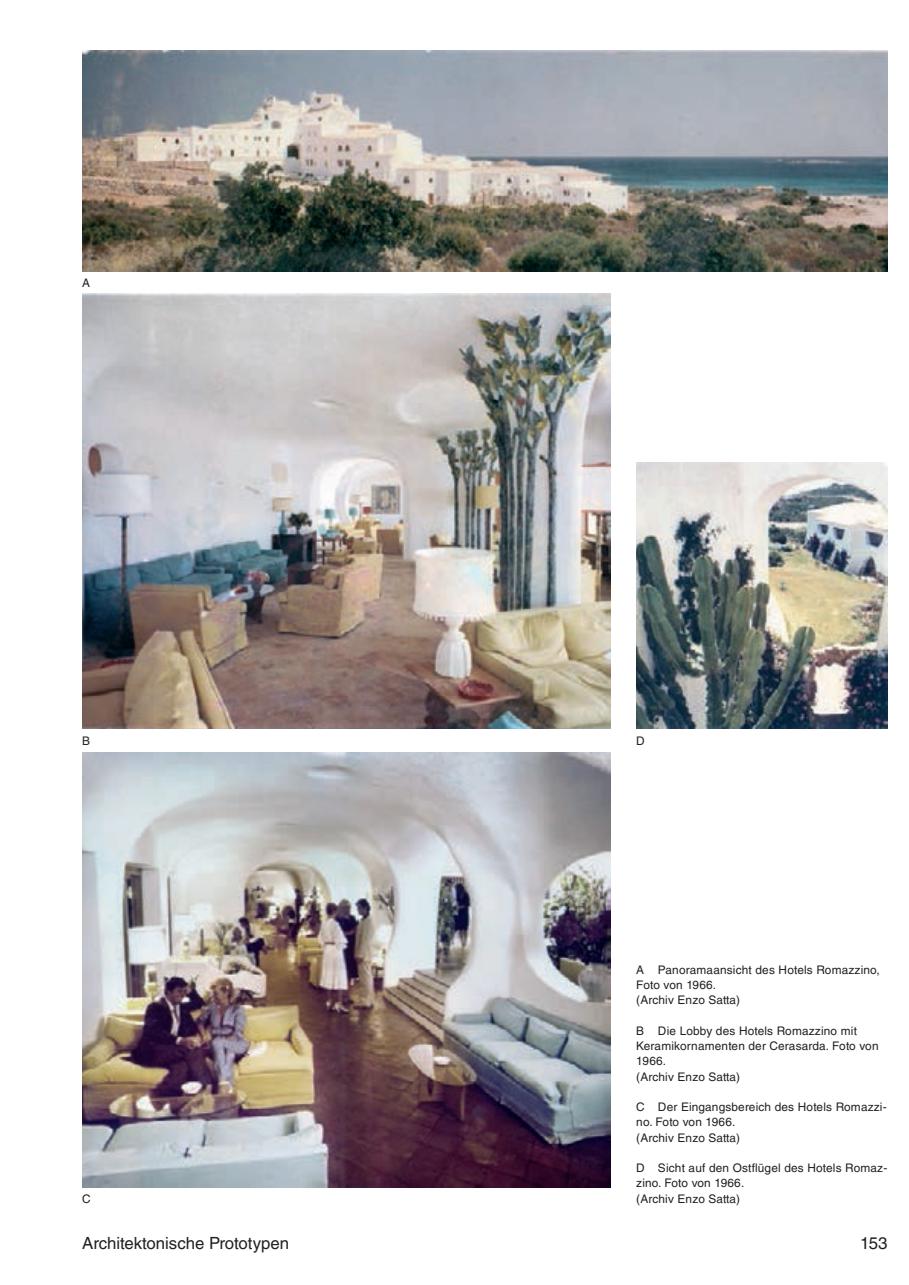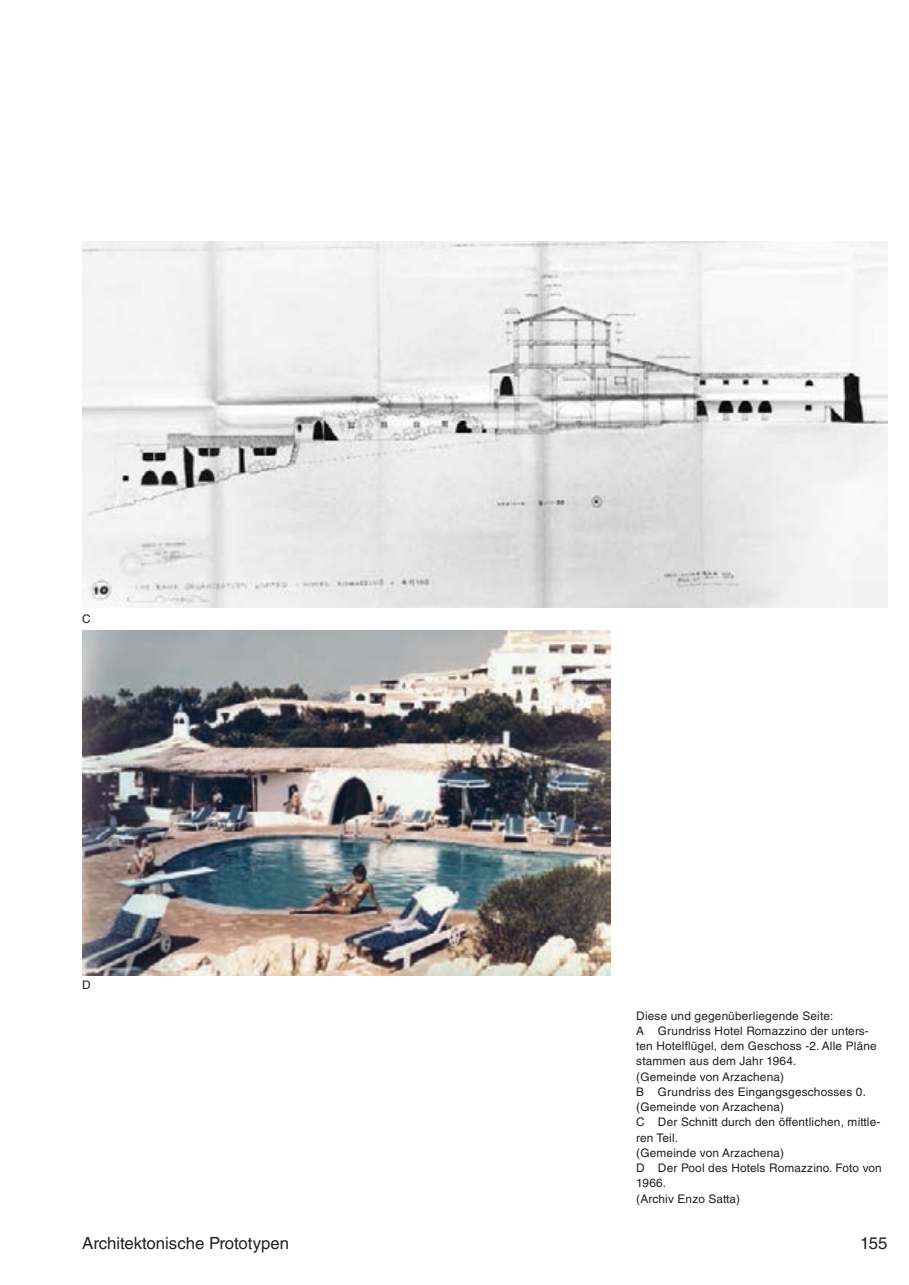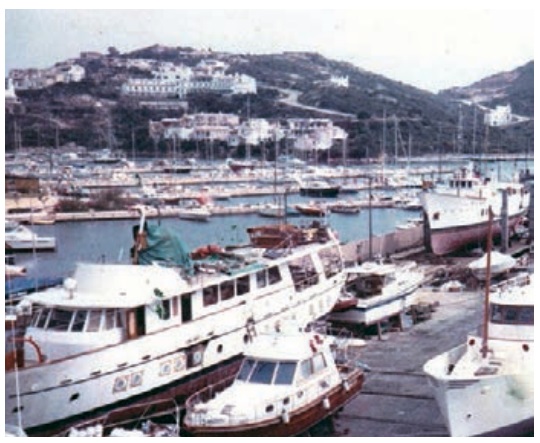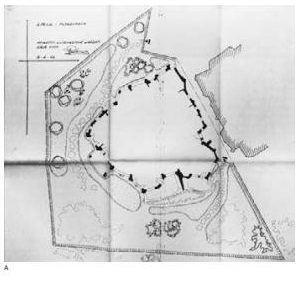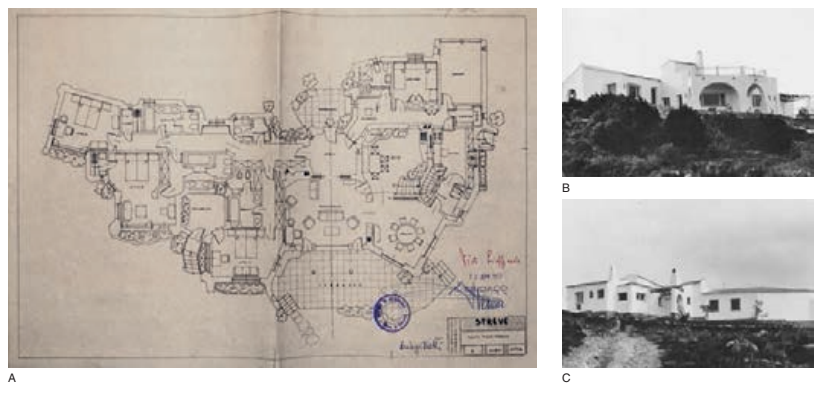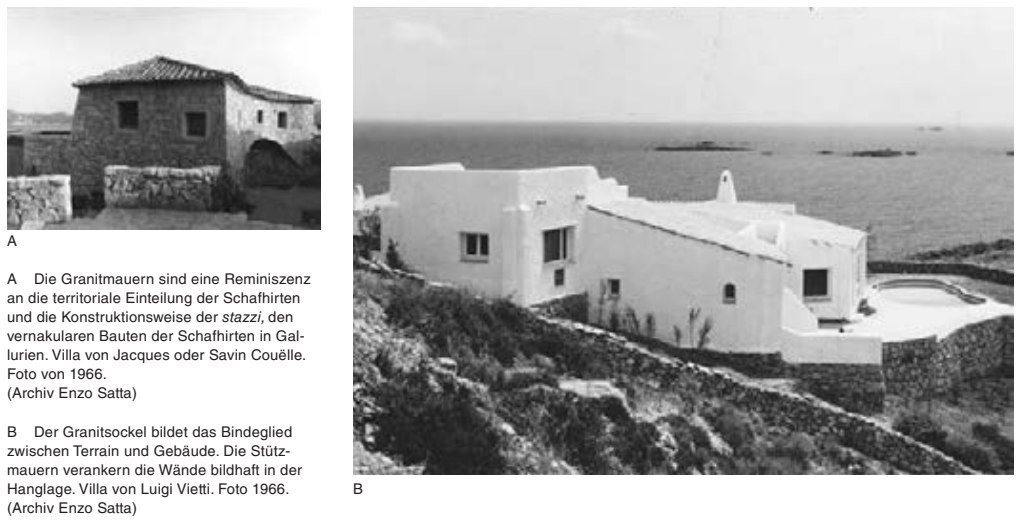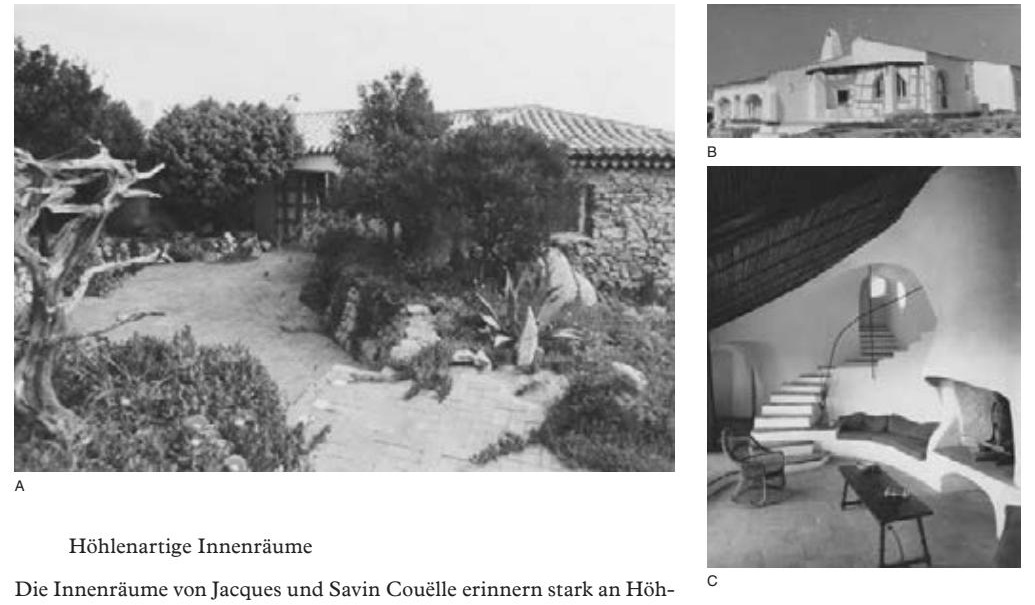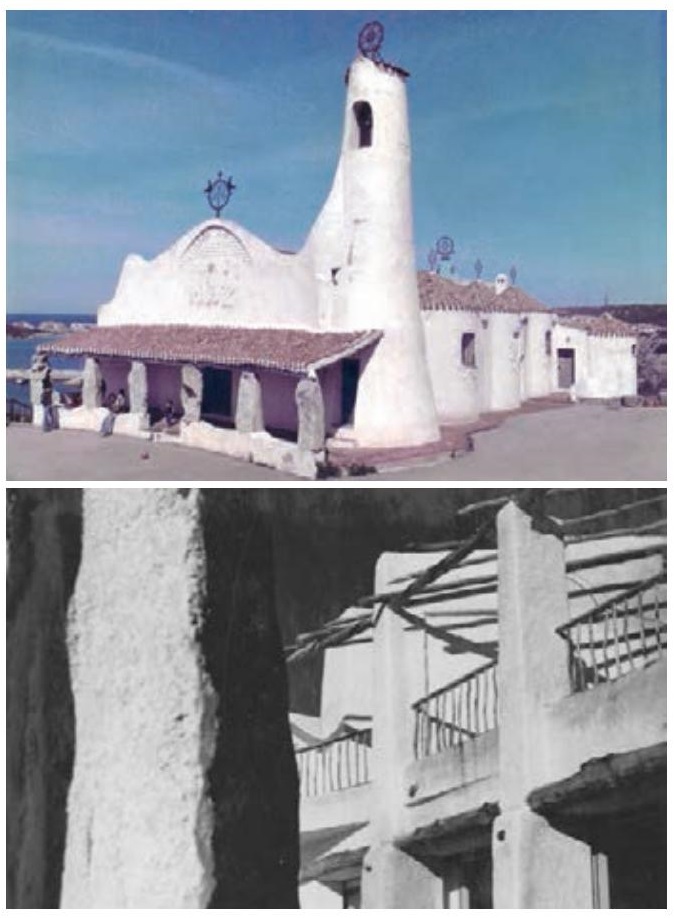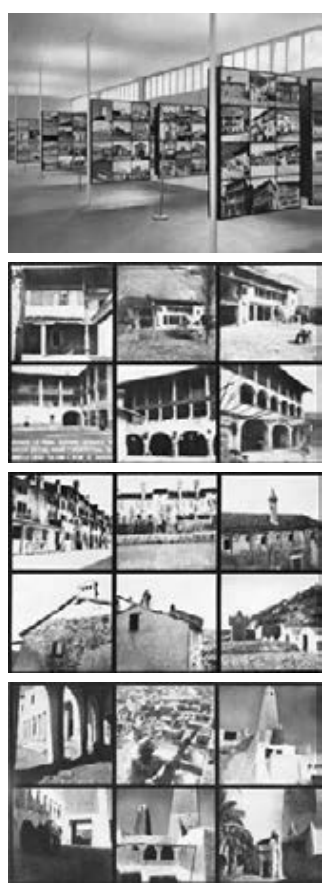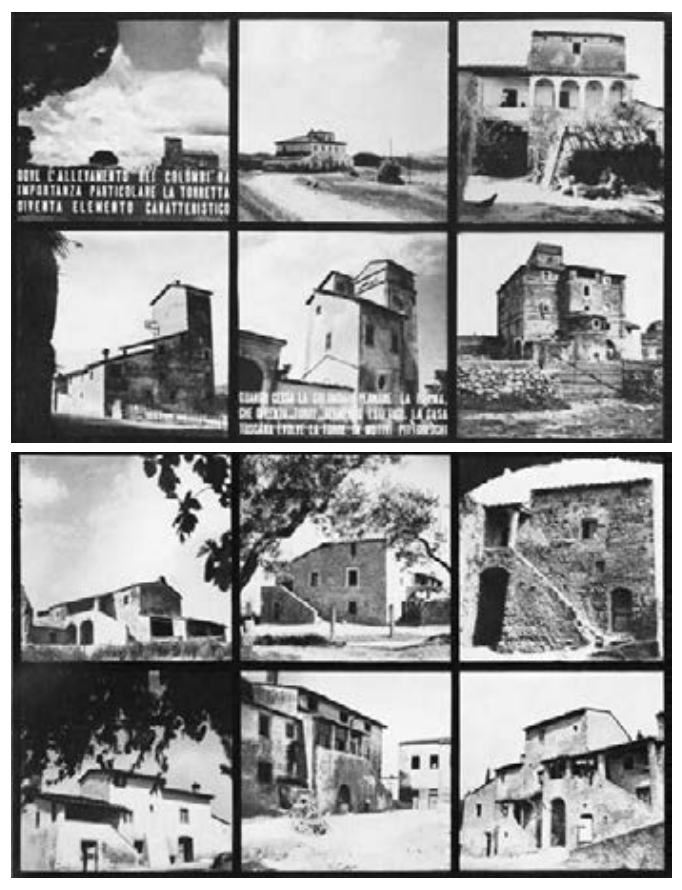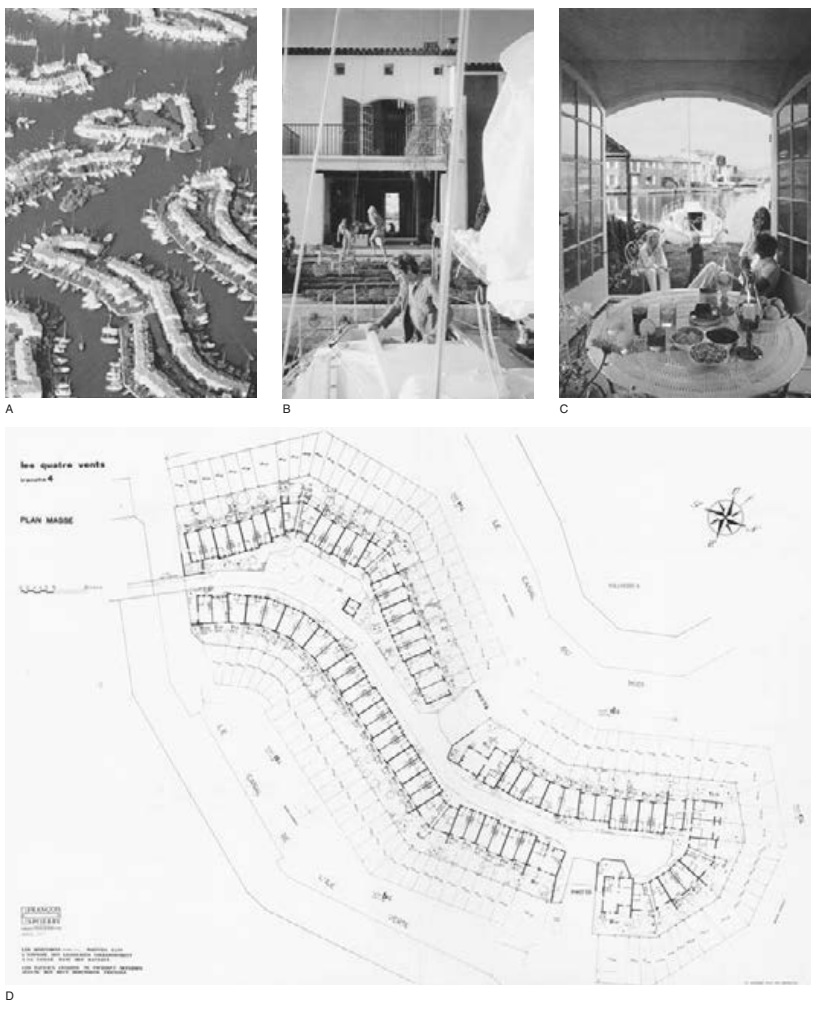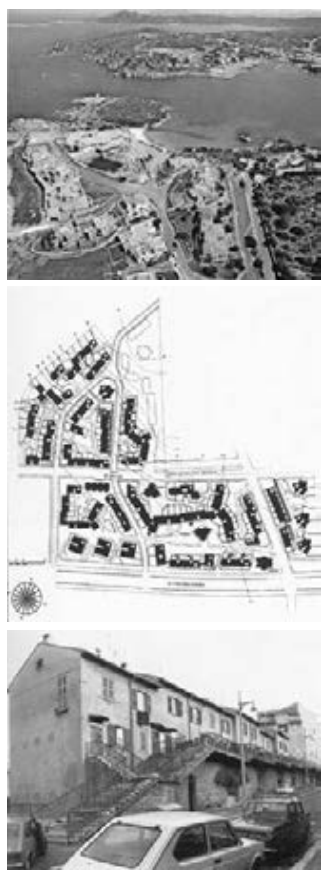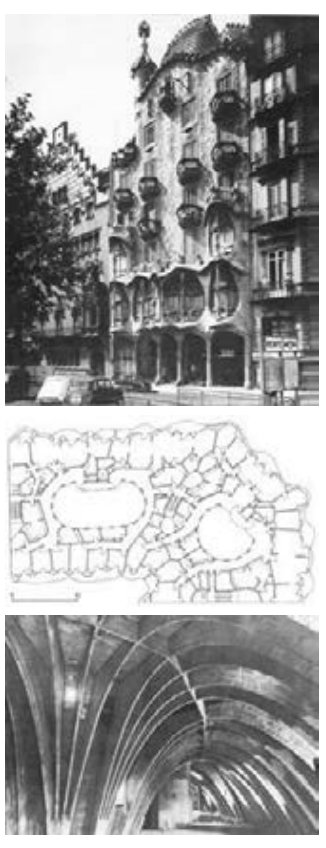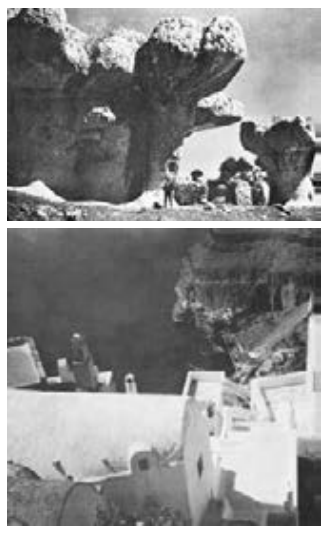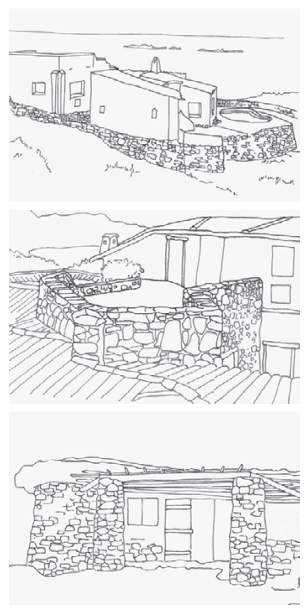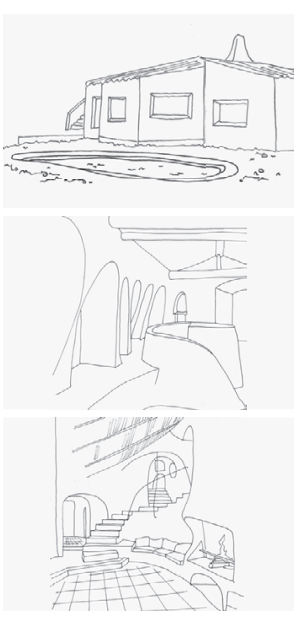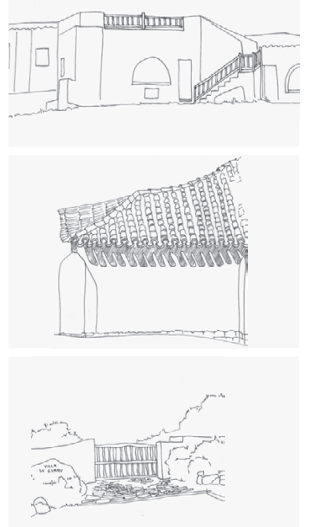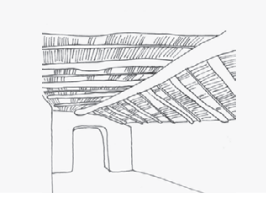CAPITOLO II
Prototipi architettonici
di Nele Dechmann
[Cliccare sui titoli]
1. Introduzione
2. Parametri di progettazione fondamentali
2.1. Riferimenti architettonici generali
2.2. Riferimenti alla tradizione edilizia sarda
2.3. Regole edilizie del Consorzio Costa Smeralda
3. Luigi Vietti
3.1. Villa Tamarisca
3.2. HOTEL PITRIZZA
4. Jacques Couëlle
4.1. Casa Renaredda
4.2. HOTEL CALA DI VOLPE
5. Savin Couëlle
5.1. Casa Wood
5.2. Casa In Sanatorio
6. Michele Busiri-Vici
6.1. Casa Studio
6.2. Sa Conca
6.3. Villa Bettina
6.4. HOTEL ROMAZZINO
7. Adattamento paesaggistico
7.1. Radicamento nel territorio
7.2. L’idea del paesaggio permea l’architettura
8. Stile Costa Smeralda – Inserimento nelle tendenze contemporanee
9. Conclusioni
10. Atlante degli elementi costruttivi
10.1. Insediamento e volumetria
10.2. Elementi costruttivi
10.3. Dettagli
CAPITOLO II
Prototipi architettonici
1. Introduzione
Il mito della Costa Smeralda è tanto celebrato quanto criticato e viene spesso raccontato in termini simili. Un principe musulmano, insieme a un gruppo di amici, trasforma una costa incontaminata della Sardegna in un paradiso nuovo. Qui, accanto a baie scintillanti, sorgono hotel e ville caratterizzati da un’architettura fiabesca, frequentati da personaggi illustri. A seconda del punto di vista, gli architetti avrebbero o tratto nuova linfa dagli elementi più belli della tradizione sarda o, al contrario, introdotto elementi mediterranei arbitrari, percepiti come corpi estranei che alterano il paesaggio.
Per la seguente descrizione architettonica si assume la tesi che gli edifici rappresentino una manifestazione dei desideri e delle visioni di quella società internazionale descritta nel Capitolo 1 attraverso un approccio preliminare. Le componenti identificate in quel contesto costituiscono il filo conduttore ideale su cui sono stati progettati gli edifici.
Per consentire un’analisi strutturata dell’architettura concreta, viene inizialmente fornito un elenco dei parametri progettuali determinanti. Tra questi rientrano riferimenti architettonici generali, ma anche gli elementi derivati dalla tradizione edilizia sarda. Questi ultimi sono stati individuati attraverso un’analisi approfondita dei documenti conservati nell’Archivio Enzo Satta. La presentazione dei parametri progettuali determinanti funge da base tecnica per l’approfondimento successivo sulla specifica architettura della Costa Smeralda.
La parte principale del capitolo consiste nella documentazione dei primi edifici della Costa Smeralda. Questi vengono descritti attraverso planimetrie, sezioni e rappresentazioni, analizzandoli in relazione all’idea guida sviluppata. A tal fine si utilizzano principalmente fonti primarie, ossia fotografie storiche e piante. La selezione esemplare degli edifici mira a favorire un approfondimento su questo stile architettonico. Finora non esiste una descrizione così completa. L’architettura della Costa Smeralda è stata finora descritta solo tramite immagini o rappresentata attraverso planimetrie isolate e riprodotte in piccolo, senza alcuna contestualizzazione. Le descrizioni attualmente disponibili offrono informazioni insufficienti su questa particolare configurazione architettonica. Gli esempi selezionati per questo studio intendono rendere possibile un’analisi più dettagliata delle caratteristiche della Costa Smeralda. A tal fine, vengono presentati i protagonisti dell’architettura e alcune delle loro opere nella Costa Smeralda. Il focus principale è su Luigi Vietti, ma si analizzano anche le opere di Jacques Couëlle, di suo figlio Savin e di Michele Busiri-Vici.
L’integrazione nell’ambiente naturale, osservata nell’analisi dell’architettura, viene infine descritta in una sezione dedicata e inserita nel contesto della pianificazione complessiva. In conclusione, il progetto architettonico viene collocato nel suo contesto storico e riassunto in un atlante degli elementi costruttivi.
Delimitazione temporale e selezione degli architetti
I tre hotel più famosi dell’epoca della fondazione della Costa Smeralda, progettati dai fondatori del comitato di architettura:
A. Hotel Pitrizza di Luigi Vietti, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Hotel Cala di Volpe di Jacques Couëlle, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. Hotel Romazzino di Michele Busiri-Vici, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
2.1. Riferimenti architettonici generali dei fondatori
Un importante punto di riferimento per questa ricerca è costituito dai possibili richiami che consentono di collocare e catalogare l’architettura specifica della Costa Smeralda. Una delle ipotesi è che il Consorzio abbia guidato gli architetti, comunicando loro il linguaggio architettonico desiderato attraverso immagini. Tuttavia, nell’archivio di Enzo Satta è stata trovata una sola chiara referenza: due immagini del Castello di Fénis e un’immagine del Castello di Graines, entrambi situati in Valle d’Aosta. Le fotografie di Fénis furono riprodotte a Londra dall’«Italian State Tourist Office» come immagini autorizzate. Si presume che queste siano state introdotte da Patrick Guinness o dall’Aga Khan per il progetto del Cala di Volpe. Considerando l’importanza cruciale dell’Aga Khan in tutte le decisioni, è probabile che questa referenza archiviata provenga da lui.(5. Una testimone oculare, Lorenza Dalmaso, si esprime con scetticismo. A suo parere, i modelli di riferimento di Couëlle vanno ricercati nei suoi stessi progetti. Enzo Satta considerava plausibile questa ipotesi. Tuttavia, le fotografie si trovavano nell’archivio delle immagini di Cala di Volpe. L’ipotesi avanzata in questa ricerca è quindi che l’Aga Khan avesse in mente quel modello di castello, e Couëlle ha integrato l’immagine di quel tipo di fortificazione in Cala di Volpe).
Un altro riferimento menzionato da Luigi Vietti per il suo progetto del centro di Porto Cervo è il porto di Marina Grande a Capri. Parallelamente alla Costa Smeralda, venne realizzato Port Grimaud da François Spoerry, che attirò l’attenzione dell’Aga Khan, il quale negli anni Ottanta incaricò Spoerry di costruire una fila di edifici a Porto Cervo.
Una sintesi finale dei riferimenti, che potrebbe fornire una cornice unitaria all’architettura, non è possibile. Il progetto è troppo vasto, i partecipanti troppo numerosi, i modelli possibili innumerevoli – e spesso non più documentabili, come dimostra la scarsità di riferimenti diretti. Inoltre, a causa della loro diversità, i riferimenti non offrono un aiuto coerente per analizzare lo stile architettonico, come emerge già dalle notevoli differenze tra Fénis e Capri.
L’intento dell’Aga Khan e del Consorzio era chiaramente quello di sviluppare un nuovo stile per l’insediamento, composto da elementi tradizionali dell’architettura sarda, ma soprattutto ispirato al paesaggio sardo. Sul processo di elaborazione di questo stile architettonico per la Costa Smeralda, l’Aga Khan dichiarò:
«Abbiamo condotto ricerche per sei mesi sulla storia della Sardegna per capire quali siano le caratteristiche delle strutture e dell’architettura sarda. Vogliamo realizzare uno sviluppo che integri tutti questi splendidi elementi della Sardegna e darli alla Costa Smeralda».
Sembra che il Consorzio abbia fornito solo poche linee guida di riferimento al di fuori dell’architettura vernacolare sarda. Piuttosto, furono selezionati architetti che avevano già realizzato edifici vicini agli ideali del Consorzio. Con loro, il Consorzio sembrava voler cogliere l’opportunità di sviluppare uno stile architettonico proprio. Questo capitolo discute se tale obiettivo sia stato raggiunto o meno. In anticipo sulla conclusione, si può affermare che, contrariamente a quanto sostenuto nella letteratura più antica sulla Costa Smeralda (come nei lavori di Price o Cappai), questo stile architettonico non si limita a un’assemblaggio di dettagli, ma presenta coerenze uniformi nella costruzione, nei materiali, nei volumi e nelle planimetrie.
Per raggiungere questo obiettivo, gli architetti dovettero elaborare un catalogo comune di riferimenti. Si può preliminarmente affermare che esistono due parametri progettuali determinanti e applicabili all’intera Costa Smeralda: da un lato, gli elementi derivati dalla tradizione edilizia sarda; dall’altro, le regole edilizie del Consorzio Costa Smeralda. Entrambi saranno descritti nel seguito.
2.2. Richiami alla tradizione edilizia della Sardegna
In precedenza è stato citato l’Aga Khan, che sottolineava l’impegno della Costa Smeralda nell’integrare elementi sardi. Sia lui che gli architetti hanno più volte ribadito questa intenzione. Le pubblicazioni precedenti sull’architettura della Costa Smeralda tendono a ignorare un elenco di tali elementi, sostenendo che si tratti più di un’ispirazione consumistica, senza un reale approfondimento della tradizione edilizia sarda. Valutare questa affermazione è complesso; in ogni caso, per fornire una panoramica fondata, qui si propone una descrizione neutrale dei componenti sardi presenti nell’architettura della Costa Smeralda. Di seguito vengono elencati gli elementi che, con molta probabilità, sono stati presi dalla tradizione edilizia sarda.La Costa Smeralda è stata concepita con l’obiettivo dichiarato di integrare elementi della tradizione costruttiva sarda nella sua architettura. L’Aga Khan e il comitato di architetti hanno sottolineato più volte l’importanza di questa connessione con la tradizione locale. Sebbene alcuni critici abbiano liquidato l’integrazione degli elementi tradizionali come superficiale o consumistica, è utile fare un inventario neutrale dei componenti stilistici che sembrano ispirati alla tradizione edilizia sarda.
Muri in granito
L’uso di muri in granito a vista è uno degli elementi più evidenti derivati dalla tradizione costruttiva sarda. In Gallura e in altre parti della Sardegna, questi muri rappresentano un elemento tipico dell’architettura vernacolare. Sono realizzati con pietre di granito irregolari e sommariamente lavorate e vengono tradizionalmente utilizzati per costruire case e stalle di forma rettangolare. Il comitato di architetti ha adottato questo elemento, adattandolo però a geometrie di pianta più complesse.
Colonne in granito
Le massicce colonne rotonde in granito, utilizzate soprattutto da Luigi Vietti e Jacques Couëlle, sembrano ispirate ai misteriosi nuraghi. Sebbene non siano copie dirette di queste strutture preistoriche, ne richiamano la robustezza e la monumentalità.
Tetti in tegole
Il tetto in tegole è un altro importante elemento, che potrebbe derivare anche da altre tradizioni mediterranee. Tuttavia, la precisa esecuzione con tegole semicircolari sporgenti e altre disposte a rovescio, che creano giochi d’ombra ornamentali sulle pareti, trova paralleli in diverse regioni della Sardegna. Questo dettaglio decorativo è spesso eseguito con doppie o triple file di tegole.
Motivi a triangolo
L’ornamento triangolare, spesso visibile sopra i camini, è un motivo ricorrente in tutta la Sardegna. Nella Costa Smeralda, questo elemento è utilizzato quasi ovunque, ad esempio come apertura di ventilazione da Vietti, come decorazione nella chiesa Stella Maris di Busiri-Vici o come elemento stilistico nell’hotel Cala di Volpe di Couëlle.
Loggia a più piani con archi
Questo elemento architettonico si trova in Sardegna, ad esempio, nel Palazzo Ducale di Sassari. Antonio Simon Mossa, che partecipò al progetto nelle fasi iniziali, utilizzò spesso questo motivo nei suoi progetti.
Stipiti delle finestre in granito
Jacques e Savin Couëlle utilizzarono frequentemente massicci stipiti in granito per le finestre, conferendo alle aperture un carattere robusto e artigianale.
Solai con travi in legno
Le travi in legno visibili all’interno sono un elemento che non si limita alla Sardegna. Tuttavia, l’uso di legni locali come il ginepro o il castagno dimostra un’attenzione particolare ai materiali regionali. Mentre Vietti e Busiri-Vici utilizzavano le travi principalmente come elemento decorativo, Couëlle realizzava anche strutture portanti in legno.
S’orriu (intreccio di canne)
La sottostruttura dei soffitti, composta da canne intrecciate posizionate sopra le travi del tetto, è un elemento tipico dell’architettura sarda. Questo elemento è stato utilizzato da Couëlle e Busiri-Vici nelle ville, così come da Vietti nel ristorante e sulle terrazze dell’hotel Cervo.
Interni simili a grotte
Gli spazi interni spesso selvaggi e organici progettati da Jacques e Savin Couëlle ricordano le formazioni naturali e sono comparabili alle semplici abitazioni dei pastori sardi. Anche l’arredamento con cesti intrecciati e altri elementi tradizionali richiama questa fonte d’ispirazione.
Rinforzi murari
I rinforzi murari di epoca medievale, spesso visibili in chiese o grandi case coloniche in Sardegna, sono stati utilizzati come elemento estetico da Vietti, Couëlle e Busiri-Vici. Appaiono anche sotto le aperture ad arco e in altri dettagli stilistici.
Casa dei Ruda
L’edificio a corte di Suelli, nel Campidano, mostra molti elementi che si ritrovano nell’architettura della Costa Smeralda: un basamento in granito di mezza altezza, arcate a tutto sesto, camini scolpiti e il motivo ornamentale con doppio arco sopra l’ingresso. Quest’ultimo elemento, in particolare, potrebbe essere stato una delle principali referenze per il Consorzio, dato che simili dettagli si ritrovano nei progetti di Vietti e Busiri-Vici.
2.3. Regole edilizie del Consorzio Costa Smeralda
Oltre alle leggi edilizie esistenti in Sardegna e in Italia, il Consorzio Costa Smeralda ha istituito propri regolamenti, più severi, per il territorio di sua competenza. Fin dall’inizio, l’architettura ha ricoperto un ruolo centrale. Nella prima dichiarazione d’intenti del 1961, firmata dai proprietari terrieri dell’area costiera, si affermava che sarebbe stato istituito un Comitato Architettonico per controllare l’architettura del territorio.
Il comitato architettonico dispone di ampi poteri decisionali. Ad esempio, può dichiarare inedificabili le aree di elevato valore paesaggistico o quelle in cui nuove costruzioni potrebbero ostruire una vista panoramica particolarmente bella. La vegetazione esistente e le formazioni rocciose di granito devono essere indicate nei progetti.(9. Questo studio si basa sul Regolamento Edilizio, Consorzio Costa Smeralda del 1990. Esistono diversi indizi nel primo report degli SDDA del 1969 che suggeriscono come l’Aga Khan fosse stato spinto ad allentare le restrizioni. Sarebbe interessante esaminare il documento originale, che tuttavia non era disponibile. Almeno fino al 1990, l’Aga Khan deteneva ancora il 49% delle quote della Costa Smeralda, e nel regolamento si fa riferimento alla sua visione).
L’articolo più importante del regolamento, che riguarda i principi fondamentali dell’architettura, è l’Articolo 44, “Estetica Architettonica”:
«Per quanto possibile, dovrebbero essere evitate costruzioni che si discostano troppo dall’architettura tradizionale mediterranea. Il comitato per l’architettura si riserva il diritto di esaminare i progetti in base a questa disposizione, affinché i criteri dell’architettura mediterranea siano rispettati. Si raccomanda che i volumi edilizi siano armonicamente inseriti nella topografia del terreno e che vengano evitate forme lineari e troppo rigide, che non si integrano bene nel paesaggio costiero».
Questa regola di base ha portato alla ripetizione di elementi che il comitato architettonico originale ha definito come “mediterranei”. Tra questi vi sono motivi ad arco per le finestre, pergolati e terrazze sul tetto. Inoltre, la direttiva di evitare forme rigide ha avuto un forte impatto sulla volumetria e, di conseguenza, sulla planimetria degli edifici.
Ulteriori disposizioni per gli edifici includono limitazioni sui materiali utilizzabili.
- Materiali: Le facciate devono essere realizzate in muratura di pietra a vista o intonaco rustico. Le pietre devono essere locali, provenienti dalla Sardegna.
- Colori: È consigliato l’uso di tonalità tenui, in modo che gli edifici si integrino armoniosamente nel paesaggio circostante.
- Tetti: Tutti i tetti devono essere inclinati con un’angolazione di 16°.
Le facciate devono essere realizzate in muratura di pietra a vista o intonaco rustico. Le pietre devono essere locali, provenienti dalla Sardegna. È consigliato evitare colori troppo intensi, per consentire agli edifici di integrarsi armoniosamente nell’ambiente circostante. Inoltre, tutti i tetti devono essere inclinati, con un’angolazione di 16°.
3. Luigi Vietti
Luigi Vietti era sulla sessantina quando fu avviato il progetto della Costa Smeralda. La sua carriera di architetto iniziò con una tesi di laurea in cui integrò elementi vernacolari in un progetto per un complesso alberghiero sul Lago Maggiore. Durante il periodo fascista si avvicinò al razionalismo e negli anni ’40 collaborò con Gio Ponti alla rivista Lo Stile. Nel dopoguerra, i suoi progetti oscillavano tra razionalismo e un linguaggio architettonico rurale.
Vietti era noto nell’élite italiana per le sue ville a Cortina d’Ampezzo, nelle Dolomiti, progettate per clienti prestigiosi come i Benetton e i Barilla. Grazie a queste referenze, fu chiamato a lavorare dal Consorzio Costa Smeralda.
Tra gli architetti coinvolti, Vietti ebbe probabilmente il maggiore impatto sullo sviluppo architettonico della Costa Smeralda. Fu incaricato sin dall’inizio di progettare aree importanti come Romazzino, Porto Cervo (incluso il centro) e la zona di Pitrizza. La sua collaborazione con il Consorzio si dimostrò fluida sin dai primi anni, al contrario di quella di altri colleghi. Nel 1969, i paesaggisti SDDA lodarono il suo piano urbanistico per Porto Cervo, mentre il piano per Romazzino di Busiri-Vici fu oggetto di critiche.(15. Enzo Satta sottolinea l’approccio positivo di Vietti e il suo uso costante di formulazioni ottimistiche).
La combinazione di affidabilità lavorativa e una personalità carismatica rese Vietti una figura sempre più centrale (16), mentre il ruolo di altri architetti come Couëlle e Busiri-Vici diminuì dopo il completamento delle loro prime opere di rilievo.(17)
(16). Vietti divenne anche membro dello Yacht Club Costa Smeralda.
(17). A differenza di Couëlle, Vietti e Busiri-Vici non contraddirono mai l’Aga Khan. Tuttavia, Busiri-Vici era significativamente più anziano rispetto agli altri due e non partecipò attivamente al progetto per lungo tempo. Cfr. Riccardi 2010, pp. 123-125.
3.1 Villa Tamarisca
La Villa Tamarisca si trova nella zona di Piccolo Romazzino, così chiamata per la presenza del rosmarino selvatico tipico della zona. Tamarisca è il nome italiano della tamerice, un arbusto che fiorisce da marzo a settembre. Tutte le ville costruite dal Consorzio in questa zona portano nomi di piante locali, come Rosmarino, Tamarisca, Ginepro e Ginestra, riflettendo il tema del paesaggio come elemento distintivo dell’identità.
Caratteristiche principali
- Posizione: Costruita su un pendio con una vista libera sul mare, la posizione della villa è stata scelta per garantire che la vista non potesse essere bloccata da altre costruzioni, rispettando le leggi edilizie della Costa Smeralda.
- Accesso: L’accesso pedonale all’abitazione è stato concepito per enfatizzare l’esperienza architettonica. In una versione iniziale del progetto del 1965, scartata successivamente, la villa includeva un garage con accesso diretto all’abitazione.
- Design esterno: Gli spazi esterni presentano forme organiche; la piscina, ad esempio, ha una forma a rene, caratteristica tipica delle prime piscine costruite nella Costa Smeralda.
- Volume e tetti: Il volume della villa segue la topografia del terreno, con corpi sfalsati e un tetto composto da terrazze piatte e coperture inclinate in tegole.
Progetti di ampliamento
Il progetto originale includeva già opzioni per futuri ampliamenti, come l’aggiunta di una terza camera o di un piano sopra la terrazza. Questo approccio anticipava le difficoltà legate alle autorizzazioni italiane e permetteva di controllare lo sviluppo dell’edificio.
Composizione volumetrica sulla costa
In pianta e in sezione, il volume piatto e allungato è formato da singoli corpi leggermente sfalsati tra loro. Questo consente all’edificio di seguire la topografia del terreno. La composizione, che combina una terrazza piana centrale con tetti inclinati laterali in tegole, crea un profilo del tetto spezzato che dona alla struttura un aspetto a scala ridotta.
I tetti delle due estremità laterali erano inizialmente previsti, nel 1965, come un tetto a padiglione e un tetto a falda semplice, ma successivamente furono ridisegnati come due tetti a padiglione. Al centro del volume, sopra la camera da letto principale, si trova la terrazza sul tetto.
Accesso
L’ingresso si trova sul lato del pendio; l’auto viene parcheggiata lontano dall’ingresso e la casa è raggiungibile attraverso un’area di giardino anteriore. L’accesso pedonale all’abitazione rappresenta una scelta intenzionale. Nella prima versione del progetto, scartata nel 1965, la villa includeva un garage interno con accesso diretto all’abitazione.
Spazi esterni
Gli spazi esterni sono progettati con un linguaggio formale organico. La piscina, ad esempio, ha una forma a rene, morbida e organica, caratteristica comune a tutte le piscine costruite nei primi anni alla Costa Smeralda. Questo design potrebbe essere stato anche una prescrizione regolamentare dell’epoca, benché non sia confermato dalla documentazione disponibile.
Pianificazione per future espansioni
Le estensioni già previste, come un terzo dormitorio e un livello aggiuntivo sopra la terrazza, mostrano come Vietti abbia anticipato le complessità legate alle autorizzazioni italiane. La pianta e la sezione includevano già queste possibili espansioni per ottenere preventivamente l’approvazione. Da un lato, ciò rispondeva all’imprevedibilità delle autorità italiane; dall’altro, permetteva di mantenere il controllo sullo sviluppo futuro dell’edificio.
Topografia interna
Il programma spaziale consiste in due camere da letto ciascuna con bagno, un soggiorno, una cucina e un’area per il personale domestico con una camera da letto, un bagno e una lavanderia. La disposizione degli ambienti segue una gerarchia basata sulla vista e sulla privacy.
Il soggiorno, posizionato al livello più basso, assume un ruolo centrale e diventa il fulcro della “paesaggistica” interna a terrazze. Insieme alla seconda camera da letto, si affaccia sulla piscina. Il bagno principale, separato dal soggiorno da due bagni, si trova al livello più alto e funge da luogo di ritiro rispetto al cuore pulsante della casa.
Dietro il soggiorno, sul lato del pendio, si trovano la cucina, la lavanderia e la camera da letto del personale. Non esiste un ingresso separato per il personale, e lo stesso vale per la maggior parte delle ville dei membri fondatori; l’atrio d’ingresso è utilizzato da tutti i residenti della casa. Il ruolo della governante o del cuoco oscillava tra dipendente e membro allargato della famiglia, non completamente separato dalla vita familiare né completamente integrato. Il rapporto tra il personale di casa e i residenti della villa è illustrato nel racconto di Podbielski:
«Nell’estate del 1970, una villa a Liscia di Vacca era in costruzione e René passava più volte al giorno per i suoi vari impegni. Una volta sentì uno dei giovani operai cantare mentre murava i mattoni e notò che era il cuoco di mezzogiorno del cantiere. Un giorno iniziarono a parlare e René chiese al ragazzo se volesse venire a lavorare con noi nella villa – come cuoco. Antonello accettò e da allora è sempre stato con noi. Inizialmente cucinavamo insieme in cucina. […] Successivamente divenne così indipendente che quasi mi vietò di entrare in cucina.
Antonello amava René e imparò molto da lui sull’arte. […] Ricevette anche un’introduzione da René alla letteratura – Balzac, Zola, Thomas Mann e i classici italiani. E costruì una grande collezione di musica classica. Ma questa formazione intellettuale ha reso la sua vita anche più complicata. Lo separa dal suo ambiente di origine. Le ragazze del villaggio sono troppo arretrate per lui, e le ragazze della città sono troppo disinvolte per le sue opinioni rigorose».
Il tema dei volumi sfalsati prosegue anche all’interno. Ogni stanza è collocata su un livello diverso, ad eccezione della cucina e del soggiorno, per ragioni pratiche. Questa variazione nei livelli contribuisce a garantire la privacy, mentre le diverse dimensioni e geometrie degli ambienti creano angoli riservati, come le nicchie davanti ai due bagni, che impediscono una visione diretta.
Alle finestre dei bagni è stato aggiunto un letto di piante come ulteriore protezione visiva. La camera principale si trova un metro sopra il soggiorno, mentre i piccoli ambienti sul lato del pendio hanno aperture ridotte. Le stanze rivolte verso il mare, invece, sono più ampie e caratterizzate da grandi aperture, in linea con una logica che richiama l’architettura organica di Frank Lloyd Wright.
Le ville di Vietti alla Costa Smeralda si sviluppano da un nucleo interno e si aprono gradualmente verso l’esterno, come piante, con terrazze e pergolati che rappresentano gli spazi più aperti di questa struttura.
Materiali rustici
Le pareti esterne sono intonacate di bianco, mentre le terrazze e i pavimenti interni sono rivestiti in terracotta, prodotta dalla nuova manifattura Cerasarda. Nel soggiorno, Vietti utilizza piastrelle di terracotta rosse quadrate da 25×25 cm, disposte ortogonalmente rispetto alla facciata, e lo stesso materiale è impiegato in tutti gli ambienti per creare continuità tra i volumi diversificati.
Gli interni delle ville riflettono un approccio coerente ai materiali. I corrimano, sia interni che esterni, sono realizzati con rami non lavorati. Nelle ville dei membri fondatori, ogni dettaglio dei materiali è stato progettato da Vietti, incluse le vasche da bagno, i lavandini e i WC, spesso rivestiti con pannelli di legno dipinti con motivi rustici.
Comfort tecnici in un contesto di semplicità
Anche se non ci sono documenti tecnici specifici per Villa Tamarisca, le ville dell’Aga Khan, di Patrick Guinness e André Ardoin mostrano che le strutture progettate da Vietti seguivano standard elevatissimi. Le finestre erano di alta qualità, e gli impianti tecnici, come tubature, caldaie ed elettricità, erano murati nelle spesse pareti.
Il riscaldamento era garantito da termosifoni sotto le finestre, mentre i camini, presenti in tutte le case, non solo offrivano calore, ma sottolineavano anche il carattere rustico delle abitazioni. Le cucine erano funzionali e razionali, dotate di tutte le attrezzature moderne, ma di dimensioni contenute, poiché principalmente destinate al personale o alle mogli dei proprietari.
I bagni erano spaziosi, con WC, bidet, lavandini e vasche da bagno. Ogni camera aveva il proprio bagno privato. Nel soggiorno si evitava di includere tecnologia visibile, per evocare uno stile di vita semplice e connesso alla natura. Tuttavia, i sistemi di climatizzazione erano incorporati nelle pareti, mentre le aperture per la ventilazione naturale erano un elemento distintivo del design di Vietti.
Le ville non disponevano di ascensori o garage integrati, una scelta che rifletteva un certo stile di vita sportivo e autosufficiente. Il telefono era il principale strumento tecnologico, con linee installate in ogni casa fin dall’inizio del progetto, spesso in posizioni centrali e insolite, come accanto alla toilette.
Struttura portante e modalità costruttive
Sulla costa della Gallura non esisteva alcuna infrastruttura né imprese edili capaci di soddisfare le esigenze dell’architettura. Per questo motivo, il Consorzio affidò i lavori alla ditta Grasseto di Padova, che aprì una filiale a Porto Cervo e coordinò il lavoro degli artigiani sardi.
Le ville progettate da Vietti furono costruite in modo razionale, tenendo conto delle circostanze locali. Le pareti furono realizzate con blocchi di cemento, mentre pilastri in cemento armato nascosti all’interno delle murature garantivano maggiore stabilità nei grandi edifici. Le coperture erano composte da un sistema prefabbricato di mattoni, acciaio e cemento. Sopra la struttura principale veniva applicato uno strato isolante e i tetti in tegole venivano cementati sopra.
L’altezza della copertura finale era maggiore rispetto alla sommità delle pareti, e questo spazio veniva colmato con file di tegole sovrapposte in modo ornamentale, un dettaglio tipico degli edifici della Costa Smeralda. Le estremità delle pareti esterne erano rifinite con una fila di tegole, seguite da tegole sporgenti invertite e ulteriormente appesantite dalle tegole del tetto, creando un caratteristico effetto di ombreggiatura decorativa.
A differenza degli edifici di Jacques Couëlle, eventuali travi a vista negli interni erano puramente decorative, inizialmente realizzate con legno locale di castagno o ginepro. Vietti optò per pareti particolarmente spesse e coperture robuste, scelte dettate da ragioni climatiche. Tipiche delle sue ville sono anche le rinforzature agli angoli, più legate all’espressione volumetrica che a esigenze strutturali.
Varianti nelle ville
La Villa Tamarisca rappresenta un esempio tipico delle ville progettate da Vietti. Sebbene esistano variazioni nel suo repertorio sardo, con ville di dimensioni diverse e finiture di qualità variabile, le caratteristiche architettoniche rimangono costanti.
Un esempio di villa più grande si trova nei pressi di Porto Cervo. Questo edificio, progettato per uno stile di vita più lussuoso, presenta una realizzazione più complessa. Nel soggiorno di dimensioni eccezionali, sotto la struttura del tetto descritto, sono stati aggiunti travi a vista che, pur non avendo una funzione strutturale, intensificano l’atmosfera. Il pavimento è rivestito con un mosaico di piastrelle esagonali allungate, circondate da piastrelle quadrate più scure con rilievi, appositamente progettate da Vietti per Cerasarda.
Nei locali privati, le proporzioni delle piastrelle cambiano leggermente, rendendo il pavimento più scuro, ma il tema decorativo del rivestimento continua in tutti gli ambienti, legandoli attraverso la scelta dei materiali. Come nella Tamarisca, le diverse funzioni sono separate da variazioni di livello.
In questa villa, il telefono è collocato accanto al letto, evidenziando l’importanza della comunicazione anche in un contesto isolato.
Arredi interni
Gli interni di una villa fotografata nel 1966 per scopi pubblicitari illustrano lo stile di vita dei primi abitanti. Un dipinto a olio raffigurante una barca a vela decora una parete, mentre una pelle di leopardo è stesa davanti al camino. Mobili confortevoli, come divani imbottiti, pouf in pelle e poltrone rivestite in stoffa, sono completati da sedie e tavolini in legno o rivestiti in tessuto. Vasi di fiori freschi sono sparsi ovunque, e un’enorme anfora dall’aspetto antico è appoggiata accanto a una finestra.
Un oggetto di grande rilevanza è il telefono, che collega l’idilliaca solitudine della villa al mondo esterno, rappresentando un abitante desideroso di esplorare bellezze naturali e tradizioni locali senza rinunciare al comfort.
Caratteristiche architettoniche principali
La Villa Tamarisca condivide con le altre ville di Vietti la stessa materialità, disposizione degli spazi e qualità costruttiva. Le strutture sono composte da una combinazione di ambienti geometrici morbidi, disposti con corridoi minimali o piccoli spazi di distribuzione. Questa organizzazione si riflette anche nella vista dei tetti, che formano una composizione autonoma fatta di altezze diverse, terrazze, spazi esterni delimitati e pergolati.
Il risultato è una volumetria composta da elementi organici dalle forme morbide, che creano un aspetto amorfo. La priorità progettuale è ottenere la migliore vista possibile, garantendo al contempo privacy e un’esperienza di vita naturale in un contesto rurale.
Le ville dei membri fondatori sono paragonabili alla Tamarisca, con una posizione più spettacolare e un numero maggiore di stanze, ma il principio compositivo rimane lo stesso. Tuttavia, queste ville non avevano piscine, poiché l’ideale per i fondatori era un accesso diretto dal loro alloggio alla spiaggia.
Disegni e rappresentazioni
I primi disegni di Vietti combinavano su un unico foglio la pianta e le quattro viste prospettiche. Le piante erano integrate con misure e indicazioni tecniche, ma Vietti non utilizzava sezioni per la progettazione delle ville. I disegni erano realizzati a mano libera, evitando linee tecniche rigide e includendo elementi naturali, come rocce o vegetazione.
La rappresentazione di un’idilliaca ruralità era enfatizzata da tende drappeggiate alle finestre e vasi di fiori lungo le facciate. Le geometrie morbide degli spazi, le pareti che si ispessivano agli angoli e si inclinavano rispetto alla verticale, contribuivano a un’immagine organica e armoniosa.
Anche le fotografie commissionate dal Consorzio nel 1966 seguivano questa logica, integrando la natura circostante come protagonista. Spesso, piccoli arbusti o formazioni rocciose sarde erano collocati in primo piano, richiamando le immagini delle case di Frank Lloyd Wright pubblicate in Italia negli anni ’50. Oggi, la vegetazione ha ricoperto molte di queste costruzioni, ma inizialmente l’inserimento visivo nella flora locale era una sfida piuttosto che una caratteristica spontanea.
A. La Villa Tamarisca di Luigi Vietti, vista della facciata sud-est con panorama sulla costa, foto probabilmente del 1967. (Archivio Enzo Satta)
B. Il piano della facciata della Villa Tamarisca, disegnato da Luigi Vietti, vista A-B del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. Villa Tamarisca, facciata nord-ovest, foto probabilmente del 1967. (Archivio Enzo Satta)
D. Villa Tamarisca, vista C-D del 1966. (Archivio Enzo Satta)
Un tipico interno di una villa di Vietti, con le finestre divise in tre. In questo caso con piastrelle Cerasarda posate in diagonale e per l’atmosfera del soggiorno sono state posate travi in legno sotto il tetto autoportante, ogni stanza si trova su un livello leggermente diverso. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. L’interno di una villa della Costa Smeralda, l’arredamento è basato sui mobili agricoli. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
B. Piatti in ceramica disegnati da Vietti per Cerasarda. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
C. Un pavimento con piastrelle Cerasarda e tendaggi con motivi tessili rurali della tradizione sarda. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
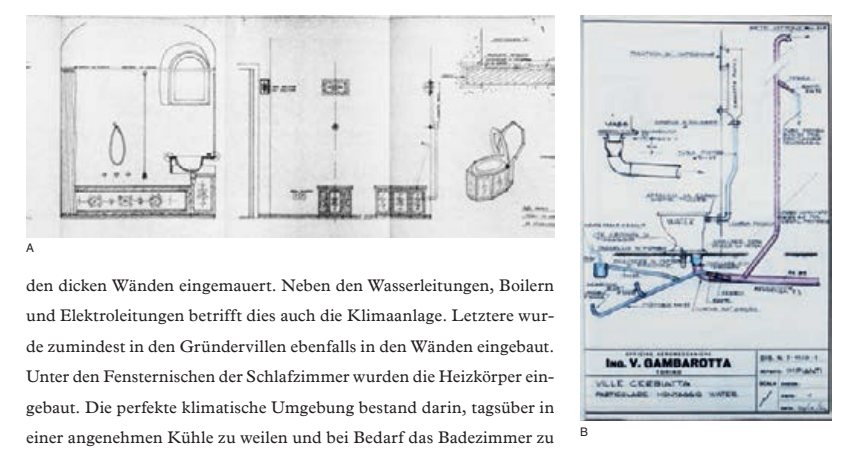
A. Il bagno di una delle prime ville di Vietti. Pianta generale e dettaglio del bagno, con collegamento telefonico accanto al bagno. Pianta del 1965. (Archivio Enzo Satta)
B. Particolare di uno schema tecnico per lo stesso WC. Pianta del 1964. (Archivio Enzo Satta)
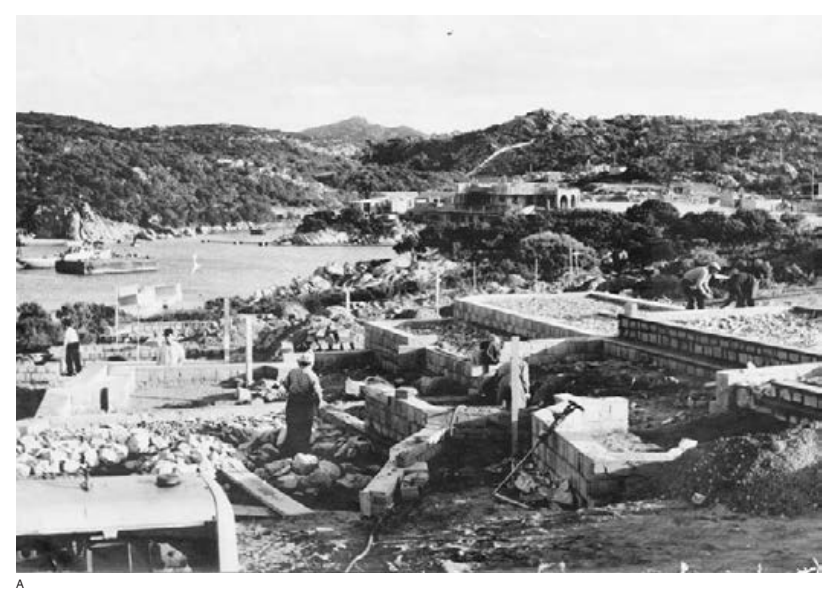
A. Un cantiere di una villa di Vietti. Una volta create le fondamenta, si possono vedere i diversi livelli dei futuri spazi abitativi. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)
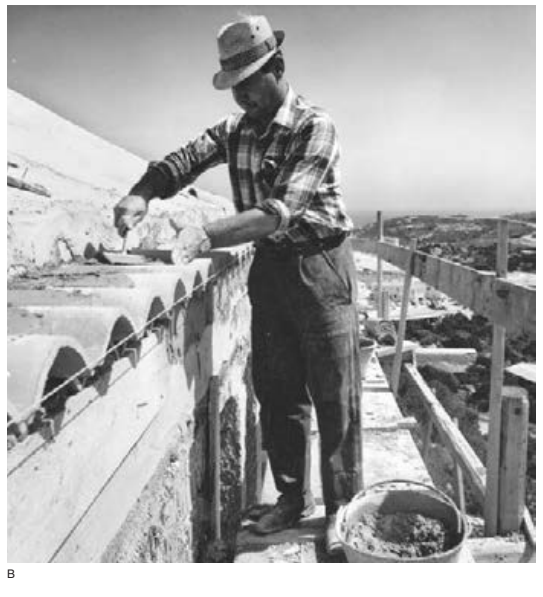
B. La lavorazione della finitura del tetto nello stesso cantiere. Il tetto portante è una combinazione di mattoni, acciaio e cemento ed è ricoperto con mattoni tradizionali. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)

A. Un cantiere di una villa di Vietti. Una volta create le fondamenta, si possono vedere i diversi livelli dei futuri spazi abitativi. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)
B. La lavorazione della finitura del tetto nello stesso cantiere. Il tetto portante è una combinazione di mattoni, acciaio e cemento ed è ricoperto con mattoni tradizionali. Foto del cantiere nel 1963 o 1964. (Archivio Enzo Satta)
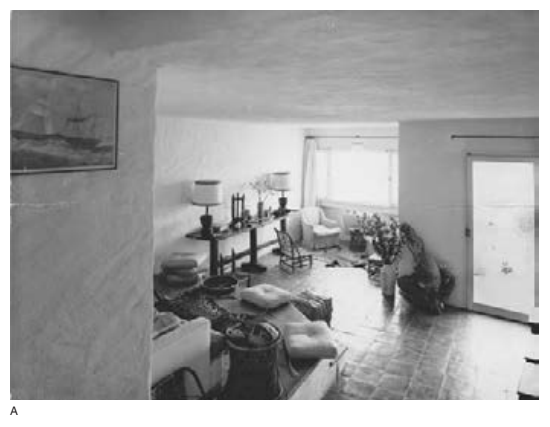
A. Un interno di una tipica villa viettiana con la patta di ventilazione aperta, le finestre tripartite, le piastrelle di Cerasarda posate ortogonalmente e un arredamento che parla del cosmopolitismo dei residenti. Foto del 1966, fotografo Jousué Ito. (Archivio Enzo Satta)
3.2 HOTEL PITRIZZA
L’hotel, come Cala di Volpe, fu costruito nel 1963. Pitrizza è l’antico nome sardo della baia e significa “piccola pietra”. Questa denominazione riflette l’ambientazione dell’hotel, progettato in uno stile architettonico autentico e integrato nella topografia come se fosse un insieme di rocce formatesi per sedimentazione e movimenti geologici.(21)
(21). La documentazione trovata rappresenta il complesso edilizio in epoche diverse. Le fotografie dell’archivio di Enzo Satta mostrano lo stato originale, mentre i progetti riflettono la condizione attuale, trasformata fino a essere irriconoscibile. Il Comune di Arzachena ha messo a disposizione i piani attuali dell’hotel per questa ricerca.
Nel frattempo, l’ingresso coperto è stato integrato negli spazi interni. Le pareti aggiunte sono state imitate in modo quasi ingenuo nello stile originale dei piani, ma senza considerare la struttura spaziale. L’intero complesso alberghiero è stato ampliato in più fasi, e oggi ci sono oltre cinque volte il numero di camere rispetto all’originale. Nei piani sono stati omessi i dettagli probabilmente aggiunti in seguito.
I primi hotel del territorio vennero pianificati nelle baie più belle, assumendo il ruolo di centri identitari per l’area circostante. Ancora oggi questi edifici esistono e continuano a rappresentare punti di riferimento. Mentre l’Hotel Cervo fu concepito come un centro quasi urbano e Cala di Volpe come un porto esclusivo per yacht e golf, l’Hotel Pitrizza si configurò come un rifugio romantico per gli amanti della natura. Gestito da CIGA Hotels, fu descritto come un “paradiso ritrovato”. La principessa Margaret fu una frequentatrice abituale dell’hotel nei primi anni, mentre dall’altro lato della baia sorgeva la solitaria villa di Bettina Graziani, amica del padre dell’Aga Khan. La loro presenza conferiva alla baia un’identità che oscillava tra grandezza, mondanità e rifugio romantico.
Integrazione con rocce e flora
L’Hotel Pitrizza si trova nell’area nord-occidentale della Costa Smeralda. Raggiungibile tramite una strada costruita appositamente, il complesso comprende diversi edifici separati. All’ingresso si trova la reception, seguita da sei case per gli ospiti e dal clubhouse lungo la costa, che ospita un ristorante, un piano bar e diverse sale. La terrazza del clubhouse e la piscina organica si trovano direttamente sul mare. La piscina, alimentata da acqua marina, è integrata nei massi di granito del territorio circostante, con alcuni di questi che emergono dal fondo della vasca. La spiaggia adiacente è riservata agli ospiti. I vari edifici sono collegati da sentieri delimitati da muri a secco, e le strutture si adattano al terreno come formazioni geologiche naturali.
Logica delle “formazioni geologiche”
Gli edifici, tutti a un piano, combinano forme arrotondate e angolari con tetti verdi piatti piantumati di fiori e circondati da bordature simili a muri a secco. I muri sono realizzati con pietre grezze, mentre alcuni elementi strutturali, come gli stipiti delle porte, sono costituiti da massi di granito scolpiti naturalmente da millenni di vento e salsedine. Le porte, realizzate in legno grezzo, ricordano quelle dei granai: alcune sono scorrevoli, altre a battente.
Gli interni delle stanze sono caratterizzati da pareti e soffitti intonacati di bianco, con scaffali a tutta altezza incassati nelle pareti e suddivisi da semplici assi di legno. I pavimenti sono rivestiti con piastrelle in terracotta di 25×25 cm, tipiche di Vietti. L’arredamento include sedie di legno tornito con sedili in paglia intrecciata, tappeti sardi tradizionali e caminetti semplici ma funzionali. Elementi moderni come poltrone imbottite garantiscono comfort, legandosi armoniosamente con l’architettura grazie a dettagli come piastrelle in tinta con i tessuti.
Come nelle ville di Vietti, la disposizione degli spazi offre massima privacy. Le singole unità abitative si combinano in un insieme continuo, sia nella planimetria che nella volumetria esterna. I tetti piatti, percorribili, sono raggiungibili tramite scale esterne in cemento e delimitati da muri a secco, rievocando le tradizioni edilizie sarde. Il design del giardino pensile di Le Corbusier viene reinterpretato in modo unico, integrando elementi vernacolari e un contesto di lusso.
Villa Benedetti – Ispirazione dal Pitrizza
In un linguaggio architettonico simile, Vietti progettò la villa di Carlo De Benedetti, ex dirigente Olivetti, situata in una spettacolare area costiera di Romazzino. Come per il Pitrizza, anche questa villa si integra perfettamente con il paesaggio circostante, utilizzando tetti verdi e muri in granito. L’armonia tra natura, tradizione sarda e una visione artistica si traduce in un’opera coerente e di grande impatto.
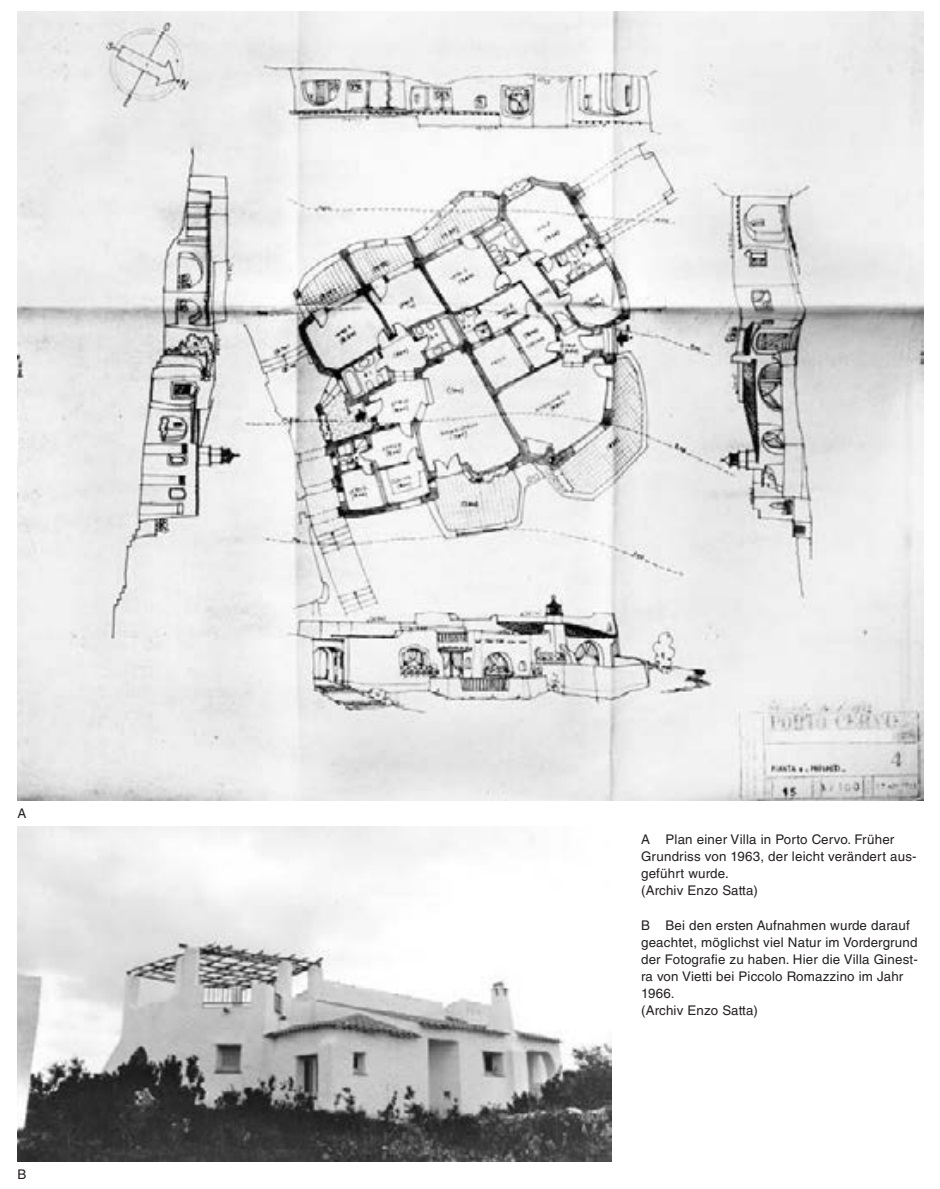
A. Pianta di una villa a Porto Cervo. Pianta iniziale del 1963, leggermente modificata. (Archivio Enzo Satta)
B. Durante i primi scatti si è fatto attenzione ad avere quanta più natura possibile in primo piano nella fotografia. Ecco la Villa Ginestra di Vietti vicino al Piccolo Romazzino nel 1966. (Archivio Enzo Satta)

A. L’ingresso dell’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. L’accesso avviene sotto il tetto verde a sbalzo nella struttura piana dell’edificio. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
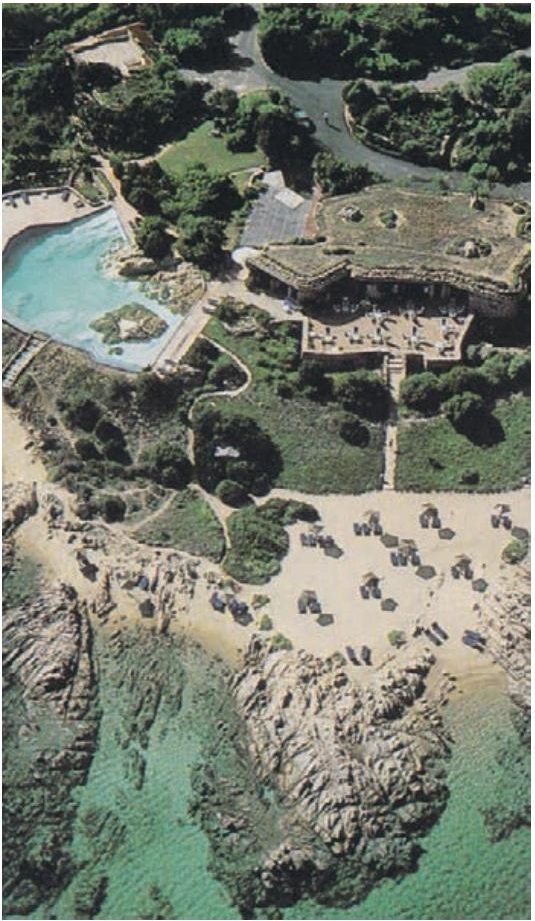
A. All’Hotel Pitrizza. Foto aerea scattata prima del 1987. (Monografia 25° Anniversario)
A. Nell’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. Lo spazio del ristorante è strutturato dalle travi del tetto. Alla fine della stanza c’è la zona più profonda dell’angolo del divano. La terrazza solarium si affaccia sul mare sulla destra. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Un primo piano mostra l’estetica del cibo dell’Hotel Pitrizza. L’idea di un rifugio romantico viene affrontata anche sul tavolo del buffet con modelli di gondole veneziane. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. Nell’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. L’estremità più profonda della stanza forma una zona ribassata con un angolo divano. Fa da raccordo tra le due stanze un camino, il cui soffitto è chiuso da un ramo nodoso. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
D. L’edificio principale dell’Hotel Pitrizza. La terrazza solarium del ristorante si affaccia sul mare e dispone di sedie anch’esse disegnate da Vietti. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
E. Vista della piscina con sottostante area benessere e della spiaggia vista dal ristorante. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
F. La piscina, le cui pareti sono in parte formate da rocce naturali. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
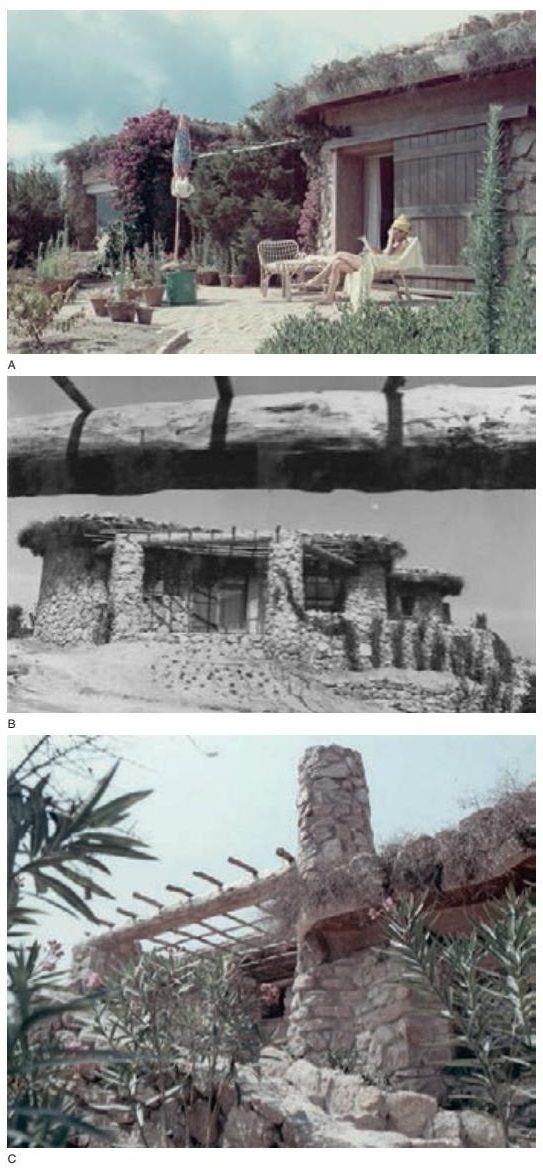
A. Suite 1: La signora prende il sole davanti alla camera con bagno sulla terrazza, che non si vede da terra e che si affaccia direttamente sul mare. La foto risale probabilmente al 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Suite 6: un’immagine esterna della suite dell’hotel. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. Un’altra suite d’albergo dall’esterno. Nella foto la struttura della struttura del tetto, pareti in granito e pergolato. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)

D. Il cortile di una suite, con mobili di Vietti. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
4. Jacques Couëlle
Jacques Couëlle si considerava più un artista che un architetto, descrivendo la sua architettura con un linguaggio artistico e definendosi “scultore di edifici”. Amico di Salvador Dalì e Pablo Picasso, il suo lavoro appare influenzato da Gaudì. I suoi interni hanno un carattere organico, simile a grotte. Questo approccio fu poi sviluppato ulteriormente da suo figlio. Prima del suo incarico in Sardegna, aveva progettato il resort Castellaras le Vieux vicino a Nizza, in montagna. Da lontano il villaggio appare medievale, ma da vicino emergono le forme organiche e scultoree di Couëlle. Questa opera gli valse l’inclusione nel comitato architettonico della Costa Smeralda.
4.1 Casa Renaredda
Questo edificio fu realizzato per uno dei membri fondatori del Consorzio Costa Smeralda.(23. Stato della documentazione: Nell’archivio di Enzo Satta ci sono tutti i piani, ma nessuna fotografia che possa essere chiaramente attribuita alla villa. Dopo un confronto, tre immagini di interni sono state associate a una villa di Couëlle. Dai piani emerge che la sottostruttura dei tetti è una copertura in legno, simile a quella di un normale tetto in tegole. Couëlle progettò esattamente lo stesso tipo di soffitto a Cala di Volpe. Nel 1966, erano state completate pochissime case, e si presume che le immagini degli interni includano anche rappresentazioni di edifici di Couëlle. Inoltre, è stata trovata su Google Earth una fotografia contemporanea dell’edificio ormai ristrutturato, con cui sono stati confrontati i piani).
È anche l’unica villa di Jacques Couëlle di cui si conserva una planimetria documentata.(24. Couëlle costruì solo altre due ville senza il figlio. I piani di approvazione della Villa Renaredda furono presentati da Antonio Simon Mossa; l’architetto francese non poteva presentarli direttamente in Italia. Questo è, tra l’altro, l’unico riferimento a Mossa trovato durante la ricerca negli archivi).
La proprietà si trova a Porto Cervo su un vasto terreno che comprende tre parcelle. Due casette per il portiere segnano l’ingresso stradale, con una strada curvilinea che conduce a un parcheggio coperto e all’ingresso della villa. Dopo un’ampia curva, la strada termina al mare, dove si trovano un piccolo molo privato e una spiaggia, da cui la proprietà prende il nome: Renaredda significa “piccola sabbia” nel dialetto di Sassari.
L’edificio principale si trova al margine del terreno e, con due ali curve di altezze diverse, crea un cortile interno protetto da sguardi esterni, sia dal mare che dalla strada. La figura a ferro di cavallo del piano viene spezzata in diversi punti: l’ala verso il mare è a un solo piano, e la geometria semicircolare è interrotta dalla sala da pranzo sporgente. Piscina e campo da tennis furono aggiunti solo negli anni ’90.
Come nel lavoro di Vietti, la villa segue la topografia e si inserisce nel paesaggio roccioso come un corpo organico. Tuttavia, a differenza di Vietti, gli spazi interni non sempre si riflettono nella forma dell’edificio. La copertura segue un movimento diverso rispetto alla struttura interna, e alcune stanze si staccano dalla figura complessiva, come la sala da pranzo che forma una torretta simile a un bastione. Internamente, questa scelta è enfatizzata da soffitti a falsa volta.
Topografia interna
L’ingresso principale si trova sotto un grande arco che attraversa l’ala a due piani. A nord, una porta conduce a una zona separata con una galleria che collega una stanza per il personale, un’ampia sala giochi e una cantina. A sud, un’altra porta introduce a un ingresso che porta alla zona abitativa principale.
Gli spazi abitativi – cucina, sala da pranzo e ufficio – sono collegati orizzontalmente da una galleria aperta, mentre verticalmente una scala a chiocciola avvolge un camino e conduce alla zona notte situata sopra l’ala nord. Qui, una galleria simile a quella inferiore, delimitata da colonne spesse, dà accesso a due camere per bambini e una per ospiti, tutte con bagno privato. Sopra la cucina e la sala da pranzo si trova la camera padronale, con bagno e una grande cabina armadio.
Gli ambienti interni sono distribuiti su diversi livelli: l’ingresso è sopraelevato, la cucina e il soggiorno si trovano due gradini più in basso, mentre l’ufficio si trova due gradini più in alto rispetto al resto. Questa configurazione crea una “topografia interna” che rispecchia quella esterna.
Il clima perfetto in un ambiente rurale
Nonostante l’estetica evocativa di un mondo quasi medievale, la villa è dotata di tecnologie moderne come impianti sanitari, elettrici e di climatizzazione. Un ampio locale tecnico nel seminterrato ospita i sistemi di ventilazione, garantendo un clima ottimale all’interno.
Struttura e materiali costruttivi
I muri spessi sono portanti e realizzati in blocchi di cemento, simili al lavoro di Vietti. In alcune stanze, il soffitto è intonacato, mentre in altre la struttura del tetto è lasciata a vista e rivestita con sottili listelli di legno. Alcuni ambienti, come la sala da pranzo, presentano false volte per amplificare l’effetto scenografico.
Anche i dettagli mostrano una notevole varietà nei materiali. Le piastrelle in ceramica hanno dimensioni diverse e sono colorate in alcuni punti, disposte in un motivo diagonale nel caminetto o utilizzate per rivestire nicchie. L’attenzione alla creazione di atmosfere specifiche rende ogni ambiente unico.
A. Presumibilmente il soggiorno di Casa Renaredda. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Per dare un’idea della grafia di Jacques Couëlle, uno scatto dell’interno di uno dei suoi progetti sulla Costa Smeralda. O da Casa Renaredda o da una villa realizzata in collaborazione con il figlio Savin Couëlle. La foto è del 1966. (Archivio Enzo Satta)
A e B Casa Renaredda, piani attuativi con note di Couëlle. Piano terra e primo piano, 1965. (Archivio Enzo Satta)
C. Piano esecutivo di Casa Renaredda con note di Couëlle. Tagli, 1965. (Archivio Enzo Satta)
D. Scatto dell’interno di una delle prime ville di Couëlle in Costa Smeralda. Potrebbe essere Villa Renaredda o un’altra villa realizzata da Couëlle. La foto è del 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. Casa Renaredda. Piano esecutivo firmato da Antonio Simon Mossa. Facciate, 1965. (Archivio Enzo Satta)
B. Scatto dell’interno di una delle prime ville di Couëlle in Costa Smeralda. Probabilmente si tratta di Villa Renaredda o almeno di un altro interno progettato da Couëlle. Le foto sono del 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. Casa Renaredda. Progetto esecutivo con ventilazione e riscaldamento, 1965. (Archivio Enzo Satta)
4.2. HOTEL CALA DI VOLPE
L’Hotel Cala di Volpe, forse l’edificio più famoso della Costa Smeralda, si trova a sud del campo da golf Pevero, in una grande baia precedentemente disabitata. L’hotel è situato tra il mare e la valle retrostante, che ospita il campo del Pevero Golf Club. Inaugurato nel 1963, è stato uno dei primi edifici completati.(25. La documentazione disponibile consente una buona ricostruzione della disposizione iniziale. Nell’archivio di Enzo Satta ci sono innumerevoli fotografie, ma nessun piano. Il Comune di Arzachena ha gentilmente messo a disposizione i piani attuali. Tuttavia, questi differiscono in parte in modo significativo dalla costruzione originaria. Sulla base di foto e riprese aeree, è possibile definire bene i volumi esterni originali, mentre gli interni sono solo parzialmente ricostruibili. Esistono numerose pubblicazioni su Cala di Volpe. Per citarne una tipica, si menziona Meet you at Cala di Volpe di Andreas Augustin. Tuttavia, queste pubblicazioni offrono poche informazioni architettoniche, includendo piuttosto testi pubblicitari e immagini di ospiti illustri. Per questa descrizione non sono rilevanti).
Podbielski scrive a proposito dell’inaugurazione: «La terrazza del bar è un luogo magico di sera, quando ci si siede lì e si osserva il mare. Ci fu una grande festa per celebrare questa nostra prima creazione in Sardegna. La nostra emozione era pari alla nostra felicità nel vedere che il sogno si era davvero realizzato».
Nei primi tempi, l’Aga Khan soggiornava personalmente nell’hotel e invitava i suoi ospiti a fare altrettanto. Simone Gerlat visitò la sua stanza nel 1964 e rimase colpita dalla sua semplicità. Una porta fatta di tavole di legno grezzamente assemblate conduceva a una stanza con pareti imbiancate a calce e intonacate in modo approssimativo. La stanza era arredata con mobili rustici scuri, un letto sardo e alle pareti erano appesi i tipici tappeti sardi con motivi naïf, tessuti con stoffe grezze.
L’unico elemento moderno erano, come in tutte le ville, l’aria condizionata e il telefono.
L’arredamento e l’atmosfera rispecchiavano quelle delle ville progettate da Vietti e confermavano una comune visione progettuale, anche negli arredi. Grazie alla presenza dell’Aga Khan, il Cala di Volpe fu sin dall’inizio frequentato da ospiti illustri provenienti da tutta Europa. Nel film di James Bond La spia che mi amava del 1977, l’agente segreto britannico soggiorna al Cala di Volpe, in una sala progettata come piano bar.
Questo film consacrò l’hotel come un’icona internazionale del jet set estivo. L’edificio divenne una vera e propria star della Costa Smeralda. Il porto nascosto era un luogo sofisticato. L’hotel viene descritto come un’opera d’arte, una scultura. Gli archi dalle forme libere e fiabesche, combinati con una struttura che ricorda un castello medievale, crearono un edificio facile da comprendere, che catturava lo spirito del tempo. Il nome “Cala di Volpe” richiama il legame tra le costruzioni semplici in stile naturale e la nobiltà che cacciava volpi. Fu solo grazie alla fama di questo hotel che Couëlle ottenne anche la notorietà internazionale.
Inserimento nel paesaggio costiero
L’hotel si trova in una piccola baia, direttamente sul mare, caratterizzato da numerose penisole e insenature. La struttura stessa, con un lungo pontile in legno che si protende nel mare, evoca, oltre al riferimento al castello, l’immagine di un villaggio di pescatori assemblato. È situato su una figura morenica direttamente sul mare e ha un aspetto medievale. La torre più alta ricorda i torri residenziali rurali della Toscana. Dal suo ingresso si diramano tre ali disposte a forma di mulino a vento.
Le due ali verso il mare ospitano le camere dell’hotel, con pareti che suddividono le ali in sezioni nel piano di base. Nell’ala posteriore si trovano boutique. Al centro di questa, una caffetteria e un piano bar, sopra i quali, nella torre residenziale, sono situate altre camere d’hotel. In queste, inizialmente, soggiornava l’Aga Khan. A ovest, sull’altro lato della baia, si trovano una clubhouse e la piscina.
Il grande complesso edilizio è formato, in pianta e in sezione, da volumi di dimensioni diverse: spazi profondi e strati stretti si susseguono uno accanto all’altro. Seguendo questa configurazione di base, come già avviene con Vietti, la struttura del tetto è una composizione di coperture in tegole e terrazze di diversa altezza e forma. Tetti a padiglione, figure stellate e terrazze a scaglie si trovano fianco a fianco. Questa figura sfaccettata è unificata dalla materialità delle tegole e delle facciate esterne intonacate, oltre che dall’espressione unica derivante dall’uso di finestre di ispirazione rurale e medievale. Inoltre, le pareti e i tetti non sono mai realizzati in modo ortogonale, ma sempre leggermente inclinati, creando una figura complessiva dalle forme morbide.
L’uso di elementi in legno per i tetti delle logge o per il pontile che si protende nel mare contribuisce a creare l’impressione di un villaggio di pescatori. Questo rappresenta un’ulteriore somiglianza con Porto Cervo di Vietti, che si ispira a Capri. Vietti utilizza a Porto Cervo gli stessi elementi di materializzazione che Couëlle impiega a Cala di Volpe (vedi anche Capitolo 3.1.6 su Porto Cervo).
Più all’interno si trova l’edificio destinato al personale. La sua facciata è composta da una loggia a tre piani, con archi al piano terra e al secondo piano, mentre il livello intermedio presenta aperture quadrate. Al centro di ogni campo sottostante, simmetricamente, spuntano doccioni dalla facciata intonacata. Le fotografie mostrano una composizione della facciata che non può essere collocata in nessuna epoca. Insieme alle piccole automobili parcheggiate all’epoca, la composizione ricorda scene di un film neorealista.
Nel 1971 fu aggiunta l’ala occidentale, che raddoppiò il numero di camere dell’hotel, ma questa descrizione non ne tiene conto.
La topografia interna degli spazi
I volumi, esteriormente piuttosto chiusi, offrono all’interno una varietà di spazi diversamente modellati, caratterizzati da un’architettura scultorea con volte a soffitto, travi a vista e gallerie ad arco. Couëlle ha ampliato il suo repertorio rispetto all’architettura di Vietti introducendo un linguaggio formale orientale, con archi simili a quelli che si trovano, ad esempio, in Algeria. Tuttavia, elementi simili si ritrovano anche nel Porto Cervo di Vietti.
Le camere negli edifici frontali sono relativamente semplici, ma ognuna dispone di una veranda privata con vista sul mare. Le stanze dei due corpi principali dell’hotel sono leggermente coniche in pianta; la stessa conformazione si riflette nella sezione, con un tetto che conferisce a ogni spazio un’altezza e un’identità formale proprie. Alcune camere sono su due livelli e creano un microcosmo interno dinamico, una concezione che il figlio di Couëlle svilupperà ulteriormente in futuro.
La pianta poligonale del piano bar ricorda le geometrie spaziali di Frank Lloyd Wright. Sopra la sala, una struttura in travi sorregge il tetto in tegole; per i timpani tra le travi, Couëlle ha utilizzato parti di antiche “cassapanche antiche”. Queste casse di legno intagliato, riempite di lenzuola, erano il regalo più importante delle tradizionali nozze sarde. Couëlle ha integrato le pareti delle singole casse nel piano bar. Questo dimostra due aspetti del rapporto della Costa Smeralda con la Sardegna: da un lato, un interesse e una passione per l’artigianato tradizionale; dall’altro, un consumo di elementi sardi, siano essi culturali o naturali. Gli effetti di questo aspetto consumistico sono approfonditi nel Capitolo 4.
Un mondo materico rustico e fiabesco
Couëlle utilizza elementi fortemente evocativi, quasi in modo disorientante. In alcuni spazi, ad esempio, crea false volte a soffitto, mentre in altre stanze mette in scena autentiche strutture in legno con spesse travi tradizionali sarde. Il risultato è un universo spaziale dalla densa atmosfera, che attinge sia alle tradizioni costruttive sarde sia agli elementi mediterranei. Tutto questo viene sintetizzato in un insieme peculiare grazie alla mano scultorea di Couëlle, che ricorda quella di Gaudí.
Per le facciate, Couëlle ha applicato una tecnica pittorica che è diventata distintiva sia per la Costa Smeralda sia per i processi di urbanizzazione in Sardegna:
- Le porte e le travi portanti sono in legno di alta qualità.
- Alcuni pavimenti sono rivestiti con piastrelle Cerasarda, altri con sezioni di ginepro incastonate nel gesso.
- Come nelle forme e nella pianta, anche nel linguaggio dei materiali si trovano molti elementi utilizzati anche da Vietti: colonne in granito rotonde che sostengono tetti in legno, intonaci dipinti in tonalità terrose, travi a vista (che in Couëlle a volte sono anche strutturali, a differenza di Vietti), finestre semicircolari alternate a strette feritoie, arcate a tutto sesto e pavimenti in cotto rosso, per citarne alcuni.
A. Cala di Volpe, veduta della “torre residenziale” e dei moli topografici verso il mare. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Vista dall’alto della pianta a forma di mulino a vento. Foto probabilmente del 1964.
(https://www.pinterest.com/cervodormiglion/costa-smeralda-anni-60/ [7 ottobre 2015])
C. La pianta del piano terra dell’edificio originario. Dall’ingresso si estendono tre ali a forma di mulino a vento. A ovest, dall’altra parte della baia, si trovano il piano bar e la piscina. (Comune di Arzachena, a cura di ND)
Cala di Volpe poco dopo il completamento. Vista a volo d’uccello dalla terraferma al mare. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
Cala di Volpe poco dopo il completamento. Vista a volo d’uccello dalla terraferma al mare. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
A. Vista dal piano bar alle boutique dello shopping. Sul molo c’era una rete da pesca sarda “dimenticata”. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Cala di Volpe, vista a sinistra delle boutique con formazioni granitiche murate, a destra del piano bar, al centro la “torre residenziale”. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. Veduta della “Torre” dall’ala con le boutique. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
D. Inquadratura esterna dell’hotel, guardando l’ala con le boutique. L’uso di elementi in legno evoca l’impressione di un villaggio di pescatori. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
E. Vista dalle boutique all’ala est con le camere dell’hotel. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
F. L’edificio del personale di Cala di Volpe. Formalmente ci sono grandi somiglianze con la parte della boutique. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. La veranda delle camere dell’albergo nell’ala est. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. La veranda di una camera d’albergo nell’ala est. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. All’interno viene creata una topografia propria. Sezione dell’ala est dell’hotel La pianta del 2006 mostra l’ala costruita nel 1963. (Comune di Arzachena, a cura di ND)
D. Una delle suite dell’hotel a due piani a Cala di Volpe. Foto degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
E. Il piano bar del Cala di Volpe. Le travi in legno sono “cassapanche antiche” dei tradizionali matrimoni sardi. Foto degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
A. Interno della parte boutique dell’edificio di Cala di Volpe. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. L’interno della club house accanto alla piscina. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. Lo stesso interno della foto A. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
D. Le sedute del piano bar, le sedie con schienale triangolare, sono state disegnate da Couëlle. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
E. Un interno di Cala di Volpe, forse proveniente dalle boutique facenti parte dell’edificio, il pavimento è in fibra di ginepro. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
5. Savin Couëlle
Savin Couëlle, figlio di Jacques Couëlle, subentrò gradualmente nei progetti del padre, tanto che spesso i due architetti vengono confusi. Le sue ville rappresentano un’evoluzione dello stile di Jacques, portandolo all’estremo. A differenza del padre, all’epoca più noto, la Costa Smeralda offrì a Savin l’opportunità di affermarsi come architetto di spicco. Trasferitosi dalla Francia a Porto Cervo, Savin si ritagliò il ruolo di architetto esclusivo della Costa Smeralda.
Le sue ville si allontanarono dallo stile scultoreo di Jacques, approfondendo gli elementi cavernosi e le composizioni artistiche libere fino a creare pareti e spazi quasi simili a collage. Questo stile architettonico divenne, fino agli anni ’90, un marchio distintivo del particolare stile di vita della Costa Smeralda. Ancora oggi, le sue ville appaiono in riviste di lifestyle e libri fotografici sulla Costa Smeralda.
Ken Adam, dopo una visita in Sardegna, si ispirò ai suoi edifici per ideare il mondo sottomarino del personaggio Stromberg nel film di James Bond La spia che mi amava. Anche gli interni del protagonista Luke Skywalker in Star Wars IV ricordano l’architettura di Savin Couëlle. Probabilmente, grazie alla sua presenza nei media, Savin ebbe almeno tanto impatto sull’aspetto della Costa Smeralda quanto il padre, diventando un modello per imitazioni dello stile architettonico in Sardegna. Per questa ragione, la sua architettura viene brevemente analizzata in questo studio, concentrandosi sui primi due edifici progettati insieme al padre.
5.1. Casa Wood
Già nel 1964, mentre Jacques Couëlle lavorava alla Villa Renaredda, Savin Couëlle prese in carico il suo primo progetto nella Costa Smeralda: Casa Wood. Situata direttamente sulla costa rocciosa vicino a Porto Cervo, l’edificio fu inizialmente progettato con una pianta rettangolare ma realizzato, come per Jacques, con angoli morbidi sia in pianta sia in sezione. Gli interni sviluppano una topografia spaziale graduale attorno a un camino dalla forma espressiva. Dal punto di vista formale e planimetrico, l’opera è vicina ai progetti del padre. Le scale sinuose introdotte in questa villa divennero il marchio di fabbrica di Savin.
Sia per la costruzione della casa sia per la delimitazione della proprietà venne utilizzato il granito visibile, un elemento tradizionale dell’architettura sarda.
A. Casa Wood. Vista aerea. I muretti a secco dei pastori sono stati utilizzati come muri di confine tra gli appezzamenti. Contrariamente alla pianta, l’edificio vero e proprio è stato costruito con angoli morbidi. Data della foto sconosciuta. (Archivio Enzo Satta)
B. Casa Wood. Il primo edificio di Savin Couëlle in Costa Smeralda fu costruito con la licenza edilizia del 1964 in forma modificata. Pianta e sezione. (Archivio Enzo Satta)
C. Casa Wood. Viste e sezione. (Archivio Enzo Satta)
A. La scala a chiocciola è un elemento tipico dell’architettura di Savin Couëlle. Foto degli anni ’60. A (Archivio Enzo Satta)
B. Un altro tipico interno di Savin Couëlle. La composizione delle altezze delle stanze, del camino e delle scale curve è costruita allo stesso modo di Casa Wood. Foto degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
5.2. Casa In Sanatorio
Il secondo progetto di Savin, realizzato nel 1965 per un cittadino di Vaduz, in Liechtenstein, è In Sanatorio. L’edificio si trova su una collina di Porto Cervo, inizialmente isolato lungo una curva stradale, oggi immerso in un quartiere residenziale nascosto da una fitta vegetazione.
La struttura si basa su due stanze ottagonali – soggiorno e camera da letto – collegate da ambienti di servizio come la piccola cucina, il bagno e la scala. Questo progetto non è del tutto tipico di Savin Couëlle, ma porta ancora l’impronta del padre. La simmetria degli spazi, e la sua successiva rottura, sarà ulteriormente frammentata nei progetti futuri di Savin.
L’edificio rappresenta un esercizio preliminare per i selvaggi soffitti a volta del suo lavoro successivo. Qui appare per la prima volta il motivo del camino in muratura, un elemento che caratterizza tutte le opere dei Couëlle. Il tetto in tegole, modellato dolcemente come una pelle di rettile, copre gli ambienti di altezze diverse.
Nel dettaglio, si ricercò l’immagine di un’architettura rurale. Particolare attenzione fu dedicata all’atmosfera degli spazi, nascondendo il più possibile la tecnologia. La cappa della cucina fu mascherata con un rivestimento in legno; le luci vennero installate sotto i pensili, mentre gli armadietti furono realizzati con legno rustico e rifiniti con cerniere a forma di rombo.
La porta d’ingresso e le finestre furono progettate da Couëlle, con piccoli vetri quasi quadrati e pannelli in legno che richiamano il tradizionale artigianato locale. Le cucine – come anche i bagni – di Savin Couëlle sono più piccole rispetto a quelle degli altri architetti fondatori, ma la materialità e l’atmosfera degli interni di In Sanatorio sono rappresentative di tutte le sue prime opere.
A. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Vista esterna. Foto della fine degli anni Settanta. (Archivio Enzo Satta)
B. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Pianta, sezione e vista, 1965 (Archivio Enzo Satta)
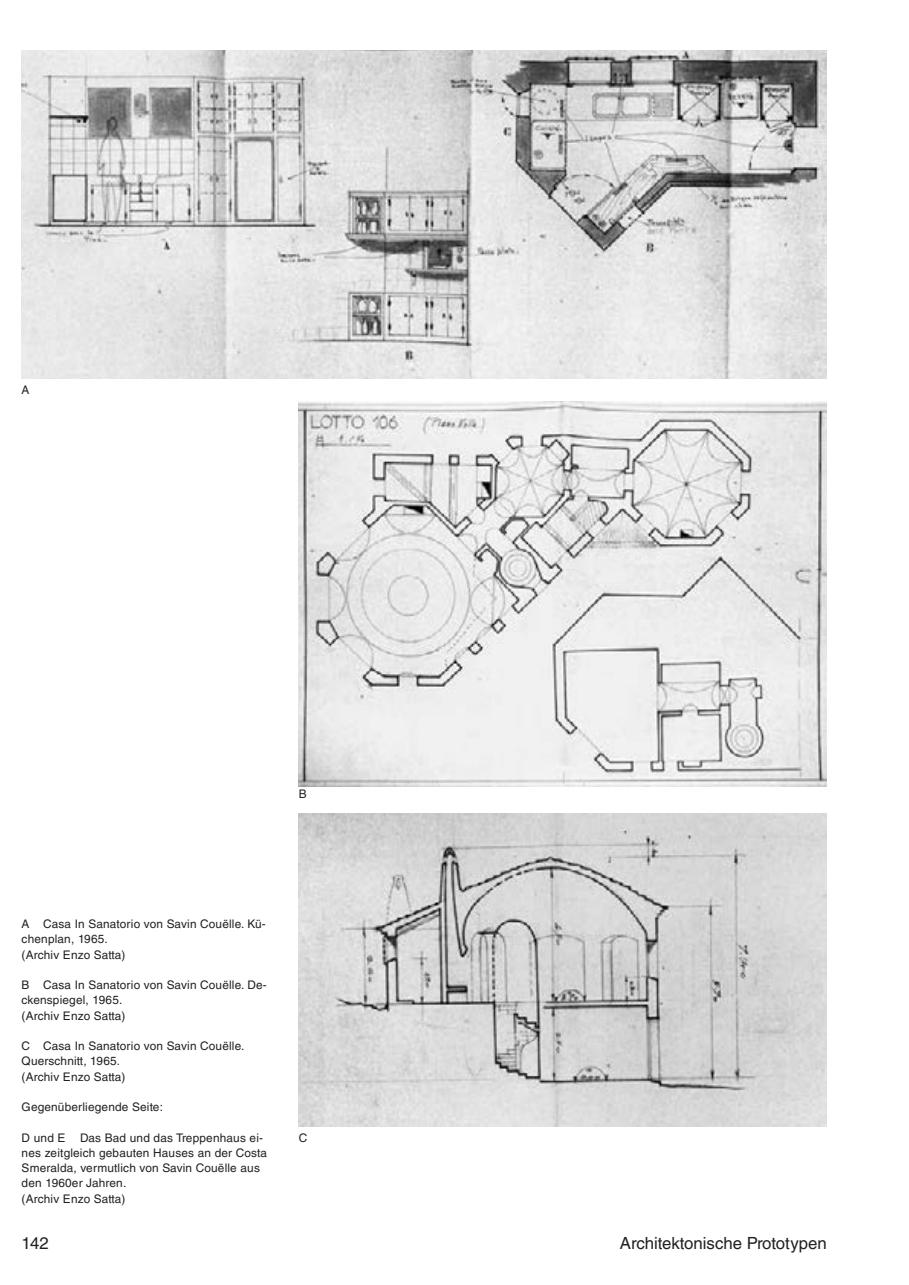
A. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Pianta della cucina, 1965. (Archivio Enzo Satta)
B. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Specchio a soffitto, 1965. (Archivio Enzo Satta)
C. Casa In Sanatorio di Savin Couëlle. Sezione trasversale, 1965. (Archivio Enzo Satta)
D. ed E. Il bagno e la scala di una casa costruita nello stesso periodo in Costa Smeralda, probabilmente da Savin Couëlle negli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
6. Michele Busiri-Vici
Michele Busiri-Vici proveniva da una famiglia romana con una lunga tradizione di artisti e architetti risalente al XVII secolo. A partire dagli anni ’40, progettò ville in stile mediterraneo lungo la costa romana, ispirandosi alle case rurali napoletane e ai trulli pugliesi. Le sue costruzioni erano sempre intonacate di bianco, caratterizzate da linee morbide e una combinazione di forme spaziali rotonde e ortogonali. Grazie a queste caratteristiche, venne scelto, già sessantenne, per il progetto della Costa Smeralda.(29)
Al primo impatto, la Costa Smeralda suggerisce che Busiri-Vici abbia avuto un ruolo centrale nel progetto. Tra le sue opere più rappresentative vi è la chiesa di Stella Maris, simbolo architettonico del luogo per il suo rapporto tra natura e cultura, come dimostrano le colonne in granito formatesi nel corso di milioni di anni e il dipinto della Madonna di El Greco appeso al muro. Il suo hotel Luci di Muntagna a Porto Cervo è uno dei primi edifici visibili per chi arriva via terra, mentre il complesso residenziale Sa Conca è stato ampiamente pubblicizzato nei materiali promozionali della Costa Smeralda. Progettò anche la centrale telefonica, un’infrastruttura essenziale per il consorzio nelle prime fasi del progetto.
Tuttavia, i suoi contributi sono scarsamente documentati, e le pubblicazioni su di lui sono limitate. Con il tempo, perse rilevanza all’interno del progetto, cedendo terreno a Vietti sia a Porto Cervo (dove non costruì il centro vero e proprio) sia a Romazzino. Come Jacques Couëlle, anche Busiri-Vici passò alcuni incarichi al figlio, sebbene il suo ruolo preciso nella Costa Smeralda rimanga poco chiaro.
(29. Nell’archivio di Enzo Satta non ci sono piani né quasi fotografie di interni di opere di Busiri-Vici. Solo le fotografie esterne delle sue ville sono numerose. Tuttavia, il Comune ha messo a disposizione i piani di un edificio, Casa Studio, per questa ricerca. Questo è uno dei primi edifici costruiti da Busiri-Vici alla Costa Smeralda, ma la disposizione circolare non è del tutto tipica. Pertanto, sarà trattato solo brevemente. Per un quadro il più possibile completo del lavoro di Busiri-Vici alla Costa Smeralda, verranno descritti gli edifici Sa Conca e Villa Bettina. Di Sa Conca è stata trovata una sezione e una pianta del tetto, e gli spazi esterni dell’edificio sono ancora accessibili. Della Villa Bettina è stata trovata una piccola immagine della pianta, che è stata ridisegnata da ND. Insieme, questi tre edifici forniscono una buona panoramica dello stile di Busiri-Vici. Inoltre, il Comune di Arzachena ha fornito i piani dell’Hotel Romazzino).
6.1. Casa Studio
Questo complesso residenziale, costruito nel 1964, si trova nel quartiere del vecchio porto di Porto Cervo, tra la chiesa Stella Maris e il mare. È il primo edificio che Busiri-Vici presentò per l’approvazione all’autorità edilizia, dove successivamente venne archiviato. Le otto unità residenziali, di forma circolare, sono disposte attorno a un cortile centrale anulare. Nel contesto della Costa Smeralda, Casa Studio rappresenta un’eccezione: l’edificio è orientato in maniera quasi uniforme su tutti i lati e tiene poco conto delle caratteristiche topografiche del luogo. Le abitazioni, di dimensioni piuttosto ridotte, sono organizzate intorno a un cortile interno, simile a una piazza di un villaggio.
Tuttavia, ci sono elementi che non solo sono tipici dello stile di Busiri-Vici, ma caratterizzano anche il suo lavoro alla Costa Smeralda. Il suo repertorio include spazi abitativi quasi circolari, organici, che richiamano fortemente le case trulli, e piante razionali, quasi moderne, con angoli arrotondati. Come in tutti gli edifici della Costa Smeralda, i camini fungono da punto focale per l’organizzazione degli spazi interni ed esterni: internamente rappresentano il centro dell’area abitativa, mentre esternamente donano verticalità e accenti impressionistici all’aspetto complessivo.
Gli edifici di Busiri-Vici, visti dall’esterno, appaiono quasi fiabeschi, con i loro bordi murari ondulati e i camini che sembrano colare verso l’alto, disposti in modo espressivo agli angoli degli edifici. Tra i tre architetti principali della Costa Smeralda, Busiri-Vici è quello che ha applicato con maggiore creatività i basamenti in granito, trasformandoli in elementi decorativi attraverso un disegno libero che si estende verso l’alto. Gli interni, invece, tendono a essere più semplici e pragmatici. Un’eccezione è rappresentata dagli ingressi rappresentativi e dagli spazi esterni coperti, che creano un continuum spaziale coerente con l’espressione artistica dell’esterno.
6.2. Sa Conca
Nel complesso residenziale Sa Conca, situato nelle vicinanze, l’interazione con il terreno diventa più evidente. Le abitazioni sono disposte trasversalmente rispetto alla costa, sfalsate l’una rispetto all’altra, permettendo a ciascuna unità di godere di una vista sul mare. Questa disposizione a gradoni è collegata da una scalinata che ricorda le atmosfere piranesiane. Parallelamente alla costa, i cinque blocchi principali sono uniti sul lato strada da un porticato ad archi e, otto metri più in basso, da una scala trasversale che attraversa tutti e cinque gli edifici. Insieme alle scale che scendono dalla strada verso la costa, questi collegamenti formano un vero e proprio paesaggio architettonico.
L’aspetto degli edifici presenta caratteristiche simili a quelle di Casa Studio. I dettagli espressivi di Busiri-Vici uniscono spesso una funzione pratica a un’estetica enfatizzata. Ad esempio, il basamento in granito, progettato principalmente per proteggere l’intonaco dall’acqua, è decorato con un disegno libero che lo trasforma in un elemento ornamentale. I profili ondulati degli edifici di Sa Conca sono creati dalle tegole di copertura. In altre ville di Busiri-Vici, questi profili ondulati sono invece generati dai parapetti delle terrazze sul tetto.
A. La chiesa Stella Maris di Porto Cervo di Busiri-Vici. La foto è stata scattata probabilmente alla fine degli anni Settanta. (Archivio Enzo Satta)
B. L’Hotel Luci di la Muntagna a Busiri-Vici. La foto risale probabilmente alla metà degli anni Sessanta. (Archivio Enzo Satta)
A. Un edificio in Costa Smeralda di Busiri-Vici, forse la Casa Studio. L’apertura al centro dell’immagine di un semicerchio su un rettangolo più piccolo è tipica della sua architettura in Costa Smeralda. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
B. Un interno di Busiri-Vici con la stessa apertura tra due stanze su livelli diversi. Si caratterizza anche per la ringhiera sottile e ondulata e per l’uso di piastrelle Cerasarda di colore azzurro. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
A. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista della scala tra due parti dell’edificio. Foto 1966 (Archivio Enzo Satta)
B. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista tra due parti dell’edificio verso la costa. Foto 1966 (Archivio Enzo Satta)
C. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista dal basso tra due parti dell’edificio verso la scala. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
D. Condominio Sa Conca di Busiri-Vici, vista attraverso gli edifici fino alla scala che corre sotto gli speroni del crinale. (Foto ND 2015)
6.3. Villa Bettina
La villa di Bettina Graziani, ultima compagna del padre dell’Aga Khan, fu uno dei primissimi edifici costruiti alla Costa Smeralda. Già nel 1962 sorgeva nella baia di Pitrizza. La pianta rappresenta un esempio emblematico dell’approccio progettuale di Busiri-Vici: a partire da un nucleo geometrico, gli ambienti si deformano con movimenti morbidi verso i margini esterni.
Nella Villa Bettina, i quattro bracci, disposti ortogonalmente intorno a un cortile interno ovale, seguono un’impostazione classica. Spesse pareti angolari fanno da raccordo tra le due geometrie delle diverse aree. L’ala nord-est, che si collega all’ingresso principale, ospita la zona per gli ospiti, gli spazi per il personale e la cucina. Le ali sud-est e sud-ovest accolgono le stanze private, mentre l’ala nord-ovest è dedicata al grande salone, il più deformato nella forma, i cui due estremi si allungano verso il mare.
Il salone è suddiviso in tre livelli: la parte centrale, con una grande finestra affacciata sulla costa, si trova alla quota più bassa, mentre le estremità sono rialzate. All’estremità ovest, la più alta, Busiri-Vici installò un pavimento in legno di ginepro con intarsi di gesso, un dettaglio che si ritrova in tutte le prime opere realizzate alla Costa Smeralda. Lo stesso materiale fu utilizzato da Couëlle a Cala di Volpe e da Vietti in una delle ville fondatrici di Porto Cervo (dove pare si senta ancora oggi il profumo del ginepro).
Non è possibile stabilire quale dei tre architetti abbia introdotto per primo questo tipo di pavimentazione, poiché le fonti sono contraddittorie. Tuttavia, l’uso condiviso dei materiali suggerisce che ci fossero accordi tra i progettisti, che andavano oltre le somiglianze formali fino a influenzare i dettagli tecnici. Anche l’arredamento della villa di Bettina Graziani è in sintonia con quello documentato negli interni di Vietti: un mix di oggetti provenienti da tutto il mondo combinati con prodotti sardi, come cuscini e tappeti.
Nei grandi archi, a volte, manca in Busiri-Vici una piena coerenza tra l’interno e l’esterno. Gli archi espressivi, infatti, sono spesso chiusi all’interno con finestre rettangolari, i cui angoli superiori si trovano contro pareti cieche. Una soluzione simile e altrettanto pragmatica si trova anche nelle opere di Vietti, nei suoi grandi finestroni panoramici ad arco.
A. La pianta di Villa Bettina riflette la firma progettuale di Busiri-Vici. Basandosi su forme geometriche chiare, egli ammorbidisce la figura ai bordi. (Pianta ND, fonte: Progettare in Costa, p.11)
B. Il pavimento della zona giorno di Villa Bettina con legno di ginepro intarsiato nell’intonaco. (Vanno a nascondersi 1969)
C. Gli espressivi archi sono chiusi all’interno da finestre rettangolari. (Vanno a nascondersi 1969)
D. La rimessa di Villa Bettina. Foto del 1966 (Archivio Enzo Satta)
6.4. HOTEL ROMAZZINO
Busiri-Vici ha costruito due importanti hotel in Costa Smeralda. A Porto Cervo, ha realizzato l’hotel Luci di Muntagna, un quattro stelle di grande rilevanza grazie alla sua posizione centrale nella località.
Il suo secondo hotel, il Romazzino, fu costruito quasi contemporaneamente(32). Fa parte del quartetto dei lussuosi hotel a cinque stelle, insieme al Pitrizza, al Cervo e al Cala di Volpe. Per la sua grandezza, il ruolo di ammiraglia della Costa Smeralda e la clientela esclusiva, il Romazzino rappresenta un esempio emblematico.(33) Non si trattò di un progetto completamente autonomo: la progettazione fu discussa con il comitato architettonico e sembra che anche Couëlle abbia influenzato il design.(34)
(32. Fonti relative all’Hotel Romazzino: Nell’archivio di Enzo Satta si trovano numerose fotografie. Il comune ha messo a disposizione i piani dell’edificio).
(33. L’Hotel Romazzino si trovava sulla proprietà dell'”Etablissement Romazzino”, la prima società creata per lo sviluppo della Costa Smeralda. Oltre all’Aga Khan, di questa società facevano parte membri delle famiglie Rothschild, Fürstenberg e Guinness. Si presume che, in seguito alla morte di Patrick Guinness nel 1965, ci siano stati conflitti temporanei sulla proprietà dell’Hotel Romazzino, che per un periodo non è stato considerato parte della Costa Smeralda. L’Aga Khan, tuttavia, riprese successivamente l’hotel. Cfr. Piga 2013, p. 177).
(34. Si dice che Couëlle abbia chiesto a Busiri-Vici di invertire l’ultima fila di archi. Questa inversione divenne un tratto distintivo dei tre architetti alla Costa Smeralda. Cfr. Riccardi 2010, p. 125).
Progetto e caratteristiche
Costruito nel 1964, contemporaneamente alle prime ville, il complesso alberghiero si distingue per la sua dimensione. Diversamente dagli altri due hotel descritti in precedenza, che si integrano con la morfologia rocciosa del paesaggio, il Romazzino è quasi una “paesaggio” a sé stante.
Dal corpo centrale a forma di torre si diramano cinque ali, formando una pianta simile a una mulinello, come al Cala di Volpe. Al centro si trovano gli spazi comuni, quali lobby, ristoranti e aree soggiorno, mentre le camere sono distribuite nella torre e nelle quattro ali inferiori che si estendono verso il mare. La quinta ala, a forma di ferro di cavallo, accoglie l’ingresso principale sul lato strada.
Il piano è razionale: ogni ala è servita da un corridoio sul lato collinare, da cui si accede alle camere. Ogni camera è dotata di uno spazio d’ingresso con bagno e guardaroba, mentre verso il mare si apre una loggia privata. I progetti di Busiri-Vici, più funzionali rispetto a quelli di Couëlle o Vietti, ricordano i layout moderni classici, smorzati da due elementi: le linee organiche della figura generale e gli angoli arrotondati.
Gli spazi pubblici al piano terra offrono una composizione elegante e stratificata, quasi cavernosa. Non ci sono giunzioni ortogonali: soffitti e pareti si fondono in curve morbide intonacate. Nonostante l’organicità delle forme, l’ordine spaziale interno è chiaro e ritmico. Nella lobby, Busiri-Vici ha disegnato ornamenti in ceramica che si intrecciano sulle grandi colonne portanti. Tutte le pareti e i soffitti sono intonacati e dipinti di bianco, mentre i pavimenti sono ricoperti con piastrelle in ceramica di 25×25 cm, posate in diagonale. L’atmosfera generale degli spazi è caratterizzata da una sobria eleganza floreale.
Stile architettonico della Costa Smeralda
La disposizione a pianta a mulinello richiama quella del Cala di Volpe di Couëlle, escludendo la possibilità di un caso. Questo e altri elementi dimostrano la volontà condivisa dai tre architetti di sviluppare un linguaggio architettonico comune. Come nelle opere di Vietti e Couëlle, anche il Romazzino segue la topografia: la struttura principale è frammentata in pianta e sezione, con i piani degli edifici a quote differenti.
Tutti e tre gli architetti hanno adottato elementi rurali ispirati all’architettura mediterranea anonima, incluso l’uso di spazi che richiamano caverne, visibili negli ingressi di Busiri-Vici, nei saloni del Pitrizza di Vietti e negli spazi pubblici di Porto Cervo.
A. Una vista panoramica dell’Hotel Romazzino, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. La hall dell’Hotel Romazzino con ornamenti in ceramica di Cerasarda. Foto del 1966 (Archivio Enzo Satta)
C. L’ingresso dell’Hotel Romazzino. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
D. Vista dell’ala est dell’Hotel Romazzino. Foto del 1966. C (Archivio Enzo Satta)
A. Una vista panoramica dell’Hotel Romazzino, foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. La hall dell’Hotel Romazzino con ornamenti in ceramica di Cerasarda. Foto del 1966 (Archivio Enzo Satta)
C. L’ingresso dell’Hotel Romazzino. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
D. Vista dell’ala est dell’Hotel Romazzino. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
Una vista da Porto Cervo Marina al centro della città principale, tra Porto Cervo Marina e Porto Cervo Vecchio. Nei primi tempi qui si trovavano solo edifici Busiri-Vici. Gli edifici sulla collina comprendono, da sinistra a destra, la chiesa di Stella Maris, Sa Conca, l’Hotel Luci di la Muntagna, Sas Pedras, S’Abbia Ilde e l’edificio dei telefoni. Tutti gli edifici sono di Busiri-Vici. Foto probabilmente della fine degli anni Settanta. (Archivio Enzo Satta)
7. Adattamento paesaggistico
L’architettura della Costa Smeralda non si limita a far riferimento al paesaggio, ma ne è interamente plasmata. A ogni scala, le caratteristiche topografiche, geologiche e vegetali influenzano le decisioni progettuali. Questa relazione con il paesaggio rappresenta sia una scelta estetica che economica, conferendo coerenza e unicità a tutta l’area.
Elementi architettonici ricorrenti, già collegati alla tradizione edilizia sarda e alle norme di costruzione, riflettono l’interazione armoniosa tra l’architettura e il territorio naturale.
7.1. Radicamento nel Territorio – Integrazione tra rocce e flora
L’inserimento nella topografia esistente e nelle formazioni rocciose è determinante per la configurazione planimetrica di ciascun edificio. Grazie alla sua ripetizione, questo elemento formale caratterizza l’identità visiva complessiva della Costa Smeralda.
I primi piani realizzati dal consorzio per Porto Cervo nel 1962 testimoniano una cartografia dettagliata del paesaggio esistente, con un’attenzione straordinaria ai dettagli. Rocce e vegetazione furono mappate con grande precisione, fino al punto di registrare ogni singolo cespuglio di ginestra.
I corpi edilizi sono stati progettati intorno alle rocce preesistenti. Alcuni volumi abbracciano letteralmente le formazioni rocciose, incorporando nella planimetria l’ombra proiettata dalle strutture geologiche. Le rocce, in questo modo, diventano elementi plastici nella composizione architettonica. Un esempio emblematico è il complesso residenziale situato all’estremità orientale di Porto Cervo, progettato da Guglielmo Mileto. Qui, il grande complesso è stato suddiviso in edifici singoli che si adattano intorno alle rocce granitiche, imitando per dimensioni e contorni i modelli geologici. Formazioni rocciose e volumi architettonici si intrecciano lungo la costa, creando una composizione unitaria.
Lo stesso approccio è stato applicato alla vegetazione esistente, come vecchi ulivi o gruppi di ginepri di particolare bellezza. Gli edifici sono stati progettati in modo da preservare tali piante, costruendo intorno a esse. Su suggerimento del consorzio, i progettisti di SDDA si sono impegnati in numerosi casi a conservare alberi o cespugli rilevanti e a pianificare strade o edifici di conseguenza. Tuttavia, per motivi pratici, attorno ai cantieri è stato spesso spianato temporaneamente il terreno, e la “vegetazione esistente” è stata successivamente ripristinata con piante prevalentemente locali (come approfondito nel capitolo 3).
Forme organiche e analogie con la geologia
Questo radicamento nel paesaggio ha dato origine a planimetrie disegnate con angoli liberi, che richiamano il linguaggio formale di Frank Lloyd Wright, ad esempio quello del Clark Cottage, ma in una versione più geometrica. Allo stesso modo, anche le sezioni seguono un linguaggio formale ispirato alle formazioni geologiche. Ogni edificio, in analogia con il paesaggio roccioso, presenta una “topografia interna”. Le coperture sono pensate come elementi topografici percorribili, composte da tetti a tegole organizzate organicamente e terrazze sul tetto che si integrano armoniosamente nel contesto naturale.
Relazione tra Edificio e Paesaggio
Gli edifici si presentano isolati, circondati dalla natura. L’evitare forme architettoniche di grandi dimensioni nasce sia da motivazioni estetiche che funzionali. Analogamente ai massi granitici erosi, le singole costruzioni si adagiano solitarie sulla costa, in relazione diretta con il paesaggio piuttosto che con altre strutture, come avverrebbe in un contesto urbano.
Quando le grandi strutture sono inevitabili, come nel caso di Porto Cervo, la figura di base viene frammentata, e le sezioni degli edifici creano una topografia propria, simile a un paesaggio. Questi principi progettuali sono stati formalizzati attraverso le normative edilizie del “Regolamento Edilizio Costa Smeralda”, che hanno escluso forme lineari e rigide, imponendo un’armonia con la topografia naturale del terreno. Questa frammentazione è ideale per garantire la privacy desiderata dai residenti (vedi capitolo 1.3.2).
La vista come elemento determinante dell’architettura
L’incontro tra il fascino del paesaggio e il suo valore economico è particolarmente evidente nel tema della vista. Poiché la natura è prioritaria, il design architettonico cerca di offrire la massima apertura verso la costa e il mare. Questo approccio influenza la zonizzazione dei terreni e determina la collocazione degli edifici sul territorio.
A partire dal 1967, SDDA ha mappato la qualità delle visuali disponibili, utilizzando queste informazioni per posizionare le costruzioni. La qualità della vista e la protezione dalla visibilità altrui sono fattori fondamentali per il valore e il design degli edifici. Questi aspetti gerarchizzano anche gli spazi interni: le ville più grandi e lussuose occupano i punti panoramici migliori e vengono orientate per massimizzare la vista.
La disposizione delle stanze all’interno riflette questa priorità. Verso il pendio, le aperture sono ridotte per garantire privacy; verso la costa, invece, le finestre sono ampie, spesso integrate con pergolati e terrazze panoramiche. Questo crea un’interazione fluida tra interno ed esterno, in contrasto con l’aspetto più chiuso e protetto del lato rivolto verso il pendio. Le architetture diventano così quasi dei “meccanismi” che orchestrano la relazione tra visibilità e discrezione.
Anche la vista interna viene valorizzata grazie a configurazioni terrazzate. Spesso, l’ingresso avviene dal lato del pendio, e la sequenza di spazi discendenti culmina in un’apertura spettacolare verso il panorama.
Percorsi progettati
I percorsi d’accesso sono strettamente legati all’integrazione topografica e alla gestione delle visuali. Le strade sinuose sono progettate per offrire scorci suggestivi, garantendo al contempo la massima privacy grazie alla combinazione di vegetazione, muri di granito e conformazione del terreno.
L’esperienza inizia già dal cancello d’ingresso, spesso realizzato in legno di ginepro incurvato, come in un tradizionale podere sardo. Da qui parte un vialetto curvato che nasconde la villa alla vista. Gli edifici sono generalmente situati più in basso rispetto alla strada, sfruttando la naturale pendenza del terreno per nasconderli. La casa è spesso parzialmente celata da terrazze e percorsi stretti che si arrampicano sul pendio, accentuando la sensazione di scoperta.
Le scale interne continuano questa narrazione topografica, enfatizzando il piacere dell’esplorazione spaziale. Questo approccio è particolarmente evidente nelle ville progettate da Jacques e Savin Couëlle, ma anche negli interventi di Busiri-Vici a Sa Conca e di Vietti nel centro di Porto Cervo, dove i percorsi si sviluppano su diversi livelli topografici.
Sul lato rivolto al panorama, i percorsi stretti iniziali si aprono gradualmente in ampi spazi, culminando in terrazze articolate, che sembrano galleggiare come scaglie sopra il paesaggio.
Il Giardino – un Doppio Agente
La progettazione del giardino riflette il duplice ruolo della natura, al contempo idealizzata e utilizzata in modo manipolativo. Tutti i giardini sono stati generalmente progettati da Florasarda, una società appositamente fondata per occuparsi dell’organizzazione e della messa a dimora delle piante.
Muri in granito irregolarmente squadrato delimitano il giardino, richiamando le tradizionali recinzioni per ovini della Sardegna. I sentieri, invece, si snodano seguendo linee disegnate liberamente, attraversando prati che sembrano zolle. La progettazione segue la topografia, integrando eventuali formazioni rocciose. Nei prati si trovano per lo più alberi e arbusti autoctoni sardi, integrati da alcune piante mediterranee non originarie dell’isola. Tuttavia, l’attenta integrazione con la natura preesistente è contrastata da un utilizzo manipolativo della vegetazione: vengono impiegate esclusivamente piante che fioriscono nei mesi estivi di luglio e agosto.
Davanti agli spazi più privati, come i bagni o le aree destinate al personale, vengono collocati arbusti locali che creano una distanza naturale, sia fisica che simbolica. Le zone destinate agli ospiti, invece, sono caratterizzate da nicchie create dalla disposizione delle piante. Le aree adiacenti agli spazi pubblici, ma che non devono essere attraversate, vengono delimitate con cespugli spinosi tipici della Sardegna.
In questo modo si crea una simbiosi tra vegetazione, costruzioni e utilizzo, che per due mesi l’anno dà vita a un ambiente abitativo ideale. La vegetazione assume così una funzione duplice: estetica e arricchente, ma anche regolatrice e controllante.
A. L’integrazione topografica si riflette anche nel tetto calpestabile, concepito come parte integrante del paesaggio, progettato da tutti e tre gli architetti.” Villa di Luigi Vietti. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Nel centro di Porto Cervo di Vietti, dove il programma richiede una grande forma, viene creato un paesaggio topografico separato. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. Planimetria di una villa di Luigi Vietti nel nord di Porto Cervo. L’accesso avviene dal lato della collina, mentre l’organizzazione degli spazi si concentra nel punto con la vista migliore. Piano del 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. Planimetria di una villa di Luigi Vietti nel nord di Porto Cervo. L’accesso avviene dal lato della collina, mentre l’organizzazione degli spazi si concentra nel punto con la vista migliore. Piano del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Le ville sono progettate con un lato chiuso verso la collina, mentre verso la vista panoramica le finestre diventano più ampie e le pergole e le terrazze esterne ampliano gli spazi abitativi offrendo una vista mozzafiato. Qui la Villa Ginestro. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
C. La stessa villa di cui sopra vista dal lato interno. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. – D. Dalla strada attraverso la casa fino alla terrazza esterna. Tutte le ville di Savin Couëlle. Foto probabilmente del 1966. (Archivio Enzo Satta)
7.2. L’idea del paesaggio permea l’architettura
Il linguaggio architettonico è caratterizzato dall’integrazione con il paesaggio sardo. I confini tra edificio, topografia modificata, vegetazione e natura circostante vengono parzialmente dissolti, fondendo tutti gli elementi in un’opera unitaria. Ogni componente architettonica riflette l’idea del paesaggio.
L’uso diretto di elementi naturali testimonia l’interesse dei fondatori per l’ambiente preesistente. Tuttavia, l’uso estetico di tali elementi rivela talvolta un atteggiamento da esploratori poco critico, definito dai critici come un approccio consumistico nei confronti della Sardegna.
Basamenti in granito
Quasi ogni villa del periodo fondativo sorge su un basamento di granito locale irregolarmente squadrato, un collegamento simbolico tra il terreno naturale e la struttura progettata.
Muri in granito
I muri in granito sono impiegati lungo tutta la Costa Smeralda per delimitare i confini delle proprietà, richiamando i tradizionali “muri a secco” costruiti dai pastori sardi per suddividere il territorio.
Muri di contenimento
I muri di contenimento, spesso utilizzati da Vietti, rappresentano un ancoraggio metaforico alle pendenze del terreno. In chiave storica, rispondono direttamente alle esigenze topografiche, ma sulla Costa Smeralda assumono anche un valore estetico. Couëlle li ha reinterpretati nelle aperture ad arco di Cala di Volpe, così come Busiri-Vici in altri suoi progetti.
Interni simili a grotte
Gli spazi interni progettati da Jacques e Savin Couëlle ricordano ambienti cavernosi, rendendo visibile l’interazione tra architettura e paesaggio. Questi spazi organici si trovano anche nei progetti di Busiri-Vici e nei passaggi di Porto Cervo progettati da Vietti.
Terrazze
Le terrazze, sui tetti e negli spazi esterni, sono pavimentate con granito o tegole di terracotta, formando lastre che si integrano formalmente nel paesaggio naturale.
Rocce di granito erose dal tempo
Le formazioni geologiche preesistenti sono state in parte integrate nelle costruzioni, diventando elementi plastici. I fondatori le hanno utilizzate per creare accenti architettonici, come Busiri-Vici nella chiesa Stella Maris o Vietti nell’ingresso principale del Pitrizza. Oggi, rocce di granito erose nel corso di milioni di anni vengono utilizzate in tutta l’isola come elementi scultorei, dando vita a un’industria locale per la vendita di queste formazioni.
Rami scultorei
Come le rocce di granito, anche i rami naturalmente modellati sono stati incorporati nell’architettura. A volte sono stati utilizzati come elementi decorativi sopra gli architravi o come balaustre per gli spazi interni ed esterni.
A. I muri in granito richiamano la suddivisione territoriale dei pastori e il metodo costruttivo degli stazzi, le abitazioni vernacolari dei pastori in Gallura. Villa di Jacques o Savin Couëlle. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Il basamento in granito funge da elemento di collegamento tra il terreno e l’edificio. I muri di sostegno ancorano visivamente le pareti alla pendenza del terreno. Villa di Luigi Vietti. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. Le terrazze intrecciano l’architettura con il terreno, villa probabilmente di Savin Couëlle, foto 1966 (Archivio Enzo Satta).
B. I rinforzi angolari ancorano metaforicamente gli edifici al territorio. Villa di Vietti. Foto 1966 (Archivio Enzo Satta)
C. Ambienti progettati in grotta. Villa di Jacques Couëlle. Foto 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. La tettoia della chiesa di Stella Maris a Busiri-Vici è sostenuta da rocce di granito erose dal tempo. Foto degli anni ’70. (Archivio Enzo Satta)
B. I rami cresciuti naturalmente formano le balaustre per tutti e tre gli architetti, qui Porto Cervo di Vietti. Foto del 1966. (Archivio Enzo Satta)
8. Stile Costa Smeralda – Inserimento nelle tendenze contemporanee
Nella descrizione delle prime opere realizzate alla Costa Smeralda emerge il tentativo dei tre architetti fondatori di sviluppare un linguaggio architettonico condiviso. Due linee narrative aiutano a collocare queste opere nelle tendenze dell’epoca. La prima riguarda l’uso di elementi costruttivi rurali, che caratterizzano l’espressione dello stile architettonico. I tre fondatori si sono ispirati al repertorio delle costruzioni vernacolari della Sardegna e del Mediterraneo. Parallelamente, il Neorealismo italiano mostra riferimenti simili all’architettura rurale.
La seconda linea narrativa, più breve, riguarda i riferimenti ad altri architetti, in particolare Frank Lloyd Wright. Le soluzioni di Wright per la disposizione della pianta e della sezione, così come il suo approccio all’integrazione tra architettura e paesaggio, rappresentano possibili modelli di ispirazione.
Questi due filoni trovano origine in tre mostre fondamentali che segnano altrettanti punti di svolta. La prima è la mostra del 1936 a Milano, «Architettura rurale italiana», che segna l’inizio dell’interesse per l’architettura rurale in Italia. La seconda è la mostra del 1951 a Firenze dedicata a Frank Lloyd Wright, che evidenzia l’influenza dell’architetto americano. Infine, i primi progetti della Costa Smeralda possono essere visti come un’anticipazione concreta di una tendenza contemporanea che troverà piena espressione nella mostra «Architecture without Architects» del 1964 a New York. Questa esposizione presentava una panoramica dell’architettura vernacolare mondiale, organizzata per temi, ponendo la natura sullo stesso piano dell’architettura come forza creativa.(37. La mostra Architecture without Architects si svolse dal 9 novembre 1964 al 7 febbraio 1965 al Museum of Modern Art di New York ed è stata curata dall’architetto viennese Bernard Rudofsky).
Punto di partenza comune – «Architettura rurale italiana»
L’uso di elementi architettonici rurali in Italia, in relazione ai processi di costruzione industriale, ha radici profonde. Tutti i percorsi dell’architettura rurale nel dopoguerra conducono alla mostra «Architettura rurale italiana» del 1936, organizzata durante la VI Triennale di Milano e curata da Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel.(35. La mostra Architettura rurale italiana del 1936 fu presentata alla VI Triennale di Milano e curata da Giuseppe Pagano e Guerniero Daniel).
In questa occasione, alcuni architetti che in seguito avrebbero formato gruppi distinti si trovarono su una piattaforma comune. Tra gli altri, Ludovico Quaroni illustrò come l’architettura contemporanea potesse essere connessa alla tradizione italiana. Anche Gio Ponti, che avrebbe collaborato in seguito con Vietti per Lo Stile, presentò alla Triennale un progetto per una piccola unità abitativa.
La pubblicazione della mostra comprendeva una selezione di fotografie curate da Pagano, che documentavano in composizioni di sei immagini ciascuna motivi architettonici della tradizione mediterranea. Venivano presentate costruzioni rurali anonime provenienti da diverse aree del Mediterraneo, come i trulli delle coste, Amalfi, l’Algeria, la Toscana e Roma. Furono individuati motivi comuni che attraversavano varie regioni e che in seguito sarebbero stati ripresi dal comitato architettonico della Costa Smeralda.
Tra questi motivi si trovano: camini dalle forme espressive, terrazze sul tetto, torri abitative, scale esterne in muratura, serie di archi, mattoni disposti diagonalmente per la ventilazione e pergolati in legno incassati nella muratura. Inoltre, nella pubblicazione sono documentati elementi che sarebbero entrati a far parte del repertorio standard di Busiri Vici alla Costa Smeralda, come le pareti e i tetti morbidi e arrotondati, nonché la particolare forma dei camini, che si allargano verso l’alto, tradizionalmente presenti sulla costa amalfitana e a Ischia.
Fotografie del sud dell’Algeria mostrano un piano terra arretrato e chiuso da archi scultorei, una soluzione che sarebbe stata adottata da Vietti a Porto Cervo e da Couëlle a Cala di Volpe. Nella pubblicazione della mostra si trovano così tanti motivi riconducibili alla Costa Smeralda che appare plausibile chiedersi se questa pubblicazione, oltre al patrimonio architettonico sardo, abbia rappresentato una seconda fonte d’ispirazione per la definizione dello stile della Costa Smeralda.
Anche in questo caso si ritrovano tracce che conducono alla Sardegna e si manifesta un comune spirito del tempo. La selezione degli edifici fotografati è avvenuta in collaborazione con l’artista sardo Costantino Nivola, amico e modello artistico di Le Corbusier. (40. Fotograficamente, lo sviluppo in Sardegna è spesso ricollegato a Pagano e al Neorealismo. In un recente catalogo della mostra NeoRealismo. La nuova fotografia in Italia 1932-1960, è stato stabilito un collegamento visivo tra il Neorealismo e l’Architettura Rurale con la Sardegna. Nel catalogo è inclusa una fotografia di Pagano che ritrae un’architettura rurale sarda. Cfr. Viganò, Enrica, NeoRealismo. La nuova fotografia in Italia 1932-1960, Basilea 2007).
Gli architetti del consorzio possono essere ricondotti a questa precedente tendenza dell’epoca. Vietti, ad esempio, aveva già utilizzato elementi rurali nel progetto per un complesso alberghiero sul Lago Maggiore, presentato nella sua tesi di laurea del 1928. Egli stesso descrive questo lavoro come emblematico per la sua carriera.(41. L’attività di Luigi Vietti è stata ricostruita con maggiore precisione per questa ricerca, poiché egli ha ricoperto il ruolo più importante alla Costa Smeralda. Oltre alla monografia Luigi Vietti. Progetti e realizzazioni degli anni ’30 di Dell’Aira, è stata considerata anche la pubblicazione di Giani 100 anni di Luigi Vietti, sebbene quest’ultima contenga poche descrizioni architettoniche. Fornisce invece un elenco dell’attività quasi secolare di Vietti come architetto in una specifica società italiana. In generale, non è stato ancora fatto alcun tentativo di una vera classificazione dei tre architetti. Price e, soprattutto, Cappai rappresentano un’eccezione parziale).
Anche Busiri-Vici, con il suo stile bianco e mediterraneo, aveva realizzato prima della fine della guerra una villa per la contessa Calvi di Bergolo nel 1941. Solo Jacques Couëlle iniziò a costruire più tardi, nel 1955, con il resort Castellaras le Vieux.
I fondatori del comitato architettonico possono essere associati a uno stile che, a partire dalla mostra «Architettura rurale italiana», ha rappresentato un tema architettonico costante in Europa.
Nel 1937 Bernard Rudofsky, insieme a Luigi Cosenza, costruì una casa a Napoli che anticipava la topografia costruita della Costa Smeralda. Questo edificio presentava un linguaggio formale moderno, con volumi cubici intonacati di bianco, colonne sottili in metallo e ringhiere che ricordano i parapetti delle navi. Nella parte inferiore si trovava un basamento in pietra naturale con rinforzi murari simili a quelli di una fortezza, mentre le scale che seguivano l’edificio lungo il pendio evocavano l’immagine di scalinate scavate nella roccia.
Sempre nel periodo tra le due guerre, nel 1938, Gio Ponti e Bernard Rudofsky progettarono l’hotel San Michele sull’isola di Capri, un progetto che non fu mai realizzato. Tuttavia, in questo lavoro anticiparono molti elementi che sarebbero stati ripresi negli anni Sessanta dal comitato architettonico della Costa Smeralda. Attorno all’edificio principale dell’hotel erano distribuite piccole strutture per gli ospiti, disposte lungo il terreno in modo tale che sezioni e piante si adattassero alla topografia. Ponti e Rudofsky disegnarono assonometrie con un tratto volutamente ingenuo, sottolineando la natura circostante, l’unico elemento che veniva colorato nei disegni.
Una vista da Porto Cervo Marina al centro della città principale, tra Porto Cervo Marina e Porto Cervo Vecchio. Nei primi tempi qui si trovavano solo edifici Busiri-Vici. Gli edifici sulla collina comprendono, da sinistra a destra, la chiesa di Stella Maris, Sa Conca, l’Hotel Luci di la Muntagna, Sas Pedras, S’Abbia Ilde e l’edificio dei telefoni. Tutti gli edifici sono di Busiri-Vici. Foto probabilmente della fine degli anni Settanta. (Archivio Enzo Satta)
A. La mostra “Architettura rurale italiana” presentava una raccolta di fotografie organizzate per motivi architettonici. (Pagano/Daniel 1936, p. 3)
B. Un motivo presente nella mostra era quello delle pergole in legno murate. Questo motivo è stato utilizzato sulla Costa Smeralda da Vietti, Couëlle e Busiri-Vici. (Pagano/Daniel 1936, p. 69)
C. Raccolta di stampi per caminetti provenienti dal Veneto, dalla Lombardia, dall’Italia centrale e dall’Italia meridiana. (Pagano/Daniel 1936, p. 21)
D. Piano terra coperto con archi scultorei a tutto sesto antistanti nell’Algeria meridionale. Camini espressivi. (Pagano/Daniel 1936, p. 49)
[TENDENZE EUROPEE] NEL DOPOGUERRA
Nuove località turistiche in Europa [vedere altre foto nel PDF originale]
Nel dopoguerra, Ignazio Gardella emerge come figura chiave dell’architettura turistica italiana. Negli anni Cinquanta e Sessanta, realizza diversi edifici destinati al turismo. Nel 1956, insieme a Marco Zanuso, progetta un hotel e il complesso portuale di Arenzano. Questa struttura si integra abilmente nella topografia locale e utilizza elementi vernacolari come i tetti in tegole e motivi ad arco rurali. Combina l’architettura razionale, espressa nel basamento continuo, con una struttura più frammentata e di ispirazione rurale.
Come per la Costa Smeralda, il complesso è spesso criticato più per la sua élite di abitanti che per l’architettura in sé. Secondo Paolo Cervini, infatti, nonostante il “raffinato ambientalismo”, il progetto non è privo di elementi snobistici, riflesso di una visione elitaria e borghese della residenza di piacere. Questo progetto anticipa uno stile di vita urbano in un’architettura rurale, un approccio simile a quello della Costa Smeralda, dove però manca la fusione tra elementi moderni e rurali.
Negli anni Sessanta, contemporaneamente a Porto Cervo, sorgono numerose nuove località turistiche sia sul mare sia in montagna, caratterizzate, in misura diversa, da un linguaggio architettonico rurale. Nessuna di queste raggiunge però la scala della Costa Smeralda, né rompe con il modernismo in modo così netto come i progetti in Sardegna.
Marcel Breuer, alla fine degli anni Cinquanta, pianifica in Francia la località sciistica di Flaine-la-Ville. Questa è composta da edifici a blocchi multipiano, disposti lungo il pendio della valle. Gli elementi rurali sono limitati a una fascia continua di pietra naturale al terzo piano. In Breuer emerge una visione urbanizzata della natura, in contrasto con una visione idealizzata e romantica.
Dal 1958, Luigi Caccia Dominioni e Ignazio Gardella progettano la piccola località di Pineta di Arenzano. Gli edifici presentano stili diversi: quelli di Caccia Dominioni seguono un’estetica vernacolare, con forme rettangolari, torri intonacate e dipinte di bianco, che ricordano le costruzioni rurali italiane e sfuggono a una facile collocazione temporale.
Nel 1964 François Spoerry sviluppa Port Grimaud, sulla costa meridionale della Francia, a nord-est di Saint-Tropez, su un’area paludosa. Questo complesso per famiglie della classe media è organizzato come un quartiere di case a schiera immerse nel verde, con i giardini che si affacciano su moli per piccole imbarcazioni. Le file di case, leggermente sfalsate tra loro, conferiscono al complesso un’espressione meno monumentale. A differenza della struttura cellulare e organica della Costa Smeralda, Port Grimaud è organizzato con strati lineari di spazi: un piccolo giardino anteriore conduce al segmento abitativo, che include un soggiorno con camere da letto sovrastanti, seguito da un giardino posteriore e, infine, da un molo per le barche. Come il comitato architettonico della Costa Smeralda, Spoerry utilizza elementi locali, applicandoli però a una pianificazione urbana radicata nella modernità.
A metà degli anni Sessanta inizia la progettazione di Avoriaz, una località sciistica nelle Alpi francesi. Sotto la guida degli architetti Jacques Labro, Jean-Jacques Orzoni e Jean-Marc Roques, sorgono grandi blocchi edilizi di dodici-sedici piani. Rivestiti in legno e con estremità inclinate, questi edifici ricordano in parte chalet di grandi dimensioni. Anche Carlo Mollino realizza diversi complessi turistici nelle Alpi, combinando direttamente la sua visione urbanistica con la natura.
L’architettura della Costa Smeralda, al contrario, esprime un ideale della natura più ingenuo. È ingenuo perché eleva la natura a fattore centrale della progettazione, pur consentendo un comfort tecnico che resta nascosto. In questo modo, la tecnologia permette una vita urbanizzata in una natura idealizzata, senza un’esplorazione critica del rapporto tra i due.
A. Veduta aerea di Port Grimauld: l’area “Les quatre vents” si trova nella parte inferiore dell’immagine. Cartolina probabilmente della fine degli anni Settanta. (Particolare di una cartolina, Archivio Enzo Satta)
B. Una casa a “Les quatre vents” di Port Grimauld vista dall’esterno. Opuscolo informativo su Port Grimauld del 1977 (Archivio Enzo Satta).
C. Gli strati sfalsati di stanze di Spoerry: Una tipica casa di Port Grimauld. Opuscolo informativo su Port Grimauld del 1977 (Archivio Enzo Satta)
D. Port Grimauld: la pianta di una delle ali del complesso, chiamata “Les quatre vents”. Opuscolo informativo su Port Grimauld del 1977 (Archivio Enzo Satta)
L’influenza di Frank Lloyd Wright
Il dopoguerra fu un periodo di riorientamento dell’architettura italiana, dopo l’era modernista sotto Mussolini. In questa fase, le opere di Frank Lloyd Wright esercitarono una notevole influenza sugli architetti italiani. L’architettura organica di Wright, come lui stesso la definiva, offriva un punto di riferimento per una nuova visione progettuale. In Italia, Bruno Zevi fu un importante mediatore delle idee e degli edifici di Wright. Nel 1945, Zevi pubblicò Verso un’architettura organica, dedicando due capitoli all’architetto americano.(50. Il titolo del libro è un riferimento a Vers une architecture di Le Corbusier, un’opera fondamentale della modernità. Già il titolo descrive l’idea dell’Italia del dopoguerra di progettare in una nuova direzione).
Alcuni anni dopo, nel 1951, Zevi organizzò a Firenze, presso Palazzo Strozzi, una mostra su Wright, accompagnata da un testo scritto dallo stesso Wright che esprimeva la sua visione dell’architettura. Questo testo potrebbe essere considerato, dieci anni più tardi, una descrizione dell’approccio adottato dal comitato architettonico della Costa Smeralda:
“Ogni architettura che meriti questo nome sarà, d’ora in poi, sempre più organica. L’architettura sarà primordiale; risponderà con arte – in armonia con il sentimento naturale e i mezzi industriali – ai bisogni reali. L’architettura organica non può mai essere semplicemente applicata dall’esterno.”
Dopo la mostra, Zevi pubblicò due monografie su Wright, contribuendo in modo determinante alla diffusione della sua opera in Italia negli anni ’50 e ’60. L’influenza di Wright sull’architettura della Costa Smeralda può essere analizzata anche attraverso le descrizioni di Zevi.
In Towards an Organic Architecture, Zevi sottolinea come il concetto urbanistico di Wright differisse da quello di Le Corbusier. Mentre Le Corbusier portava la natura nella città attraverso alti edifici circondati da spazi verdi, Wright spostava la città nella natura, grazie alla disponibilità universale dell’automobile nella sua idea progettuale. Questo approccio, basato sulla relazione tra edifici e mezzi di trasporto, è simile alla logica di integrazione topografica che caratterizza gli edifici della Costa Smeralda.
A livello architettonico, le somiglianze con Wright si fanno ancora più evidenti. Come già osservato nell’analisi dell’architettura della Costa Smeralda, la disposizione in pianta e in sezione sembra ispirarsi a Wright. La caratteristica peculiare dei suoi progetti è lo spostamento degli spazi, sia orizzontale che verticale, in risposta alle necessità degli abitanti, creando così una disposizione organica. I volumi interni si sviluppano progressivamente verso l’esterno, “aprendosi come piante”.
Il centro delle abitazioni di Wright era rappresentato dal focolare, mentre la logica interna dell’edificio si rifletteva anche nella sua forma esterna. Diversamente dalla rigidità stereometrica di Le Corbusier, le costruzioni di Wright sono formate da masse strutturali e volumi complessi che sembrano crescere naturalmente dalla loro struttura interna. Questa configurazione organica permette agli edifici di integrarsi armoniosamente con la natura circostante, adattandosi persino al terreno, come osservato in progetti emblematici come Fallingwater.
Zevi sottolinea anche come Wright utilizzi materiali locali per intere pareti, creando l’impressione che gli edifici emergano dalla terra stessa. Ad esempio, descrive la casa Pauson in Arizona come caratterizzata da una “continuità intima” con il suo ambiente naturale, contrapposta al contrasto tipico della modernità. Wright, secondo Zevi, concepisce la casa come un rifugio per l’umanità, una sorta di ritorno alla caverna, una visione che si rispecchia nelle idee di Jacques Couëlle, progettista di Cala di Volpe, riguardo all’abitazione ideale.(62. Jacques Couëlle afferma che l’architetto deve costruire per l’uomo una casa che sia come la tana per la volpe. Cfr. Vanno a nascondersi sulla Costa Smeralda, 1969).
Anche le modalità di rappresentazione condividono delle somiglianze. Le fotografie delle opere di Wright enfatizzano l’ambiente naturale, con elementi come alberi o arbusti in primo piano e l’edificio posizionato più lontano.(63. Una parte di queste fotografie è stata scattata dal fotografo Josué Ito nel 1966 e organizzata per temi come spiagge, folklore, Sa Conca, Pitrizza, paesaggio, Alisarda e night club. Gli altri fotografi che hanno documentato i primi anni della Costa Smeralda non sono noti).
Questo approccio è evidente nelle immagini di case come la Pauson e la Friedmann, pubblicate da Zevi nel 1954. La composizione di queste immagini trova un’eco nelle prime fotografie commissionate per la Costa Smeralda, come quelle del Pitrizza, che richiamano fortemente lo stile visivo delle pubblicazioni di Zevi su Wright.
Possibili modelli architettonici: Gaudí e Mendelsohn
Una caratteristica fondamentale che distingue l’architettura della Costa Smeralda dagli edifici di Wright è la morbidezza delle linee nei progetti in pianta e in sezione. L’architettura organica di Wright, sebbene “organica”, è formalmente rigida, con geometrie rigorosamente rettangolari o circolari. Le curve morbide e le superfici intonacate della Costa Smeralda trovano invece precedenti altrove prima degli anni Sessanta. Da un lato, esse derivano, come già descritto, dagli elementi tipici dell’architettura rurale del Sud Italia, come i trulli. Dall’altro, vi sono due architetti del periodo prebellico che hanno realizzato opere emblematiche in questo linguaggio formale: Erich Mendelsohn e Antoni Gaudí.
La Torre Einstein di Erich Mendelsohn, costruita nel 1921, presenta una somiglianza formale con le prime costruzioni della Costa Smeralda, in particolare quelle di Busiri-Vici. In Towards an Organic Architecture, Zevi critica il fatto che la logica del design esterno della torre sia una modellazione plastica arbitraria e simbolica delle funzioni interne, generando così un’atmosfera letteraria e mistica. Tuttavia, non è possibile stabilire con certezza se la Torre Einstein sia stata effettivamente una fonte d’ispirazione per il comitato architettonico della Costa Smeralda, sembrando piuttosto una casuale somiglianza formale nella storia dell’architettura.
Gli edifici di Antoni Gaudí, realizzati ancora prima, mostrano espressioni stilistiche simili alle prime opere del comitato architettonico. Tra le costruzioni più affini vi sono Casa Batlló e Casa Milà a Barcellona. Casa Batlló, completata nel 1906, si distingue per la plasticità della facciata, che richiama forme vegetali, e per riferimenti simbolici di natura animale: il tetto, ad esempio, evoca il corpo squamoso di un drago. Questo tipo di design “rettiliano” si ritrova anche nelle opere di Jacques e Savin Couëlle in Sardegna. Inoltre, il piano terra dell’Hotel Romazzino presenta somiglianze con la mansarda di Casa Batlló.
Casa Milà, terminata nel 1910, offre ulteriori parallelismi. La pianta dell’edificio, con le sue curve fluide, ricorda i progetti di pianta arrotondata della Costa Smeralda. Il tetto terrazzato di Casa Milà è un elemento progettuale essenziale per tutti e tre gli architetti coinvolti nella Costa Smeralda, e le strutture espressive del tetto di Gaudí possono essere paragonate ai camini, più piccoli ma ugualmente plastici, presenti in Sardegna.
Non esistono riferimenti documentati a Gaudí da parte del comitato architettonico della Costa Smeralda. Tuttavia, le somiglianze formali potrebbero essere derivate dagli stessi riferimenti comuni all’architettura rurale. Va notato, però, che Gaudí viene spesso citato come fonte d’ispirazione per Jacques Couëlle. Inoltre, l’uso di piastrelle colorate presso l’Hotel Cala di Volpe, un elemento distintivo delle opere di Gaudí, come in Casa Batlló, rende plausibile una connessione con il grande architetto catalano.
Paralleli con il Neorealismo
Il Neorealismo è il movimento stilistico più vicino, sia temporalmente che geograficamente, all’architettura della Costa Smeralda. Proprio per questo, Cappai ha utilizzato il Neorealismo come termine di confronto per una collocazione storica della Costa Smeralda, comparando i progetti turistici della corrente italiana del dopoguerra con il masterplan del Consorzio. Tuttavia, la sua analisi urbanistica non approfondisce il confronto con l’architettura specifica della Costa Smeralda, aspetto che sarà esaminato qui di seguito.
Sotto il profilo formale e volumetrico, vi sono sovrapposizioni tra il Neorealismo e la Costa Smeralda. Tuttavia, accanto alle similitudini fisiche emergono profonde divergenze nelle motivazioni sottostanti: politiche nel caso del Neorealismo, e ludiche e leggere nel caso della Costa Smeralda.
Il Neorealismo fu un movimento culturale italiano del dopoguerra che si manifestò come espressione costruita più di un decennio prima della Costa Smeralda. I suoi protagonisti, nel rigetto del fascismo e del suo peso ideologico, erano alla ricerca di un’identità italiana autentica e incontaminata, che riconoscevano nella vita rurale, considerata un elemento continuo e immutato attraverso i vari regimi. Secondo Gilles Deleuze, le origini del Neorealismo risiedono nel cinema italiano, in particolare nei primi film del dopoguerra che si ricollegavano a Ossessione di Visconti (1942), mettendo al centro la vita dell’uomo comune.
Il film Ossessione si svolge in una stazione di sosta rurale, una casa intonacata e semplice con un cortile prospiciente la strada. Il tetto a falde leggere, le persiane in legno e l’arco tra la casa principale e quella secondaria prefigurano non solo motivi architettonici neorealisti, ma anche elementi della Costa Smeralda. Durante il dopoguerra, il linguaggio razionale dell’architettura, associato al fascismo, venne abbandonato a favore di un’estetica rurale. Il Neorealismo rappresenta dunque non solo una rottura con l’architettura fascista, ma un distacco più ampio dalla tradizione razionalista dell’edilizia italiana prebellica, manifestando una sfiducia nei confronti del razionalismo illuminista della modernità.
Tuttavia, questa narrazione delle origini del Neorealismo omette il fatto che Mussolini stesso fosse un promotore dell’architettura rurale. Durante il suo regime, molti film italiani si concentrarono sulla vita rurale. Ad esempio, Acciaio (1933) tratta della vita degli operai dell’acciaio, ma include il mondo rurale come tema centrale. Analogamente, Sole (1929) racconta la bonifica di una zona paludosa a sud di Roma. Anche film di tematica bellica idealizzano il mondo rurale, come Camicia nera (1933), che intreccia il progresso industriale sotto Mussolini con la vita nelle campagne. La rappresentazione visiva di questi film anticipa, in parte, quella dei film neorealisti.
Mussolini promosse anche l’architettura rurale attraverso la creazione di città di fondazione in Sardegna, come Carbonia, Arborea e Fertilia, che incarnavano l’ideale di vita rurale. Questi insediamenti, dalle loro denominazioni alla pianificazione urbana fino ai dettagli architettonici, sono testimonianze concrete dello stile rurale. Arborea e Fertilia, in particolare, sorsero su terreni bonificati, come nel caso descritto nel film Sole.
La ricerca di ispirazioni da parte del Neorealismo evidenzia così come il ritorno all’architettura rurale fosse un fenomeno ampiamente diffuso nella società dell’epoca.
Per il movimento architettonico del Neorealismo, il Manuale dell’Architetto di Mario Ridolfi, pubblicato nel 1946, rappresenta una pietra miliare. Pensato come un manuale per la ricostruzione degli edifici distrutti, offre una raccolta di elementi tradizionali destinati all’uso degli architetti progettisti. Manfredo Tafuri lo definì un “esperanto vernacolare”, una sorta di linguaggio architettonico comune basato sulla tradizione. Anche per il Consorzio Costa Smeralda si può riscontrare l’uso di un linguaggio simile, come mostrato nelle sezioni 2.2 e 2.6.
Dopo che il manuale entrò a far parte del discorso architettonico in Italia, il presidente di INA-CASA affidò a Mario Ridolfi il compito di redigere le normative per l’ente. Nell’ambito di questo programma di ricostruzione, prese forma quello che Tafuri definisce il “manifesto” del Neorealismo: il Quartiere Tiburtino. Questo progetto, coordinato da Ridolfi e Quaroni, segnò l’inizio di uno studio sulle regole compositive per i nuovi quartieri residenziali. Si abbandonarono l’orientamento sud della modernità e si misero in discussione gli edifici a blocco lineare tipici dell’epoca prebellica. Nonostante ciò, il Tiburtino rimase organizzato in edifici a blocchi lineari, circondati da aree verdi, mantenendo così una connessione urbanistica con la modernità. Tuttavia, grazie alle trasformazioni sia nella disposizione sia nell’architettura, il quartiere rappresenta anche l’espressione di una nuova epoca.
Tafuri descrive il Tiburtino come un luogo indefinito: né città, né periferia, né villaggio. Allo stesso modo, in Costa Smeralda si trovano insiemi di edifici urbanisticamente organizzati in maniera simile, come nel caso di La Dolce Sposa di Vietti degli anni ’80. Tuttavia, i primi edifici del territorio erano concepiti più come nuclei isolati che come blocchi lineari. I basamenti in pietra naturale del Tiburtino, che formano una sorta di paesaggio a gradini lungo i blocchi, richiamano le scalinate e i porticati della Costa Smeralda, come a Sa Conca di Busiri-Vici.
Costruttivamente e formalmente, il Tiburtino utilizza elementi tradizionali delle zone rurali di Roma, come l’introduzione di un artigianato formalizzato o la torsione e lo spostamento dei volumi, che conferiscono agli edifici l’aspetto di una struttura cresciuta organicamente, anziché di un complesso uniforme di nuova costruzione. Tuttavia, a differenza della Costa Smeralda, il Tiburtino non rappresenta l’ideale perfetto di un sogno ricercato, ma riflette piuttosto una realtà complessa e contraddittoria. Tafuri sottolinea come gli elementi rurali siano applicati al Tiburtino solo in forme deformate e distorte.
Un approccio simile si ritrova anche in altri progetti di Mario Ridolfi, uno dei protagonisti del Neorealismo. Le sue opere più iconiche sono le costruzioni a torre, come le Torri in Viale Etiopia a Roma (1952), il Quartiere INA-Casa a Napoli (1956) e il già citato Quartiere Tiburtino (1951). Questi edifici, pur essendo molto più densi rispetto a quelli della Costa Smeralda, condividono con il progetto sardo l’integrazione con il verde circostante e l’uso di elementi vernacolari.
Ancora più evidente è il parallelismo nell’attenzione per la piccola scala. Come osserva Oliver Martin descrivendo l’architettura del Neorealismo, vi è una costante ricerca di un “parametro umano” che si manifesta nell’interesse per i dettagli e per strutture piccole, irregolari e individualizzate. Questo approccio è riscontrabile anche nelle prime opere del comitato architettonico della Costa Smeralda.
Anche i progetti di Ridolfi, grazie alla loro collocazione nel verde circostante e alla reintroduzione di elementi vernacolari, mostrano delle somiglianze con il progetto sardo. Questa affinità si nota ancora di più nell’attenzione verso le strutture a scala ridotta. Come ha osservato Oliver Martin parlando dell’architettura neorealista, emerge un chiaro richiamo alla dimensione umana, evidente nella cura per i dettagli e nella preferenza per composizioni spaziali frammentate e irregolari. Questo approccio è presente anche nelle prime opere del comitato architettonico.
L’architettura neorealista si distingue per alcuni aspetti fondamentali che trovano eco nello stile della Costa Smeralda: parte da una concezione moderna, ma la trasforma attraverso rotture nella struttura principale, reintroduce elementi tipici dell’architettura locale e aggiunge dettagli artigianali. Un esempio che illustra bene questo processo è il Rifugio Pirovano di Albini e Colombini, costruito a Cervinia nel 1952. Situato in montagna, questo edificio rappresenta una sorta di versione alpina delle seconde case progettate dal comitato per la costa. La sua struttura si basa su tre livelli sfalsati e regolari, con un profilo che richiama i tetti industriali a shed. Tuttavia, questi tratti moderni vengono interrotti da dettagli più tradizionali, come il balcone che si sviluppa sopra i primi tre piani e il quarto livello caratterizzato da aperture verticali con persiane in legno. Ancora, quattro colonne imponenti attraversano i piani inferiori, dando loro l’aspetto di un basamento su cui poggia il piano superiore in stile più vernacolare. Elementi tipici come il tetto a due falde e dettagli artigianali, come le giunzioni delle travi in legno o le colonne in pietra naturale, completano questa sintesi tra tradizione e modernità.
Anche alla Costa Smeralda si ritrovano motivi architettonici simili, ma qui l’obiettivo era realizzare un ideale, mentre nel Neorealismo si tende a usare elementi tradizionali in modo volutamente frammentato o scenografico. Nonostante ciò, entrambe le correnti condividono un interesse per il dialogo tra architettura locale e contesto moderno, anche se con intenti diversi: nel Neorealismo l’integrazione della tradizione avviene in modo concettuale e riflessivo, mentre alla Costa Smeralda prevale un approccio più estetico.
Infine, sebbene il Neorealismo abbia una chiara matrice politica, questa appare difficilmente conciliabile con gli obiettivi degli architetti della Costa Smeralda, più orientati verso la creazione di un ambiente armonico e idealizzato. Tuttavia, guardando più da vicino, emergono delle somiglianze: se il Neorealismo dialoga con la storia italiana, la Costa Smeralda cerca di costruire un mondo quasi incontaminato, dove l’uomo possa vivere in equilibrio con la natura. Le motivazioni sono diverse, ma le aspirazioni architettoniche trovano un terreno comune.
Prossima generazione – «Architettura senza architetti»
Il punto comune tra il progetto in Sardegna e il Neorealismo è la creazione di un ambiente rurale per persone che vivono in realtà uno stile di vita urbano. L’architettura rurale non solo collega queste due diverse correnti del dopoguerra italiano, ma rappresenta anche un aspetto del più ampio spirito del tempo in Europa.
Nel novembre 1964, mentre i primi edifici della Costa Smeralda venivano completati, il Museum of Modern Art di New York inaugurava la mostra «Architecture without Architects», curata dall’architetto viennese Bernhard Rudofsky. Questa mostra, insieme alla pubblicazione omonima, divenne una fonte d’ispirazione per gli architetti europei e influenzò profondamente la generazione successiva. A dimostrazione del fatto che lo spirito del tempo internazionale veniva condiviso da diversi movimenti, nel libro appare anche il nome di Gio Ponti, il quale, secondo Rudofsky, aveva fornito indicazioni su edifici italiani. Proprio come l’architettura anonima e mediterranea era parte del patrimonio creativo di Ponti, così il concetto di Rudofsky di un’architettura vicina alla natura ispirò gli architetti della generazione post-1968.
Nel suo prologo, Rudofsky celebra l’autenticità dell’architettura anonima, spesso rurale. Per sostenere la sua tesi, cita sia la Bibbia – con la città di Enoch (Genesi IV: 17) descritta come una «città per una sola famiglia» – sia Darwin, che osservò un impulso a costruire persino nei primati. Rudofsky sostiene che l’architettura precede persino l’umanità stessa: le formazioni rocciose e le grotte modellate da vento e acqua, con le loro forme eleganti, sono già architettura. Come esempio di luoghi in cui «la natura è stata architetto», cita il paesaggio carsico della «Ciudad Encantada», a est di Madrid.
Attraverso la sua mostra e il suo libro, Rudofsky legittima l’utilizzo di formazioni rocciose antiche – come i graniti della Costa Smeralda – nell’architettura contemporanea. Egli sottolinea anche la scelta del luogo abitativo come espressione della libertà umana: spesso questa scelta non è dettata solo dall’utilità, ma anche dalla bellezza del territorio. A sostegno della sua idea, cita il villaggio greco di Phira, una descrizione che si adatta perfettamente anche alla Costa Smeralda contemporanea.
Sul concetto di Stile Costa Smeralda
Come evidenziato in precedenza, il comitato architettonico della Costa Smeralda aveva l’obiettivo di sviluppare un linguaggio stilistico condiviso per l’architettura della zona. Dopo aver analizzato il contesto temporale, è opportuno concludere con una riflessione sul nome Stile Costa Smeralda.
Questo stile è stato descritto in modi diversi nel corso del tempo, tra cui Stile Costa Smeralda, stile “neosardo” o “neomediterraneo”. Una delle principali influenze sulla classificazione è stata quella del geografo Cedric Price, che negli anni ’80 ha condotto uno studio sull’intera costa della Sardegna. Price è stato il primo a proporre una categorizzazione stilistica dell’architettura della Costa Smeralda, che viene spesso utilizzata ancora oggi come riferimento principale. Tuttavia, in quanto geografo, la sua analisi si è concentrata principalmente sugli aspetti esterni degli edifici, individuando tre principali categorie stilistiche: “nuragico”, “neomediterraneo” e “neosardo”.(82. Lo stile “naturale” o “nuragico” utilizza muri in granito e coperture vegetali, mentre lo stile “neomediterraneo” è caratterizzato principalmente dall’intonaco bianco grezzo. Lo stile “neosardo” si distingue per il trattamento scultoreo di edifici che altrimenti sembrano tradizionali. L’architettura dell’Hotel Pitrizza è descritta come “naturale” o “nuragica”. Entrambi gli elementi sono certamente leggibili nella composizione di Vietti. L’integrazione nella natura è evidente, e si può anche identificare un riferimento visivo ai nuraghi, costruiti in granito con tecnica a secco per formare torri circolari. Tuttavia, l’indecisione espressa nell’uso di due definizioni per una sola corrente stilistica dimostra che le distinzioni sono state fatte in modo eccessivamente dettagliato. Cfr. Price, p. 231).
Queste definizioni, però, risultano troppo generiche e la divisione in tre stili distinti è fonte di ambiguità. Ad esempio, secondo Price, l’architettura delle ville di Vietti rientrerebbe nello stile “neomediterraneo”, mentre il suo Hotel Pitrizza sarebbe classificato come “nuragico”. Questa distinzione, che assegna allo stesso architetto due stili diversi per opere costruite nello stesso periodo e nella stessa area, appare più confusa che chiarificatrice. Inoltre, le tre categorie individuate da Price si sovrappongono con le opere dei tre principali architetti coinvolti nella Costa Smeralda. Le opere di Vietti, ad esempio, sarebbero distribuite tra tutti e tre gli stili: il Pitrizza definito “nuragico”, Porto Cervo “neosardo” e le sue ville “neomediterranee”. Alla categoria “neomediterranea”, caratterizzata da edifici intonacati di bianco, apparterrebbero non solo le ville di Vietti ma anche quelle di Busiri-Vici. Allo “stile neosardo”, invece, andrebbero attribuiti edifici di Couëlle e Vietti.
Questa sovrapposizione rende evidente come sia inappropriato creare uno stile basandosi su un singolo edificio, come nel caso del Pitrizza.
Al contrario di Price, questa ricerca propone di considerare l’architettura della Costa Smeralda come parte di un unico stile coerente. La decisione di denominare lo stile dal luogo in cui è stato creato è motivata da ragioni sia pragmatiche che logiche. Di conseguenza, come accade ormai comunemente, in questo studio il linguaggio architettonico sviluppato viene chiamato semplicemente “Stile Costa Smeralda”.
A. La casa Pauson potrebbe anche essere stata un modello fotografico per la documentazione sulla Costa Smeralda. (Zevi 1954, p. 145)
B. L’Hotel Pitrizza presenta analogie con la Casa Friedmann di Frank Lloyd Wright per quanto riguarda l’aspetto e il tipo di fotografia. (Zevi 1954, p. 155)
C. L’Hotel Pitrizza fotografato nel 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. L’architettura rurale fa da sfondo a molti film del Neorealismo. Qui una scena tratta dal film Ossessione di Visconti del 1942.
B. A Porto Cervo, si ritrovano motivi dell’architettura rurale dei film del Neorealismo, come ad esempio in Ossessione. Foto degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
C. Anche nei filmati su Mussolini viene idealizzata la vita rurale e l’architettura corrispondente viene messa in scena. Qui una scena tratta da Camicia nera del 1933.
A. Gli insediamenti in Costa Smeralda sono per lo più edifici singoli piuttosto che a schiera. Fa eccezione “La Dolce Sposa” degli anni ’80 di Vietti, che si basa su principi organizzativi simili a quelli del Tiburtino. (Archivio Enzo Satta)
B. A titolo di confronto, la pianta del quartiere residenziale Tiburtino di Quaroni e Ridolfi del 1950.
C. Alcuni elementi architettonici del Tiburtino, come lo zoccolo che forma anche una scala, si ritrovano pure in Costa Smeralda. (Tafuri 2002, fig. 8)
La torre di Einstein di Mendelsohn è citata in Towards an Organic Architecture come prodotto di una ricerca formale autonoma. (Zevi 1949, pagina delle illustrazioni XII)
A. La casa Batlló di Gaudí ha linee morbide in pianta e in sezione. Il tetto potrebbe essere stato un riferimento per i Couëlles. (Moravanszky 1985, p. 38)
B. La pianta della casa Milà di Gaudí è simile a quelle della Costa Smeralda, in particolare a quelle di Porto Cervo. Si veda anche il capitolo 3 su Porto Cervo (Moravanszky 1985, p. 41).
C. Il sottotetto di casa Milà ricorda le stanze di Romazzino dell’architetto Busiri-Vici. (Moravanszky 1985, p. 42)
A. La casa Batlló di Gaudí ha linee morbide in pianta e in sezione. Il tetto potrebbe essere stato un riferimento per i Couëlles. (Moravanszky 1985, p. 38)
B. La pianta della casa Milà di Gaudí è simile a quelle della Costa Smeralda, in particolare a quelle di Porto Cervo. Si veda anche il capitolo 3 su Porto Cervo (Moravanszky 1985, p. 41).
C. Il sottotetto di casa Milà ricorda le stanze di Romazzino dell’architetto Busiri-Vici. (Moravanszky 1985, p. 42)
A. Rudofsky afferma che la natura ha creato anche l’architettura; tra l’altro, cita l’esempio delle rocce calcaree modellate dal vento e dagli agenti atmosferici e mostra le immagini della “Ciudad Encantada” a est di Madrid. (Rudofsky 1964, fig. 19)
B. Il villaggio di Phira serve a Rudofsky come esempio di come la libera scelta di dove vivere sia una manifestazione della libertà umana. (Rudofsky 1964, fig. 31).
10. Atlante degli elementi costruttivi
In precedenza sono stati descritti i progetti chiave dei tre principali architetti della Costa Smeralda, mettendo in evidenza le loro similitudini e collocandoli nel contesto storico. Questi elementi architettonici condivisi saranno ora allegati in modo visivo.
10.1 Insediamento e volumetria
Topografia dell’edificio.
L’edificio stesso forma una topografia accessibile
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici Riferimento: Concetto generale del paesaggio
Nella Roccia e Fauna
Le costruzioni si sviluppano attorno e in armonia con le particolari formazioni naturali preesistenti.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
Norma edilizia: Il tipo di costruzione nasce dalla conservazione delle formazioni naturali.
A. Volumi sfalsati
I singoli ambienti sono spesso disposti in modo sfalsato sia in pianta che in sezione.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
Norma edilizia: L’evitare forme rigide di grandi dimensioni porta alla creazione di questo tipo di pianta.
B. Muri di granito come confini
I lotti e, se necessario, gli spazi stradali sono fiancheggiati da muretti a secco realizzati con pietre di granito sbozzate grezzamente.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici Riferimento: Stile costruttivo tradizionale sardo
Regola costruttiva: il muro in granito è quello consentito, meno consigliato il muro intonacato.
10.2 Elementi costruttivi
A. Basamento in granito
La base in granito è solitamente posta frontalmente, ma può anche far parte della struttura portante; l’estremità superiore della zona della base è spesso disegnata secondo una linea “artistica” libera;
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Costruzioni tradizionali sarde e concezione generale del paesaggio.
B. Terrazze
Le terrazze rappresentano estensioni degli edifici e li ancorano al terreno. Tutte le terrazze sono pavimentate con piastrelle in terracotta della Cerasarda.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale di una vita rurale e concetto generale del paesaggio.
C. Elementi circolari in granito
Architetti: Principalmente Vietti e Couëlle, raramente Busiri-Vici
Riferimento: Antichi nuraghi sardi
A. Forma organica delle piscine
Inizialmente, le piscine venivano costruite esclusivamente con forme organiche, forse ispirate a tendenze provenienti dagli Stati Uniti.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
B. Archi scultorei
Archi non perpendicolari e spesso orientati in più direzioni non ortogonali anche in pianta.
Architetti: Principalmente Couëlle; raramente Busiri-Vici (nelle abitazioni) e Vietti (a Porto Cervo)
Riferimento: Concetto generale di vita rurale e concetto generale del paesaggio
C. Spazi simili a grotte
Architetti: Soprattutto Couëlle, raramente Busiri-Vici (in edifici residenziali), Vietti (a Porto Cervo)
Riferimento: Stile costruttivo tradizionale sardo e concezione generale del paesaggio
A. Tronchi non lavorati
Tutte le ringhiere, sia interne che esterne, sono state realizzate con legno naturale.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
B. Fila di mattoni a sbalzo
Costruita in variazioni che vanno da una a tre file di mattoni sporgenti.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Tradizionale tecnica costruttiva sarda
C. Cancello in legno / indirizzo su pietra di granito
Organizzazione classica dell’ingresso all’edificio dal lato della strada e scritte dell’indirizzo su pietre di granito.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici Riferimento: Tradizione costruttiva sarda e concetto generale di architettura rurale – concetto generale del paesaggio.
A. Pergola
Sempre realizzata con rami non levigati, spesso anche incassata nei muri.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Tradizionale tecnica costruttiva sarda e concetto generale del paesaggio
B. Tetto calpestabile
I tetti calpestabili si trovano sempre accanto o tra tetti inclinati in tegole e sono sempre pavimentati con piastrelle in terracotta della Cerasarda.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
C. Loggia / Galleria con file di archi
Può essere a uno o più piani.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Presumibilmente ispirata alla tradizionale tecnica costruttiva sarda
Norma edilizia: Non direttamente specificata, ma il motivo è coerente con lo stile mediterraneo.
A. Soffitto con travi in legno
Può essere portante e rivestito con canne, oppure installato sotto il soffitto portante per creare un’atmosfera più calda e accogliente.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Tradizionale tecnica costruttiva sarda
A. Rocce di granito erose dagli agenti atmosferici
Integrate come elementi decorativi di pregio, sia negli spazi esterni che interni degli edifici.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
B. Rinforzi murari
Per lo più agli angoli, non necessari dal punto di vista strutturale, ma progettati per ancorare visivamente l’edificio al territorio.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
C. Camini espressivi
Nelle prime costruzioni erano costituiti principalmente da due mattoni posizionati diagonalmente sopra il camino, spesso intonacati.
Architetti: Principalmente Vietti e Couëlle, raramente Busiri-Vici
Riferimento: Tradizione costruttiva sarda
A. Strutture coperte
Tutti gli edifici tecnici, anche i più piccoli, sono stati integrati nei muri o, se indipendenti, intonacati e coperti con tegole.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
Norma edilizia: Gli edifici tecnici dovevano essere sottoposti all’approvazione del comitato architettonico; molto probabilmente i tetti in tegole erano una norma obbligatoria.
B. Strati multipli di vernice
Per creare l’impressione di un edificio antico, sono stati applicati vari strati di colori sovrapposti sulle facciate.
Architetti: Couëlle; in alcuni casi Vietti (a Porto Cervo); Busiri-Vici in modo limitato (a Sa Conca).
Riferimento: Tradizione costruttiva sarda e concetto generale del paesaggio
Norma edilizia: I colori accesi dovevano essere evitati, così come il bianco, che tuttavia è stato spesso utilizzato nei primi anni.
10.3 Dettagli
A. Rocce di granito erose dagli agenti atmosferici
Integrate come elementi decorativi di pregio, sia negli spazi esterni che interni degli edifici.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
B. Rinforzi murari
Per lo più agli angoli, non necessari dal punto di vista strutturale, ma progettati per ancorare visivamente l’edificio al territorio.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
C. Camini espressivi
Nelle prime costruzioni erano costituiti principalmente da due mattoni posizionati diagonalmente sopra il camino, spesso intonacati.
Architetti: Principalmente Vietti e Couëlle, raramente Busiri-Vici
Riferimento: Tradizione costruttiva sarda
A. Strutture coperte
Tutti gli edifici tecnici, anche i più piccoli, sono stati integrati nei muri o, se indipendenti, intonacati e coperti con tegole.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
Norma edilizia: Gli edifici tecnici dovevano essere sottoposti all’approvazione del comitato architettonico; molto probabilmente i tetti in tegole erano una norma obbligatoria.
B. Strati multipli di vernice
Per creare l’impressione di un edificio antico, sono stati applicati vari strati di colori sovrapposti sulle facciate.
Architetti: Couëlle; in alcuni casi Vietti (a Porto Cervo); Busiri-Vici in modo limitato (a Sa Conca).
Riferimento: Tradizione costruttiva sarda e concetto generale del paesaggio
Norma edilizia: I colori accesi dovevano essere evitati, così come il bianco, che tuttavia è stato spesso utilizzato nei primi anni.
A. Tronchi non lavorati
Tutte le ringhiere, sia interne che esterne, sono state realizzate con legno naturale.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Concetto generale del paesaggio
B. Fila di mattoni a sbalzo
Costruita in variazioni che vanno da una a tre file di mattoni sporgenti.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici
Riferimento: Tradizionale tecnica costruttiva sarda
C. Cancello in legno / indirizzo su pietra di granito
Organizzazione classica dell’ingresso all’edificio dal lato della strada e scritte dell’indirizzo su pietre di granito.
Architetti: Vietti, Couëlle, Busiri-Vici Riferimento: Tradizione costruttiva sarda e concetto generale di architettura rurale – concetto generale del paesaggio.