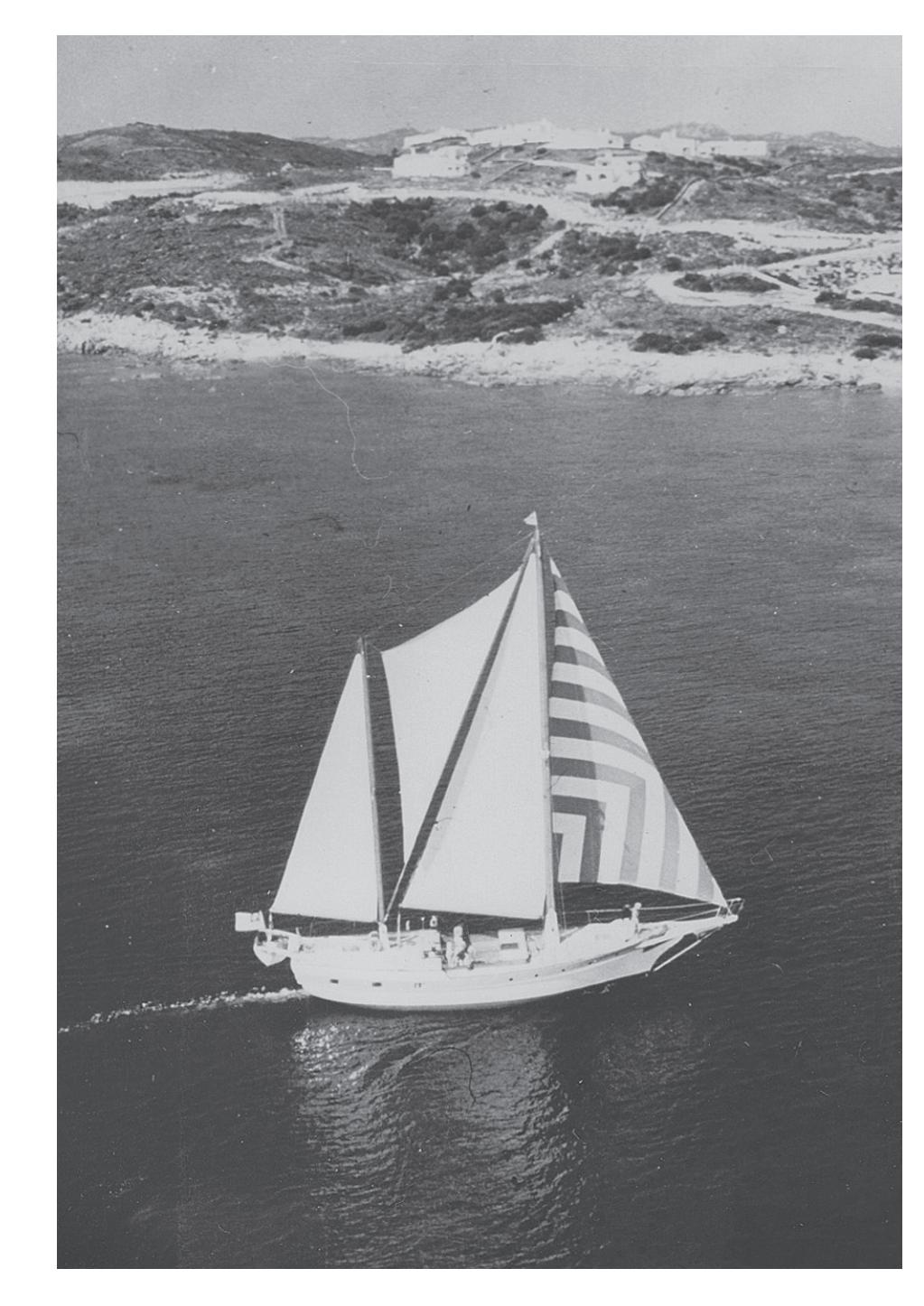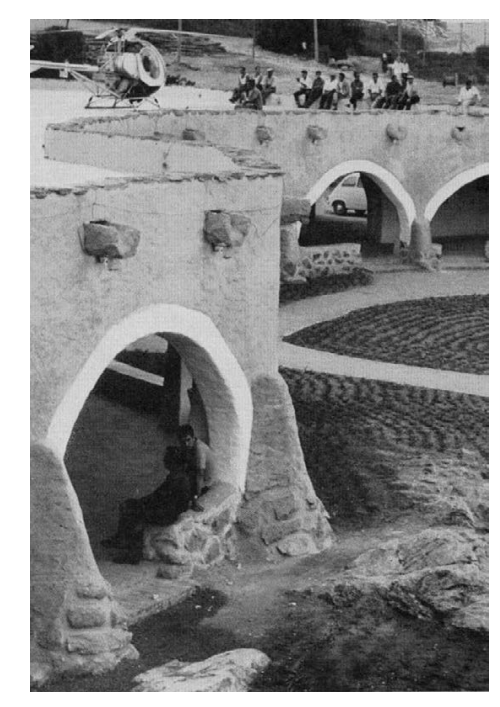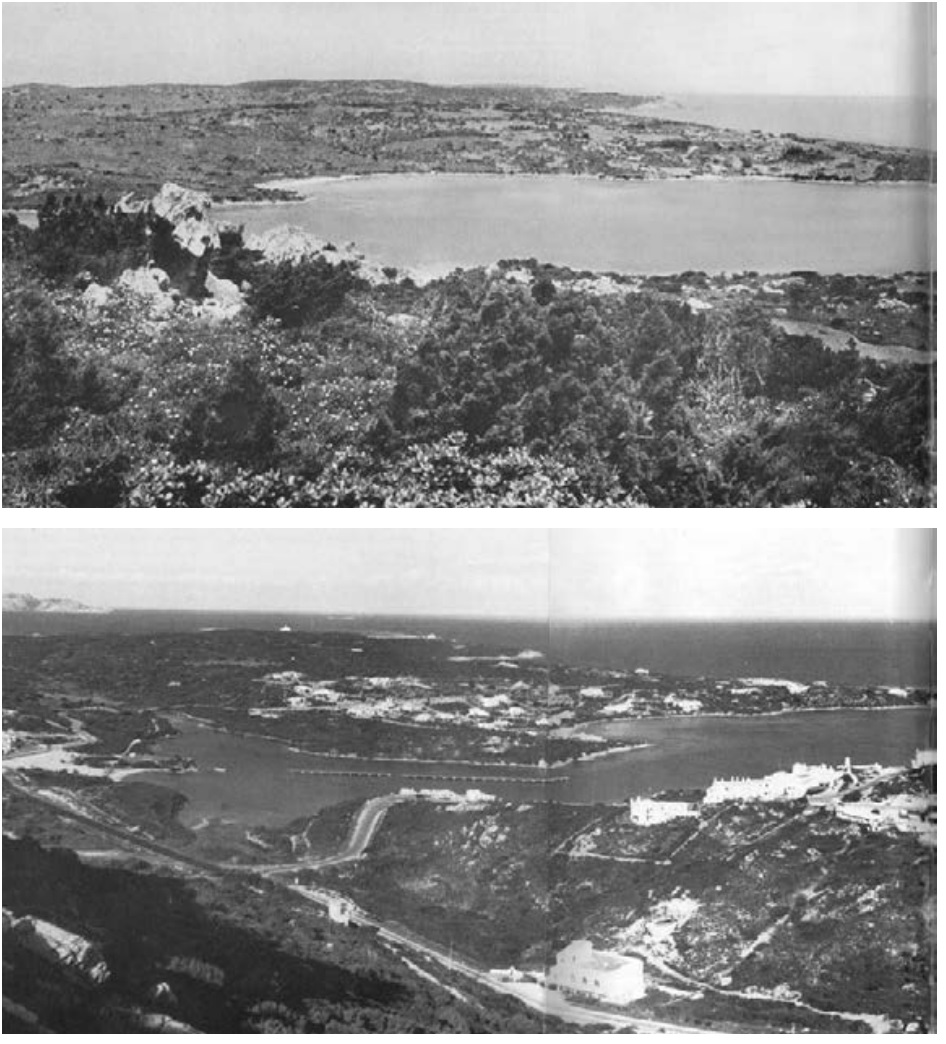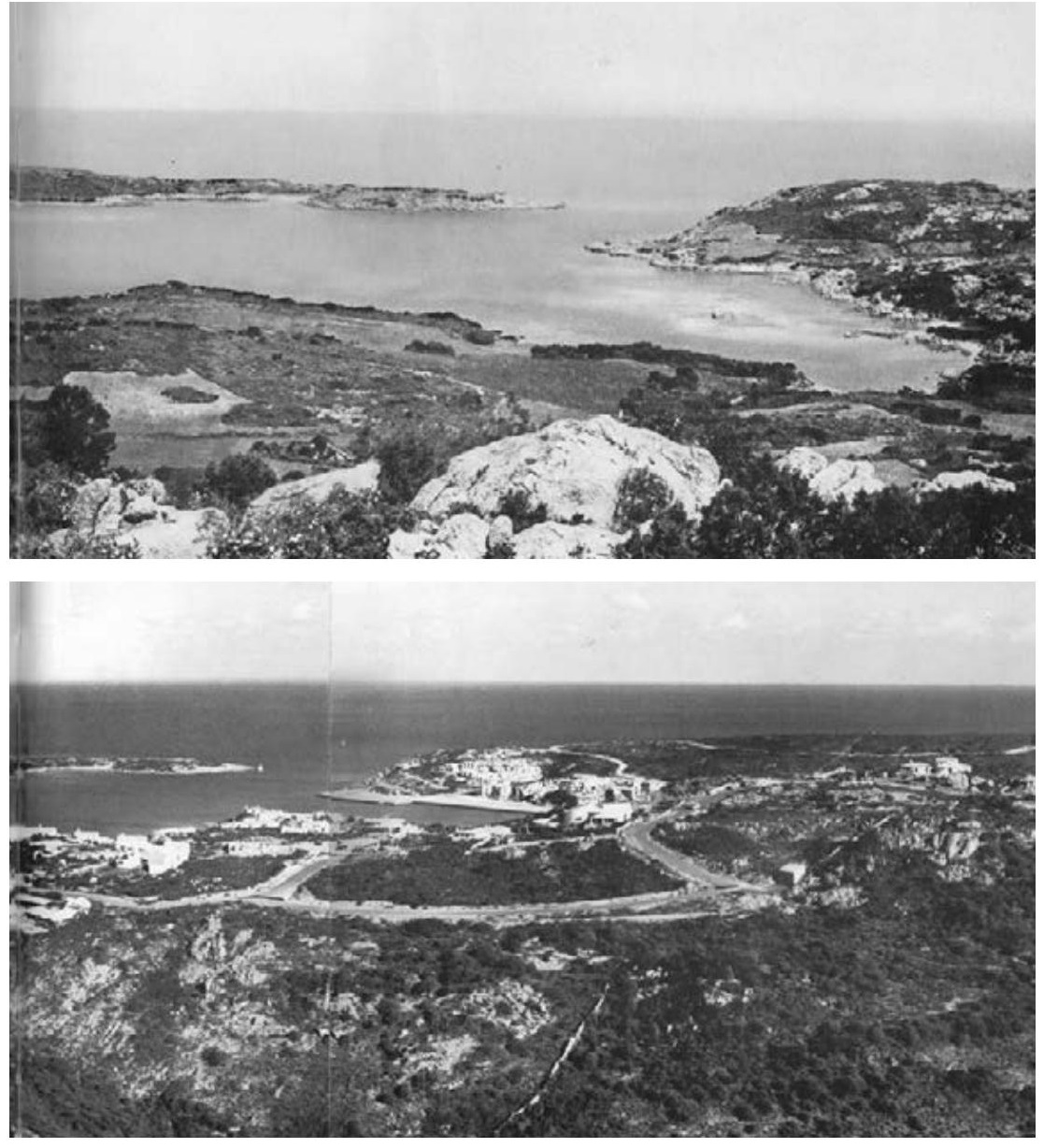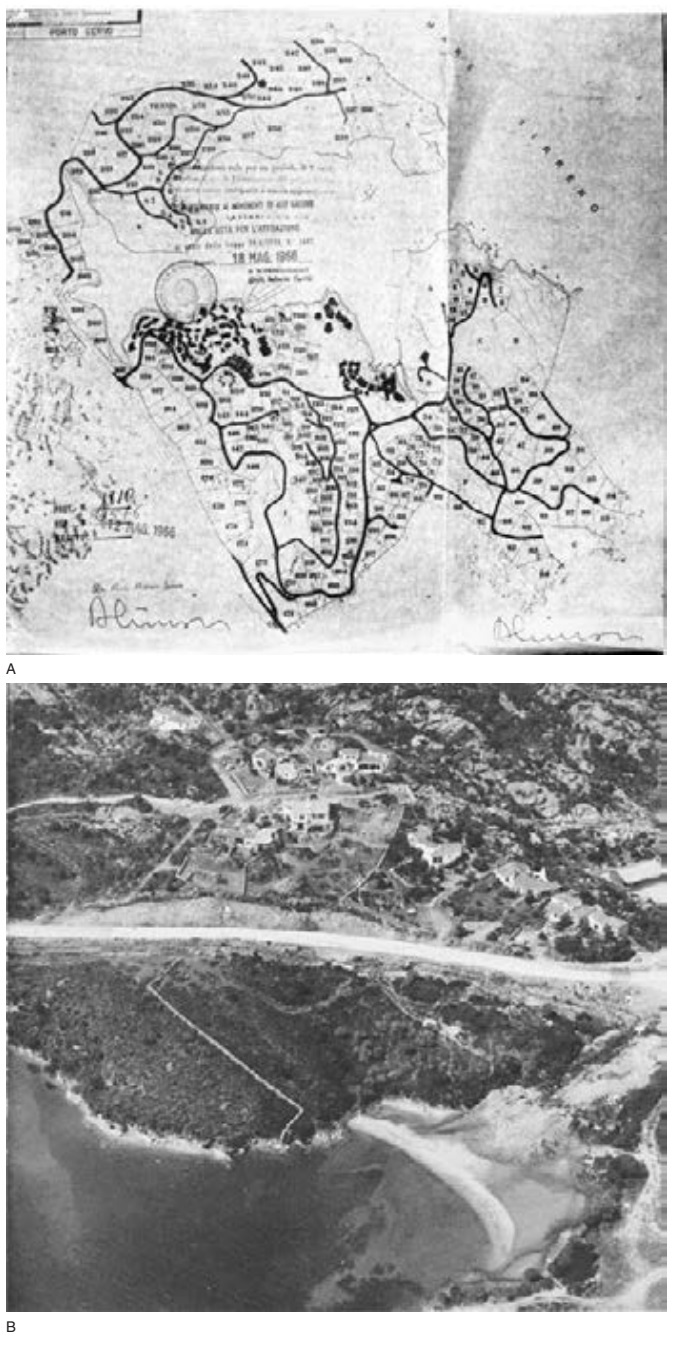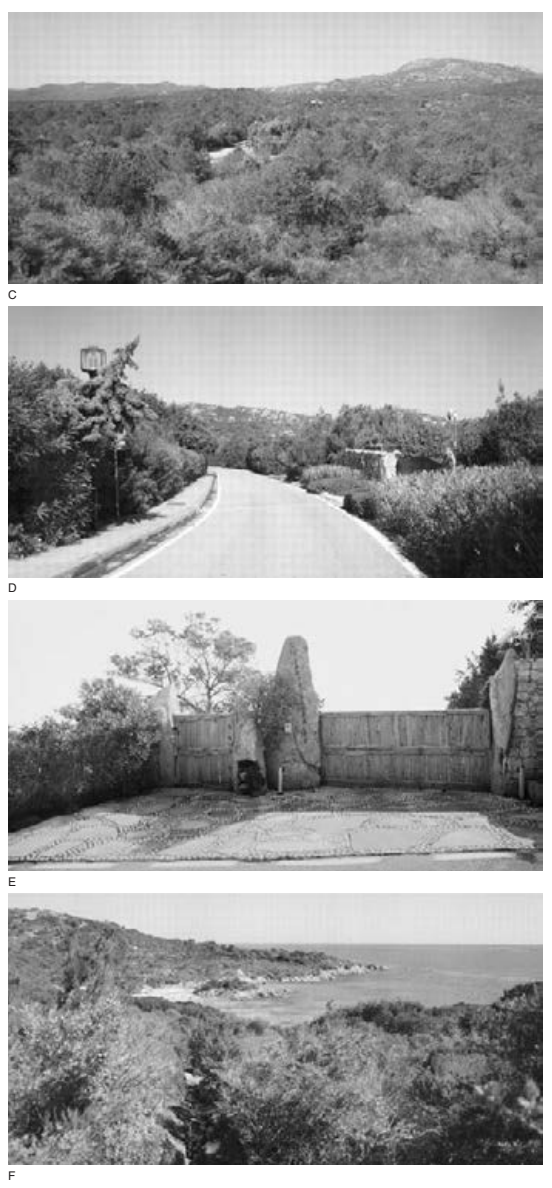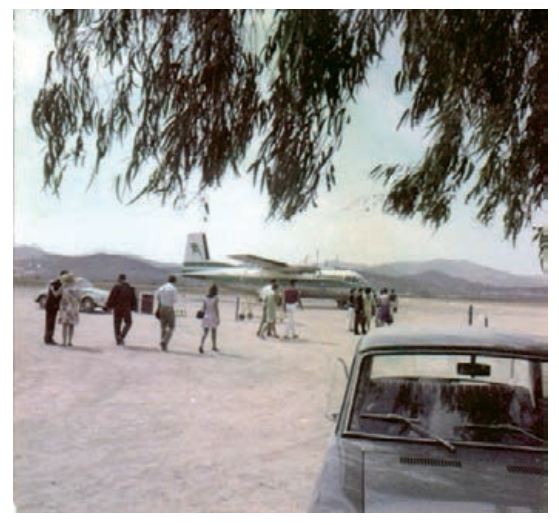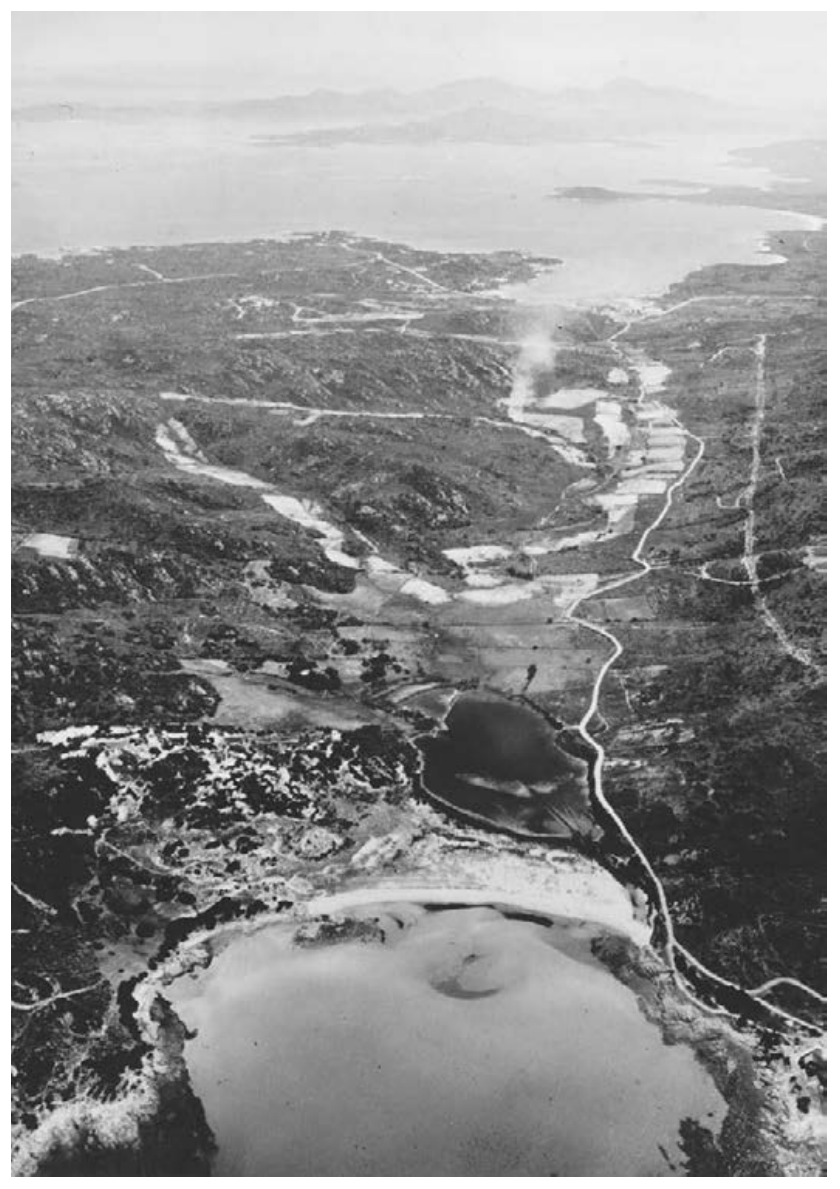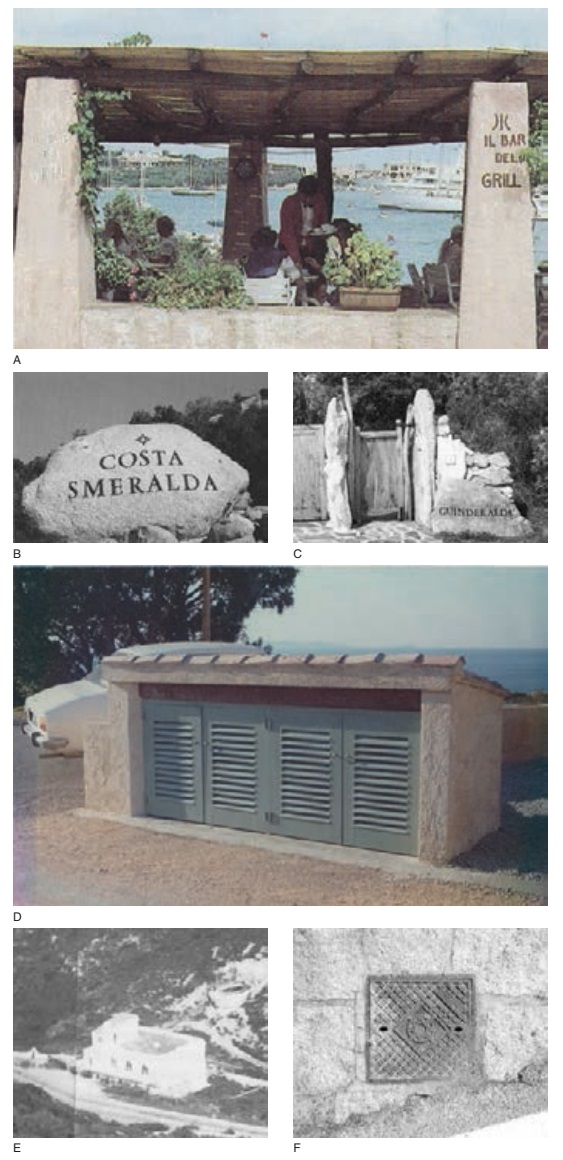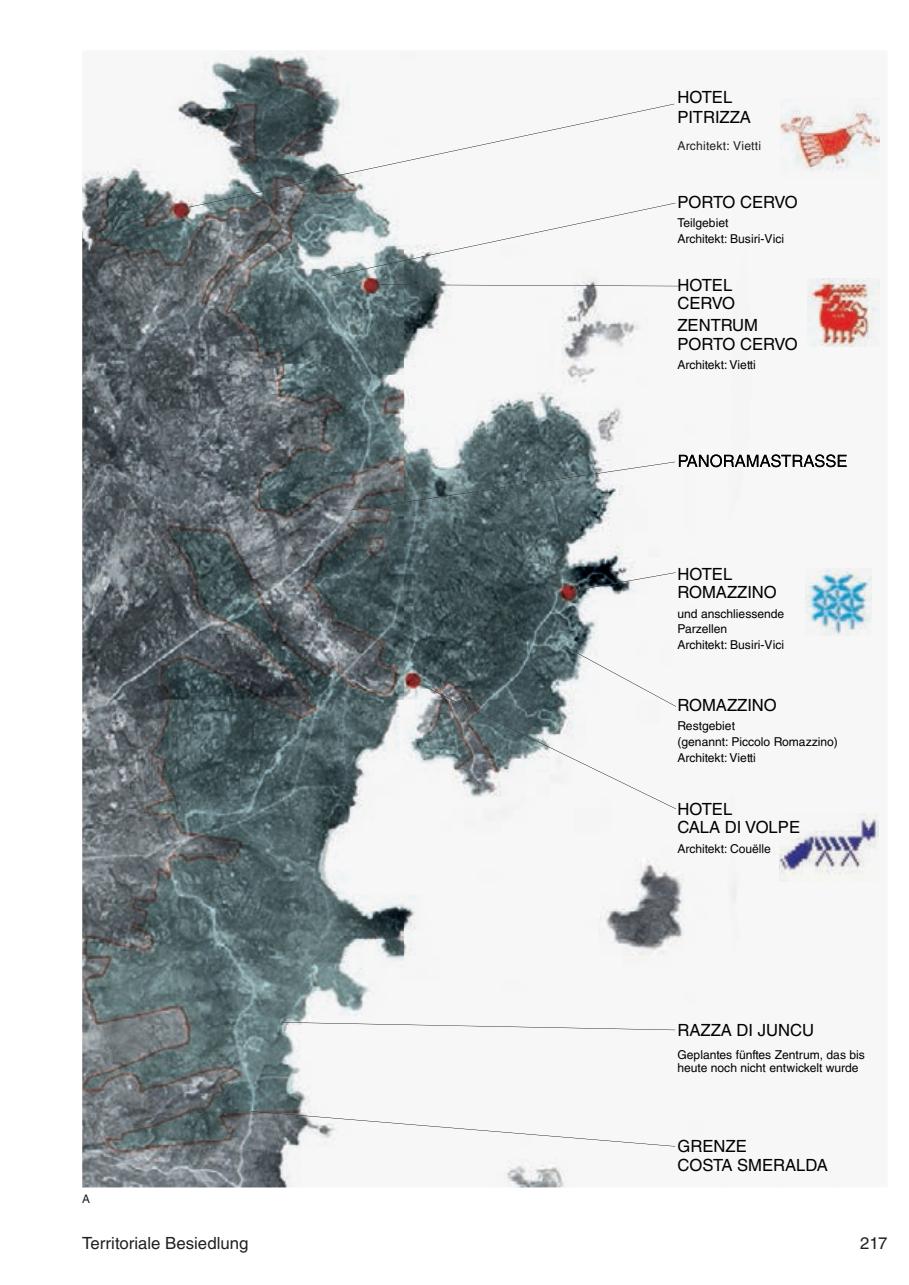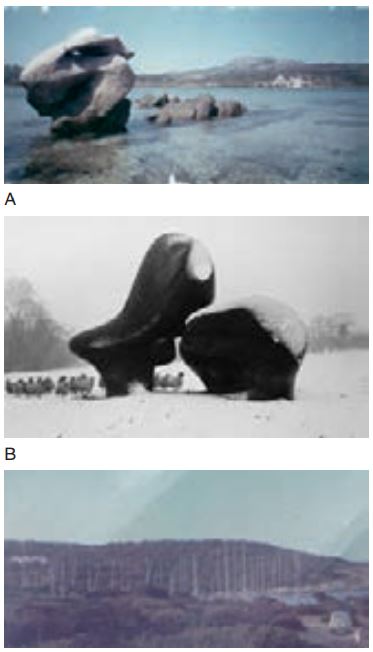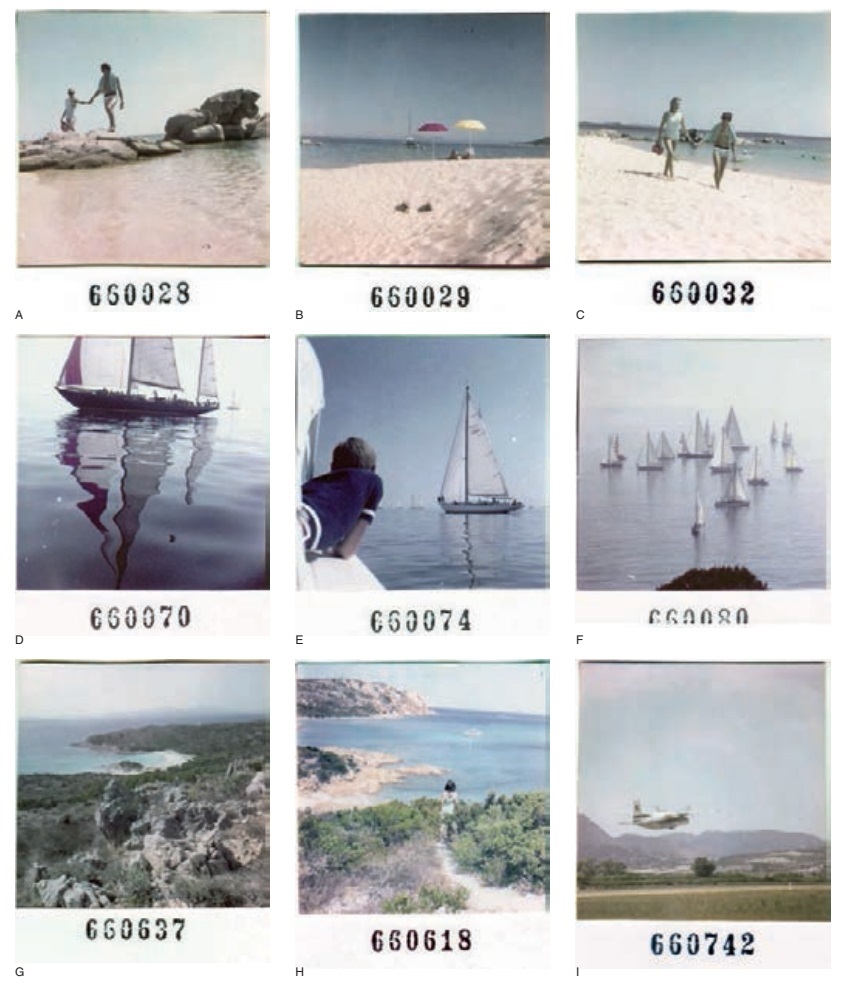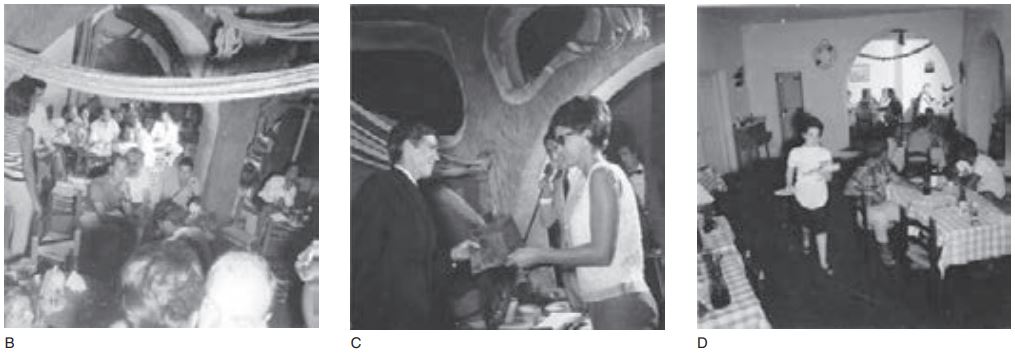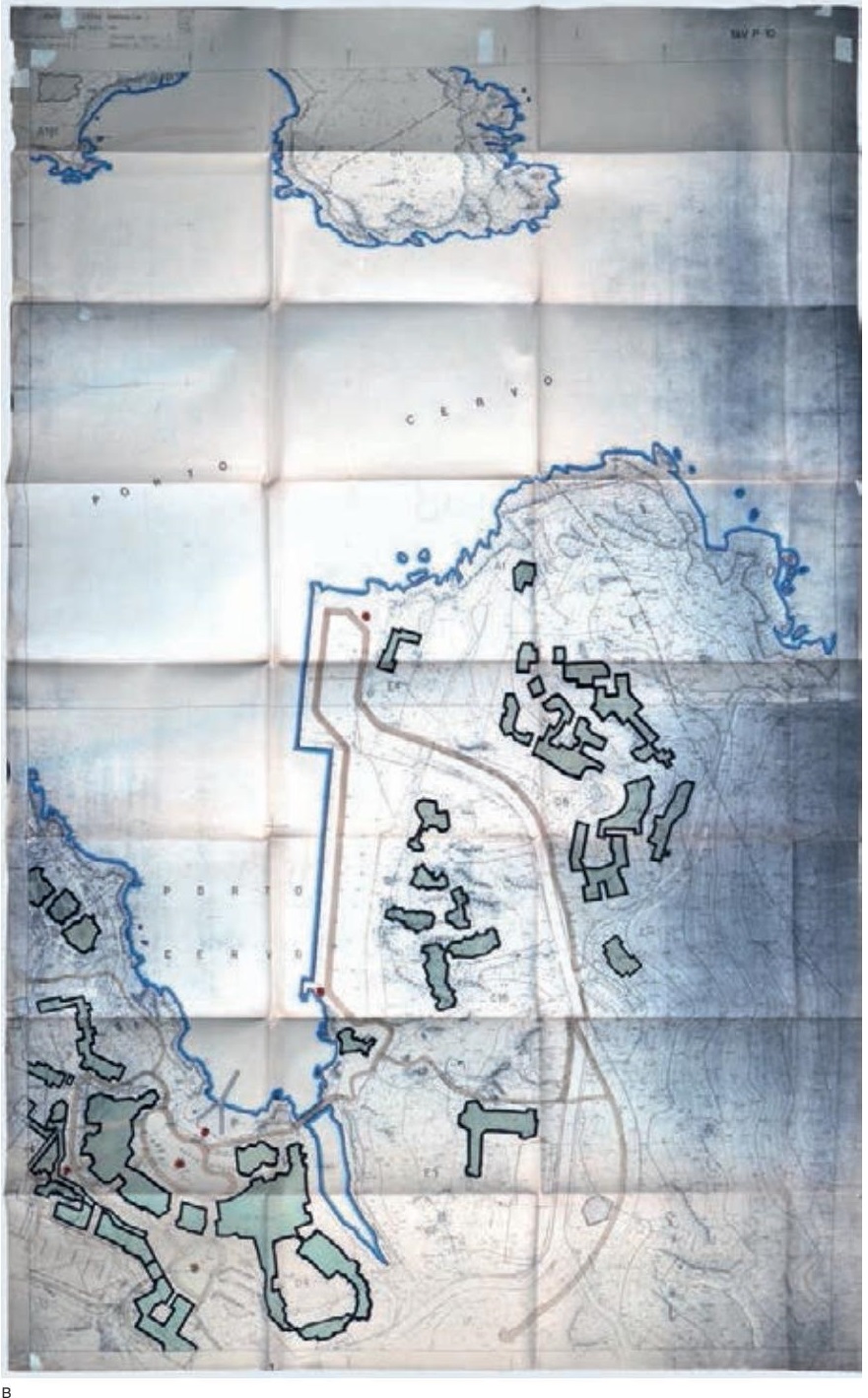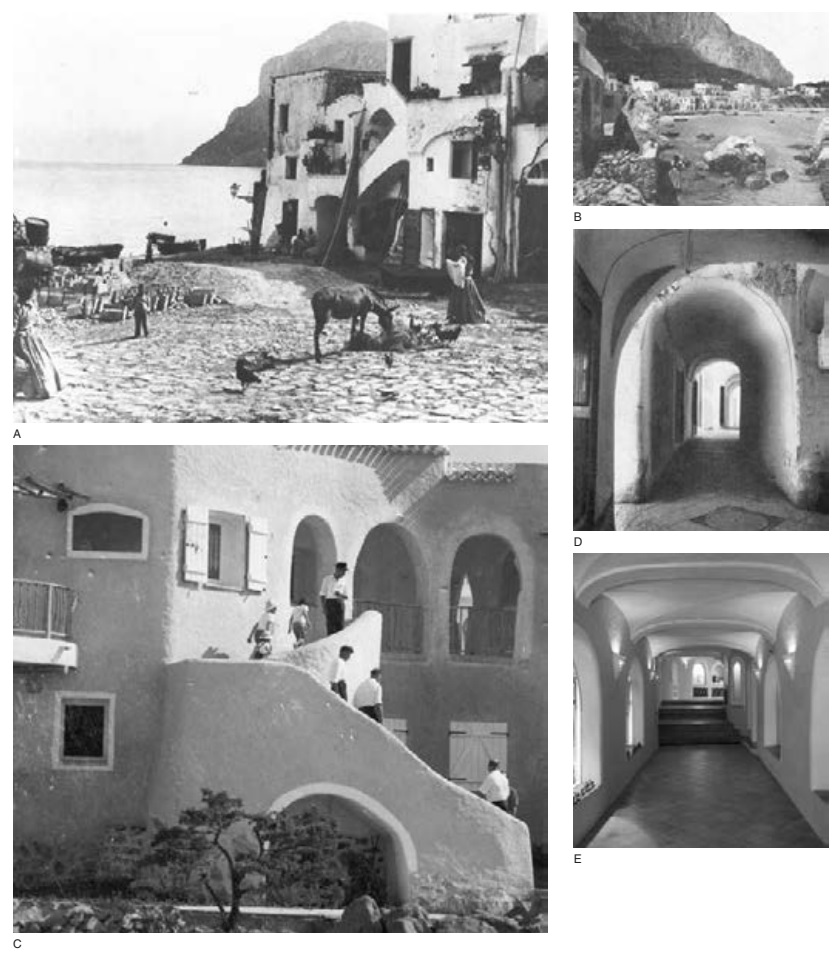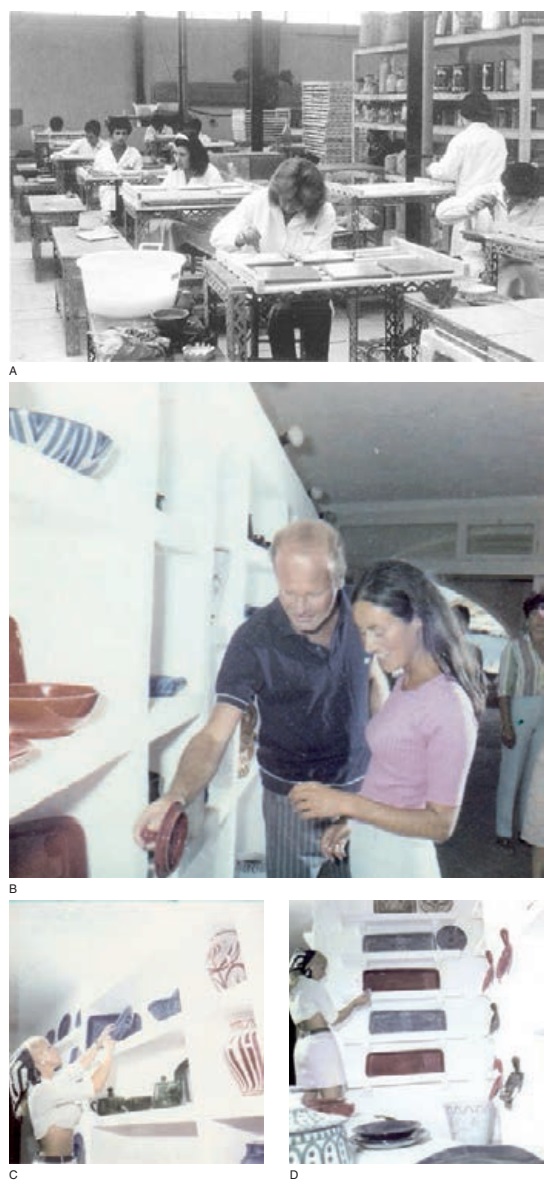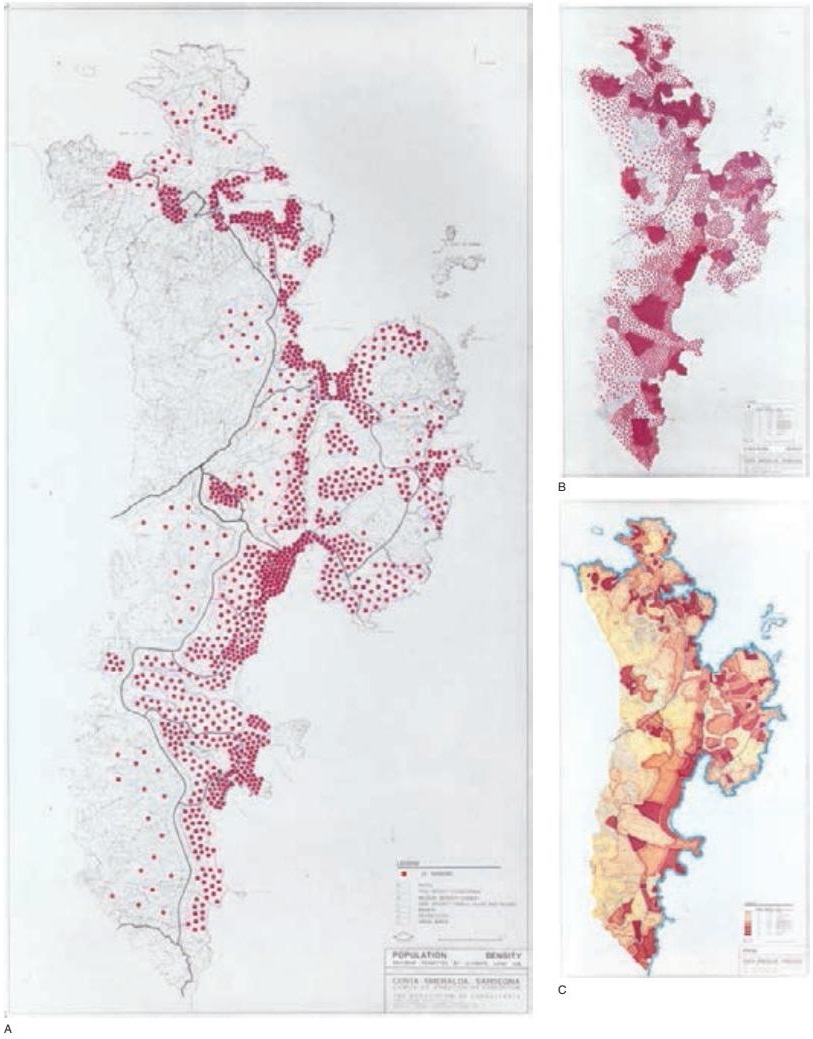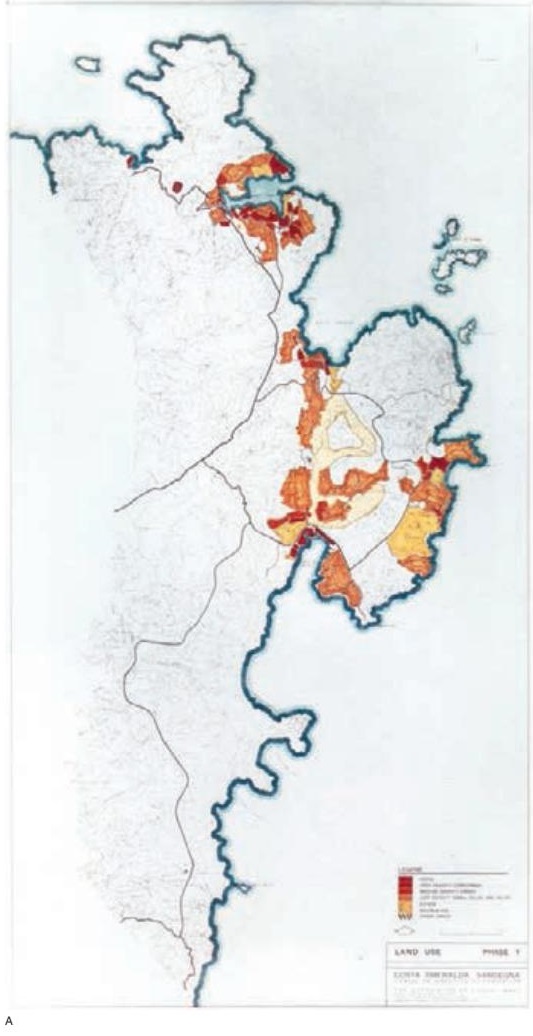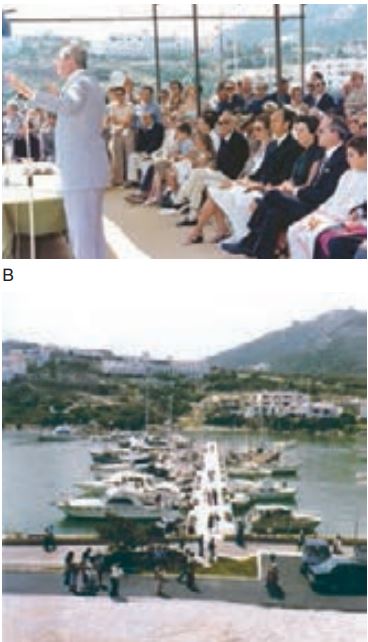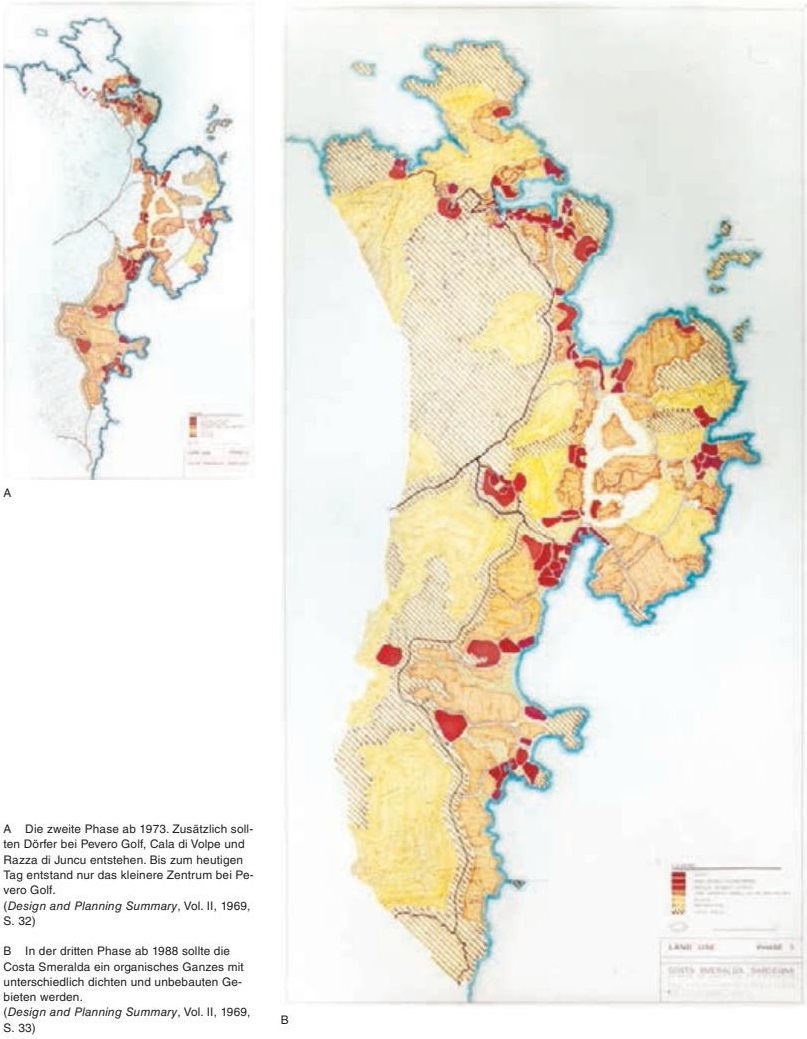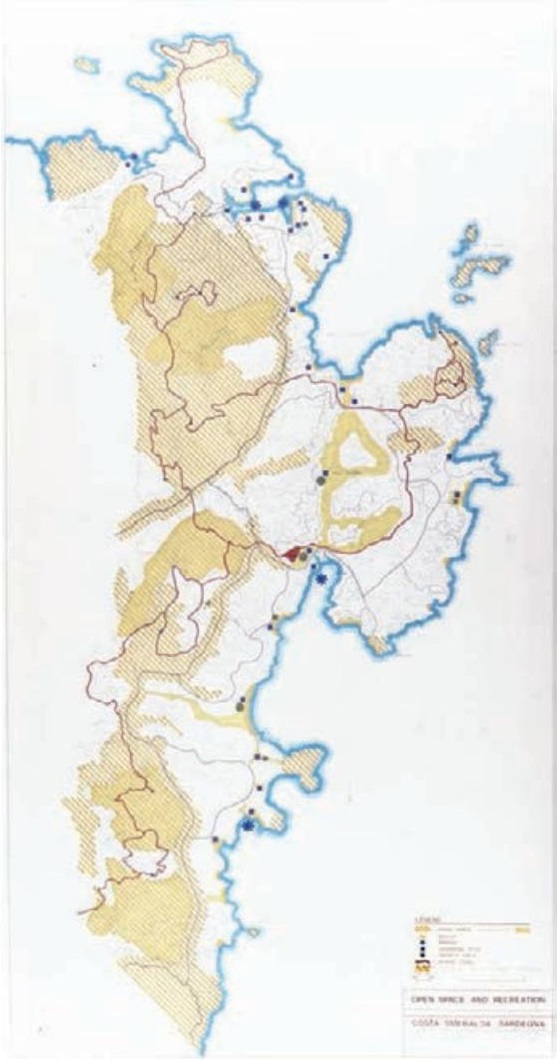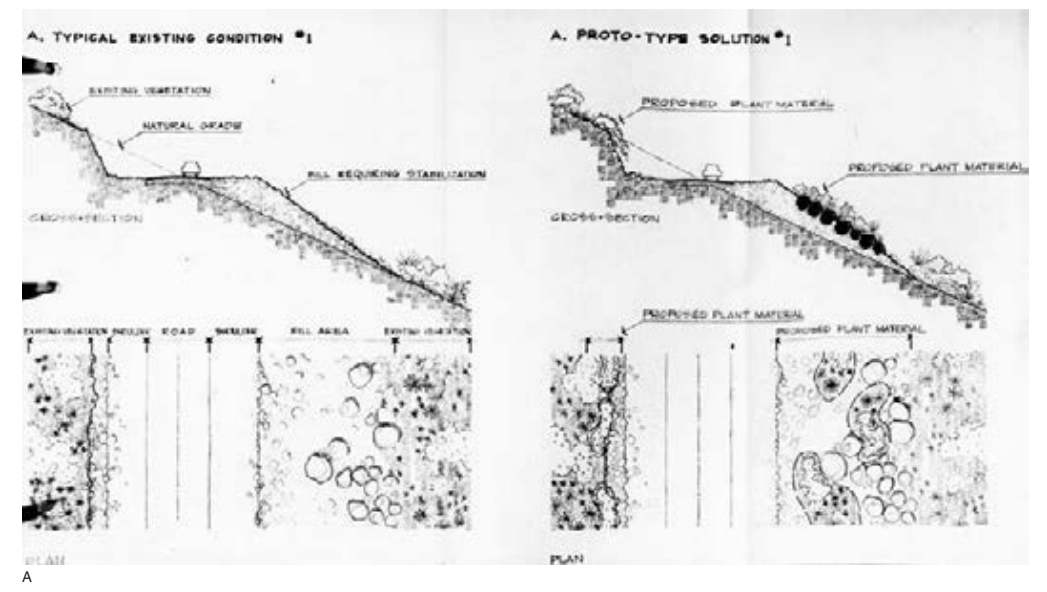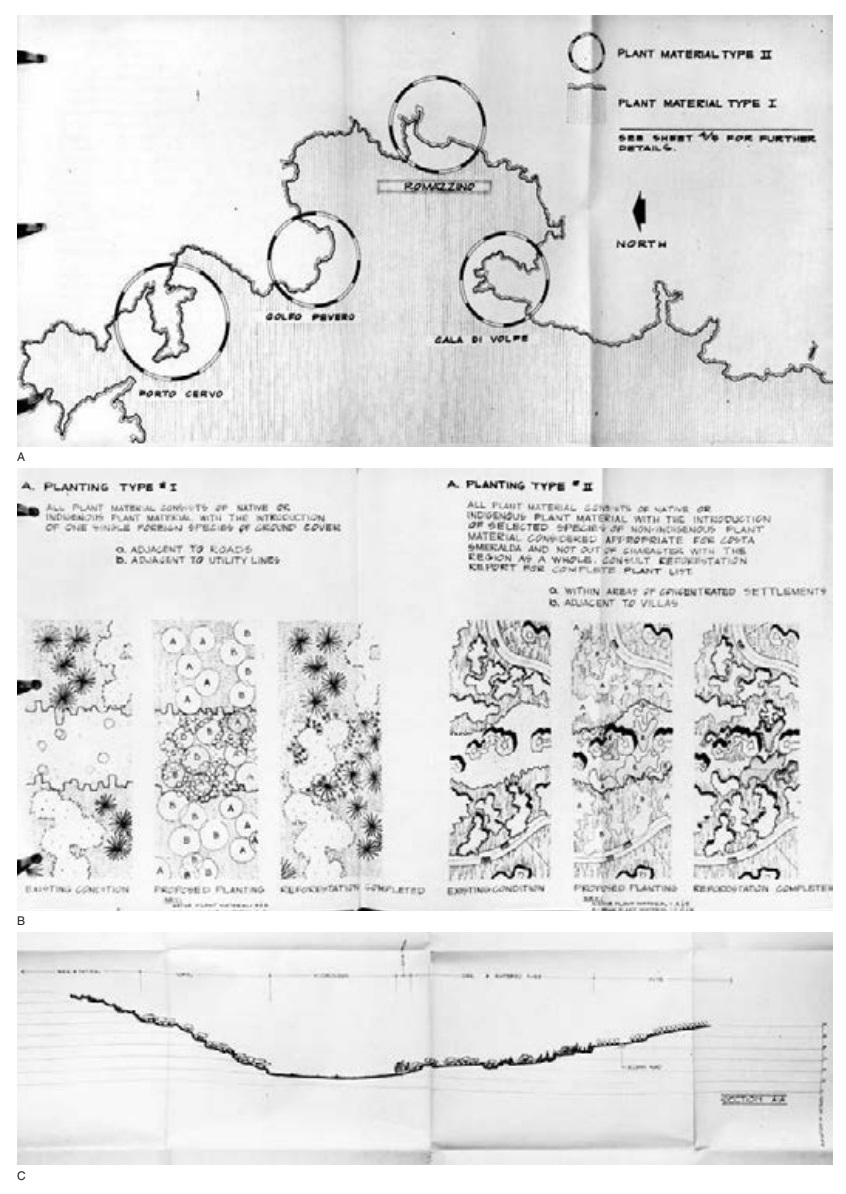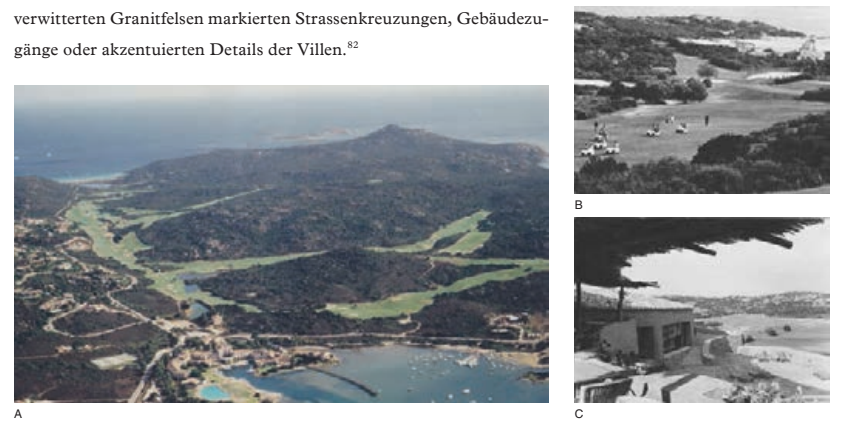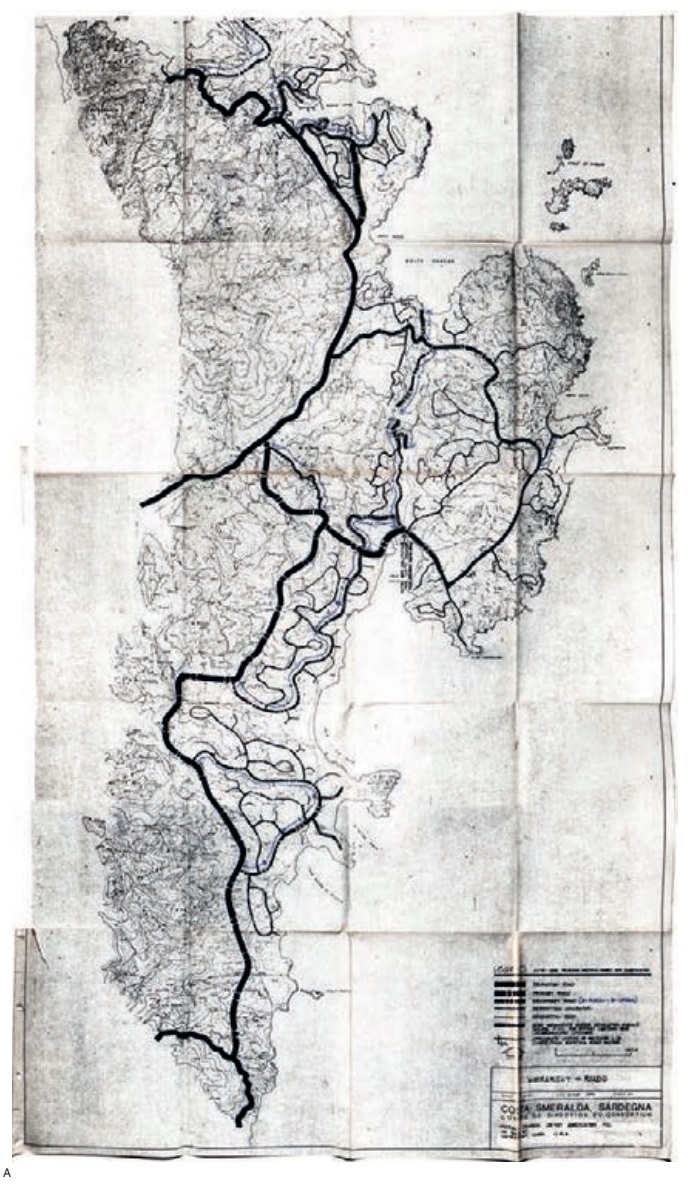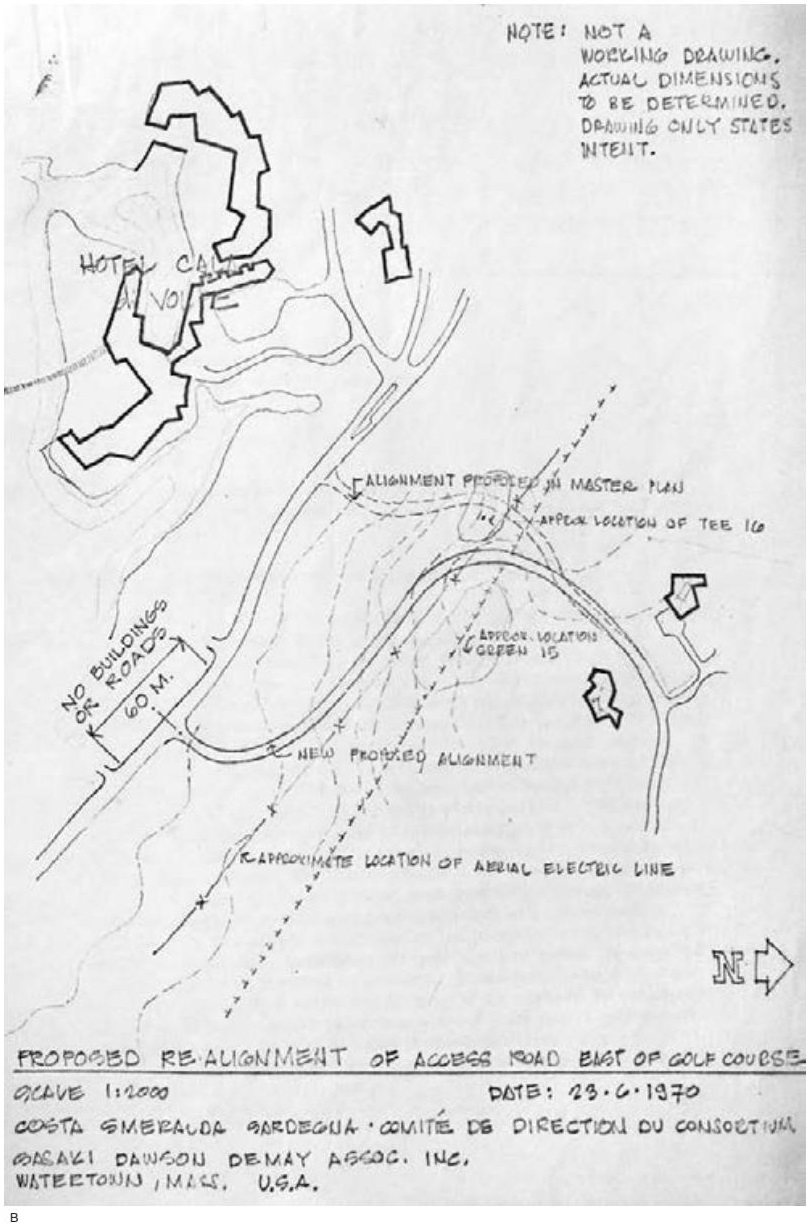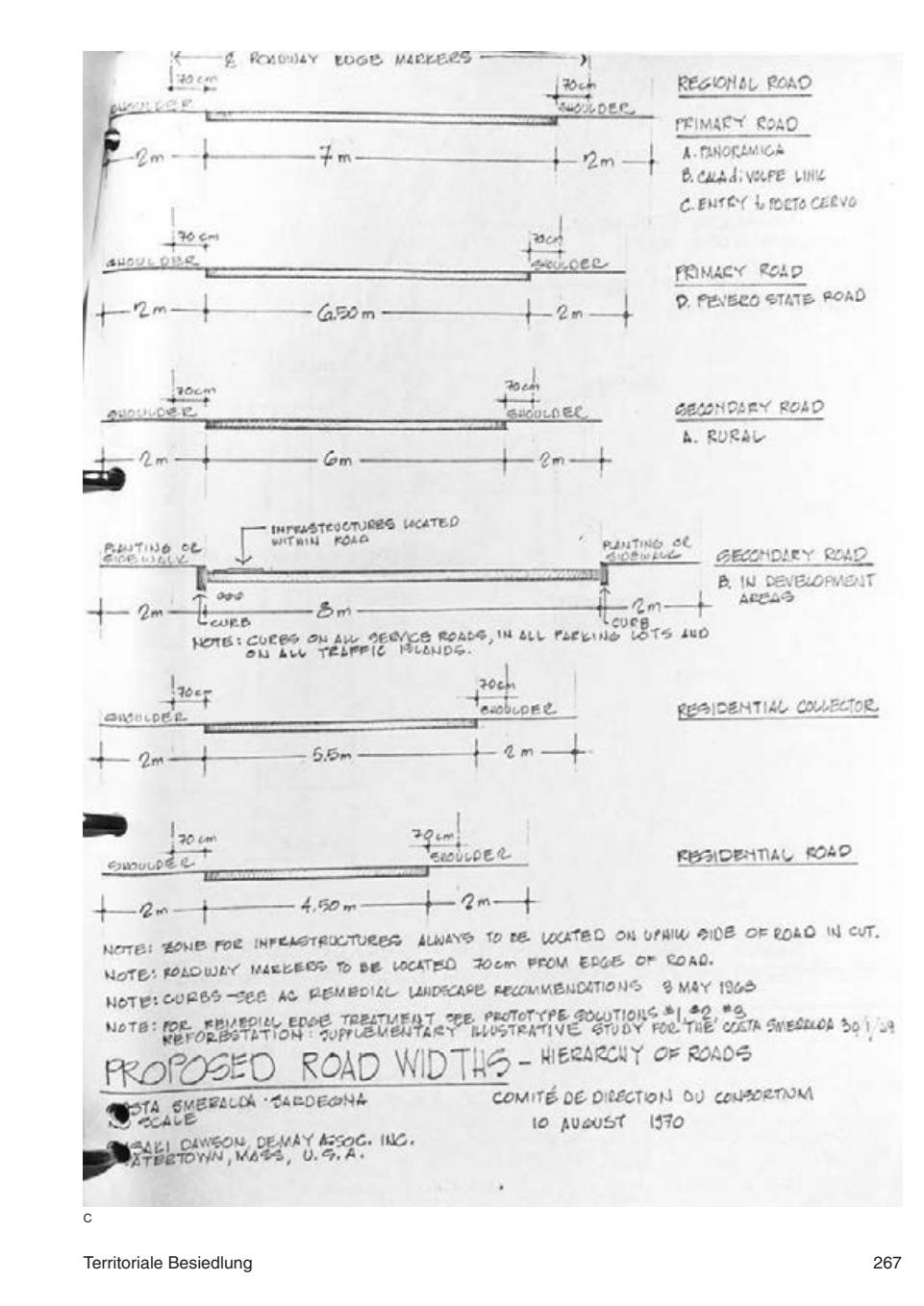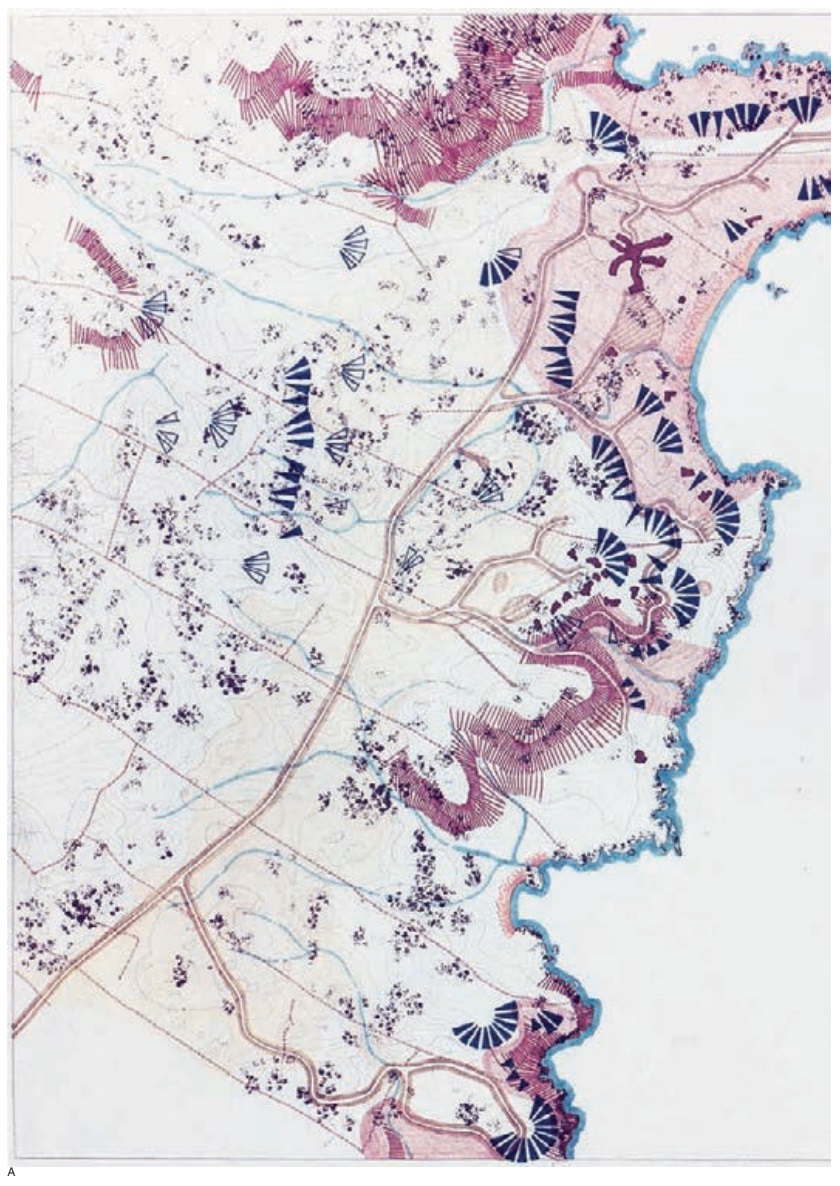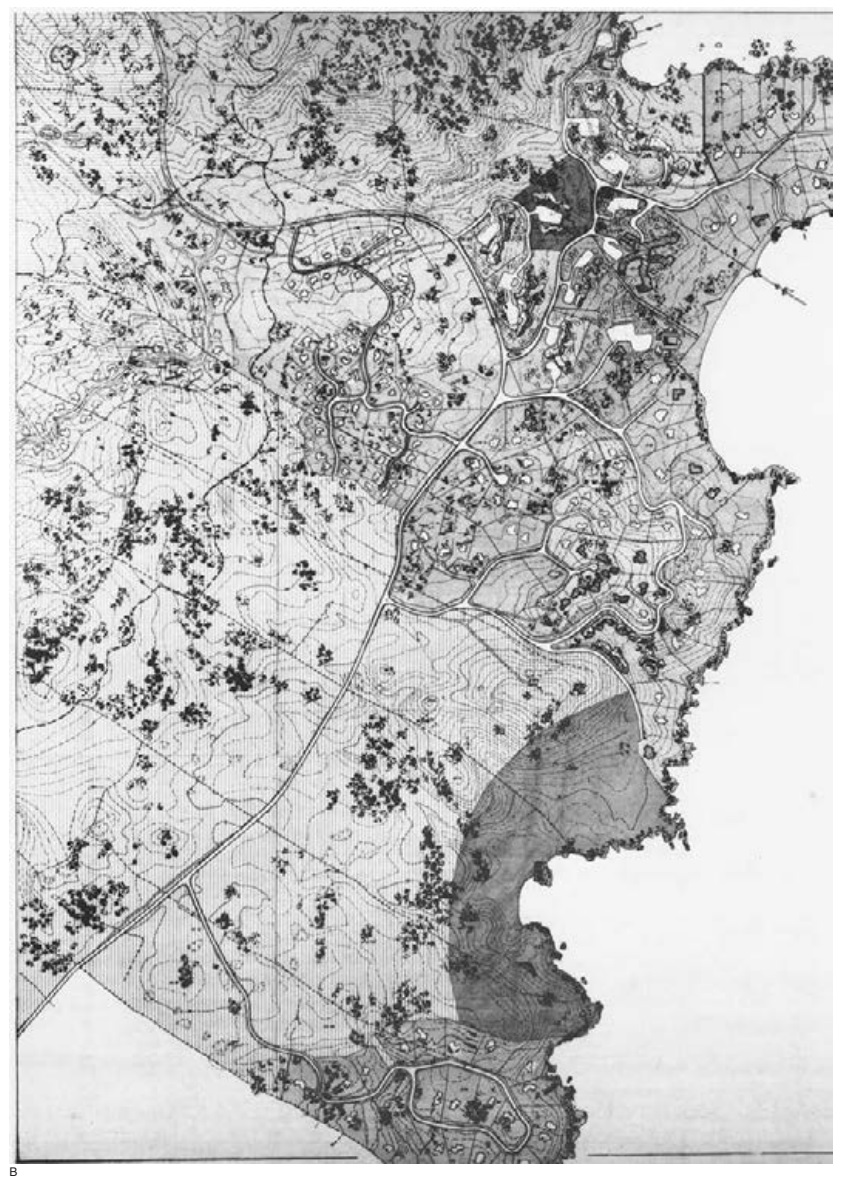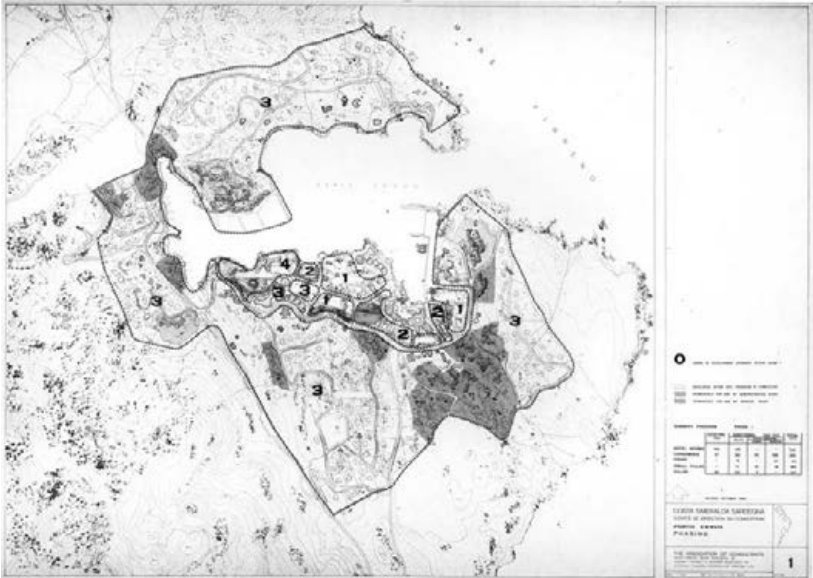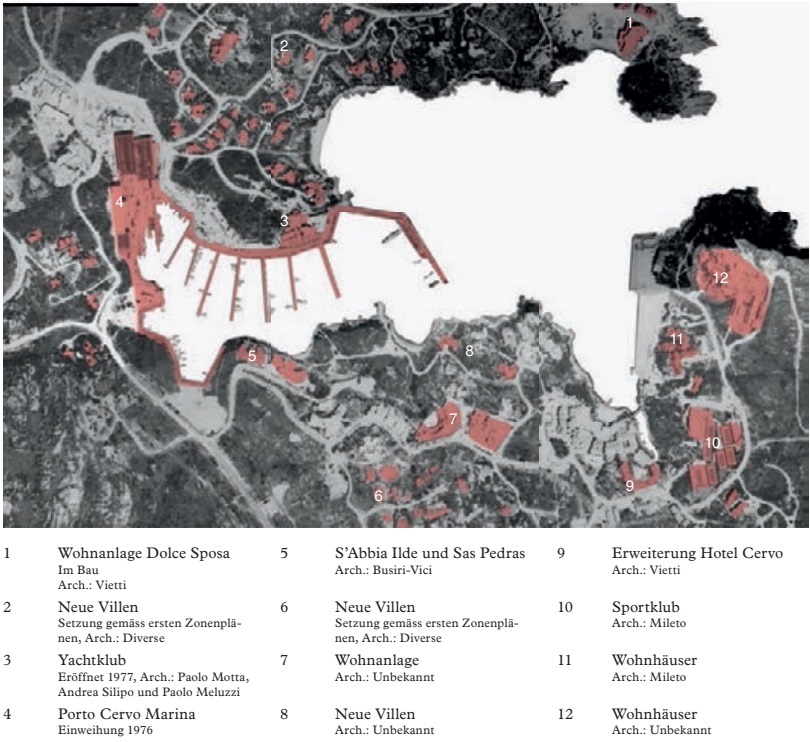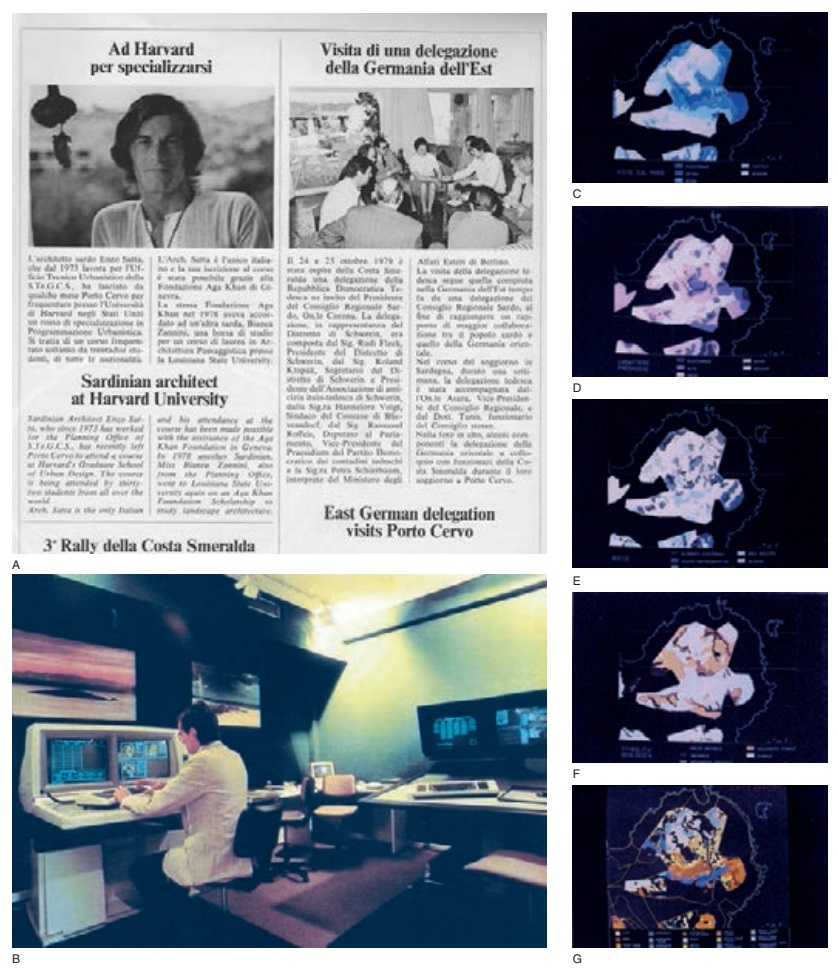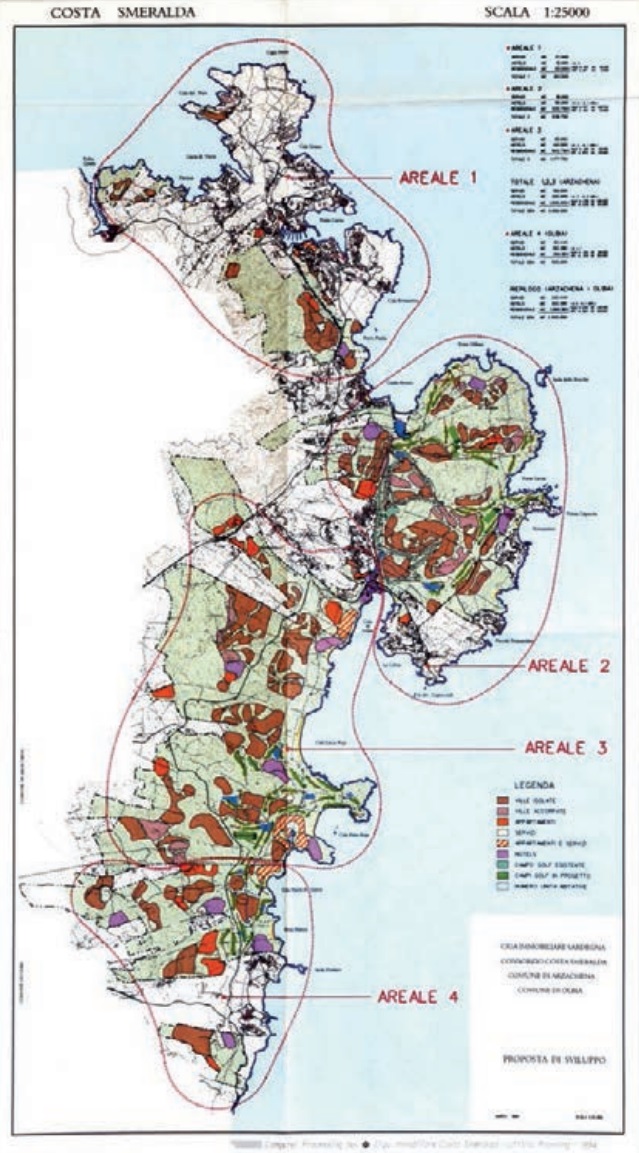Capitolo III
La pianificazione dell’insediamento territoriale •
di Nele Dechmann
(per una consultazione veloce cliccare sui titoli col pallino)
1. 1961-1968 – Le prime pianificazioni
1.1. Il primo masterplan
1.2. Le infrastrutture
1.3. La distribuzione degli insediamenti sul territorio •
1.4. Porto Cervo – L’organizzazione del centro principale •
1.5. Porto Cervo Centro – Modelli per l’urbanistica e l’architettura •
1.6. Porto Cervo Centro – Il nucleo saliente •
2. 1969-1983 – Il masterplan di SDDA •
2.1. Piani per fasi •
2.2. Strumenti di pianificazione – Progettazione del paesaggio •
2.3. Strumenti di pianificazione – Viabilità e localizzazione degli edifici •
2.4. Strumenti di pianificazione – Urbanistica – L’esempio di Porto Cervo •
3. 1983-1998 – Fino all’ultimo masterplan sotto l’Aga Khan •
4. Inquadramento storico-architettonico e storico-culturale •
III. LA PIANIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO TERRITORIALE
Nel 1960, la costa della Sardegna settentrionale era ancora vicina al concetto di “natura”, nel senso di una regione incontaminata dall’intervento umano. I pastori utilizzavano raramente le terre aride, dove il suolo acido permetteva la crescita di poca vegetazione. Alcune pecore appartenenti alle famiglie più povere pascolavano in queste aree sterili. Se un visitatore si avventurava lungo la costa, incontrava occasionalmente un muro di granito che delimitava una proprietà, e ancora più raramente trovava, più nell’entroterra, uno stazzo, una struttura utilizzata dai pastori per trascorrere la notte. Pecore o esseri umani erano una vista alquanto rara per un viaggiatore solitario.
Il sentiero lungo la costa non era percorribile con un’auto normale e veniva utilizzato raramente, nemmeno a piedi o con un asino. I percorsi maggiormente frequentati si trovavano nell’entroterra, dove collegavano i vari insediamenti tra loro.
Quando i membri del Consorzio iniziarono a costruire i primi edifici, il territorio era ancora in questo stato originario. Nella primavera del 1963, il direttore di progetto della ditta di costruzioni Grasseto viaggiava con Vietti e Podbielski a bordo di una jeep inglese da Liscia di Vacca a Porto Cervo. Tuttavia, dopo una forte pioggia, l’accesso divenne impossibile, costringendoli a tornare indietro per raggiungere l’attuale Porto Cervo Vecchio via mare. Durante la visita del sito, Vietti espresse entusiasmo per la visione di una piazza pubblica, indicando i cespugli e le rocce e descrivendo come sarebbe apparso tutto, tanto che i suoi compagni rimasero impressionati da quella visione così audace.
L’area incontaminata rappresentava una sfida unica: sviluppare un intero territorio partendo da zero e cogliere l’opportunità rara di trasformare la natura in un paesaggio pianificato.
1. 1961-1968 – LE PRIME PIANIFICAZIONI
Gli inizi della pianificazione urbanistica e paesaggistica, tra il 1961 e il 1968, non sono documentati né in forma di piani né in forma di testi. Di conseguenza, la descrizione dei primi approcci è stata ricostruita sulla base dei progetti architettonici esistenti e dei racconti di testimoni contemporanei(2).
(2) Per descrivere i primi passi della pianificazione, si fa riferimento a un piano del centro di Porto Cervo del 1964 e a piani dell’intero insediamento di Porto Cervo basati sul rilievo topografico del 1962. Questi ultimi corrispondono allo stato di progettazione circa al 1973. Si consultano inoltre le pubblicazioni Gerlat 2006, Riccardi 2010, Piga 2013 e Cappai 2014. Tutte le affermazioni nel capitolo 3.1, salvo diversa indicazione nel contesto, sono conclusioni tratte da questo materiale.
1.1. Il primo masterplan
La vastità dell’area, completamente priva di infrastrutture, richiedeva una pianificazione in grado di integrare relazioni complesse.(3. È possibile che ci fosse anche una motivazione personale del giovane Aga Khan: creare un luogo che potesse diventare una casa per lui, in quanto guida religiosa senza una nazione. Cfr. Gerlat 2006, pp. 20 e
Il territorio, con una linea costiera di 55 chilometri, doveva acquisire una nuova identità funzionale ed estetica. Questo obiettivo richiedeva un comitato di pianificazione capace di operare su scale temporali e spaziali più ampie rispetto alla progettazione di una singola struttura. Era necessario considerare la costruzione di edifici, strade e infrastrutture insieme alla progettazione paesaggistica. I servizi indispensabili dal punto di vista economico e le infrastrutture funzionali dovevano essere pianificati a lungo termine.
L’obiettivo del Consorzio, ovvero progettare l’intero territorio come un paesaggio integrato, si riflette nei primi processi organizzativi. Nell’intenzione scritta del 1961 per la fondazione del Consorzio, il comitato di architettura era già incluso nella pianificazione. Poco dopo, nel 1962, venne costituito anche un comitato di pianificazione, composto da:
- Michele Busiri-Vici
- Jacques Couëlle
- Luigi Vietti
- Antonio Simon Mossa
- Raimond Martin
- Marise Rohan
- Giancarlo Busiri-Vici
- Leopoldo Mastrella
Le tre principali figure architettoniche, Busiri-Vici, Couëlle e Vietti, dominarono anche il team di pianificazione. Di Raimond Martin, un francese, si sa che progettò almeno la stazione di servizio di Porto Cervo. Marise Rohan, una delle poche donne coinvolte nell’organizzazione, era segretaria di André Ardoin e probabilmente svolse lo stesso ruolo nel comitato di pianificazione.
Il primo incarico del team fu una mappatura dettagliata del territorio. Nel 1962, la ditta Bianchi di Milano produsse carte in cui vennero segnate le mura a secco sarde, i sentieri, gli alberi, ogni roccia e i gruppi di arbusti. Su queste basi, la Costa Smeralda fu pianificata fino agli anni Ottanta.
Anche il primo masterplan, del 1963, venne elaborato utilizzando queste mappe dettagliate. Per definire più centri, furono individuati siti per hotel e porti in luoghi diversi.(6)
6. Il primo masterplan non è disponibile per questa ricerca. Dalla revisione del masterplan del 1969 e della pubblicazione Monografia 25. Anniversario, si ipotizza che Couëlle fosse inizialmente il responsabile del progetto, con Busiri-Vici e Vietti come principali collaboratori. Raimond progettò aree meno importanti. Del sardo Antonio Simon Mossa, spesso menzionato in Sardegna, esiste solo la firma sul primo masterplan del 1963, che non fu realizzato (cfr. Piga 2013, p. 63). Successivamente non si trovano ulteriori tracce della sua partecipazione al team di progettazione. Il suo ruolo rimane difficile da definire. Riccardi attribuisce il suo precoce ritiro a una grave malattia, seguita dalla sua morte prematura (cfr. Riccardi, pp.
L’intera area fu suddivisa in tre zone:
- Aree per ville lungo tutta la costa.
- Zone verdi.
- Aree per attività speciali, come un campo da golf.
Insieme al regolamento edilizio e a una lettera dell’Aga Khan, in cui si affermava che il Consorzio si sarebbe impegnato a proteggere il paesaggio esistente, questo masterplan fu presentato alla Regione e rapidamente approvato.
Nello stesso anno, il masterplan subì modifiche significative: le localizzazioni di hotel e porti furono accorpate in piccoli centri. Quattro aree dovevano diventare centri principali nella pianificazione successiva:
- Pitrizza(7)
- Porto Cervo
- Romazzino
- Cala di Volpe(8)
(7). Pitrizza, insieme alla vicina Liscia di Vacca, forma in realtà un nodo ampliato. Liscia di Vacca era l’area adiacente alla baia di Pitrizza, dove i Podbielski comprarono e vendettero la maggior parte delle proprietà. Per una comprensione semplificata del territorio a più poli, il centro viene riassunto come “Pitrizza”.
(8). Nel primo masterplan, le aree alberghiere e portuali erano separate. Cala di Volpe e Porto Cervo non erano ancora di proprietà del consorzio. Per questo motivo, nel masterplan iniziale si faceva riferimento a Romazzino, Dolce Sposa e Cala Granu. I porti dovevano sorgere a Cala di Volpe, Porto Liscia, Porto Cervo Marina e Cala del Faro. Per le prime pianificazioni dei centri, vedi Gerlat 2006, p. 41, e Piga 2013, pp. 63f.
Le quattro regioni furono suddivise in sottoregioni, ciascuna assegnata a un architetto.
- Couëlle prese in carico Cala di Volpe e probabilmente la parte orientale di Porto Cervo.
- Vietti si occupò del centro di Porto Cervo, di Pitrizza e di una parte di Romazzino.
- Busiri-Vici assunse la responsabilità del centro di Romazzino, con l’hotel, e di una parte di Porto Cervo.
Questa suddivisione è una conclusione basata sui piani e documenti consultati. Il ruolo di Raimond Martin è il meno chiaro, ma è certo che costruì la stazione di servizio a sud di Porto Cervo. È possibile che si sia occupato di alcune parti dell’infrastruttura.
Le tre dimensioni progettuali dell’insediamento territoriale.
La progettazione dei centri tra il 1962 e il 1968 si basò su tre livelli distinti.
Primo livello: pianificazione su larga scala e infrastrutture
Il primo livello riguardava la pianificazione su vasta scala e la costruzione delle infrastrutture. Furono realizzate strade e installati impianti telefonici, elettrici e idrici, connettendo i principali punti nodali. Questi interventi furono pensati con una visione preliminare del numero di edifici che sarebbero stati costruiti in ciascuna area. Il regolamento edilizio, descritto nel Capitolo 2.2.3, stabiliva che tutte le linee dovessero essere sotterranee e che per le costruzioni fuori terra fossero impiegati solo materiali come intonaco grezzo e muratura a vista. Anche gli edifici secondari e tecnici dovevano rispettare gli stessi criteri estetici degli edifici principali e necessitavano dell’approvazione del comitato architettonico. Questa scelta innovativa di nascondere tutta la tecnologia contrastava con il resto della Sardegna, dove le linee elettriche erano generalmente aeree. Tale approccio mirava a evitare la creazione di spazi degradati e non armoniosi alla Costa Smeralda.
Secondo livello: distribuzione geografica e organizzazione dei centri
Il secondo livello riguardava la distribuzione geografica e l’organizzazione dei centri. Fu necessario decidere quanti nodi urbani dovessero essere sviluppati, quale dimensione dovessero avere e dove localizzarli. Dopo aver individuato i quattro primi centri – Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe – venne definita l’organizzazione urbanistica interna di ciascuno di essi.
Terzo livello: grandi elementi architettonici
Il terzo livello era costituito dai principali complessi architettonici, rappresentati dagli hotel più importanti del territorio. Questi edifici erano il cuore dei centri definiti. I quattro complessi formavano nuclei architettonici isolati attorno ai quali si svilupparono successivamente altre costruzioni. I centri di Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe furono progettati seguendo un linguaggio spaziale simile. Nonostante i progetti provenissero da architetti diversi, ciascuno di essi rappresentava una “topografia architettonica astratta”. La pianta a forma di mulino a vento si può riconoscere – almeno in parte – nel centro di Porto Cervo(10). Anche l’Hotel Pitrizza di Vietti incarnava una sorta di paesaggio architettonico, con il complesso del clubhouse, la terrazza esterna, la piscina e il centro benessere integrati in un’unica topografia esplorabile.
(10). Nel caso di Porto Cervo, l’elemento centrale non era costituito da un unico hotel, ma includeva l’Hotel Cervo, che rappresentava una parte rilevante del complesso edilizio.
A. La foto mostra il centro di Porto Cervo appena completato e risale probabilmente al 1964, quando evidentemente gli elicotteri atterravano ancora sulla piazza principale, presumibilmente per uno dei membri del Consorzio. (Fazio 1965, p. 672)
A. La foto panoramica mostra la baia di Porto Cervo ed è del 1960, prima che il Consorzio iniziasse a costruire. (Monografia 25º Anniversario)
B. La seconda fotografia è stata scattata nel 1970; Porto Cervo rappresenta ormai il fulcro della Costa Smeralda, un luogo che è già un punto di riferimento nella mappa internazionale del turismo. (Monografia 25º Anniversario)
A. La foto panoramica mostra la baia di Porto Cervo ed è del 1960, prima che il Consorzio iniziasse a costruire. (Monografia 25º Anniversario)
B. La seconda fotografia è stata scattata nel 1970; Porto Cervo rappresenta ormai il fulcro della Costa Smeralda, un luogo che è già un punto di riferimento nella mappa internazionale del turismo. (Monografia 25º Anniversario)
A. Le prime reti stradali sono state costruite a Porto Cervo e Romazzino. Le strade seguono la topografia e raramente raggiungono la costa. Ecco la planimetria di una concessione edilizia del 1966 (circa la metà degli edifici presenti nella planimetria non sono mai stati costruiti). (Archivio Enzo Satta)
B. Un tipico esempio di tracciato stradale e di collocazione degli edifici.
La strada principale segue la topografia con linee morbide, gli edifici non sono accessibili direttamente dalla strada, ma attraverso un ramo laterale più sottile sul lato opposto del lotto. Gli edifici nella foto qui sopra sono tutti di Savin Couëlle. La foto risale probabilmente alla fine degli anni Sessanta (Archivio Enzo Satta).
C La rete stradale è una componente fondamentale del paesaggio della Costa Smeralda. Le strade seguono un andamento curvilineo, adattandosi alla topografia, per lo più senza muri, attraversando direttamente il paesaggio. Non ci sono spazi pubblicitari e tutti le tubazioni sono interrate. (Foto: ND 2015)
D. Le strade di solito non hanno marciapiedi laterali, tranne nelle aree residenziali, dove ci sono stretti percorsi pedonali su un lato della strada. (Foto: ND 2015)
E. Gli ingressi delle proprietà si trovano direttamente lungo la strada. I primi accessi sono sempre progettati nello stesso modo, con cancelli in legno e pietre di granito ai lati. Le rampe di accesso sono decorate con pietre disposte in modo ornamentale. Spesso accanto al cancello si trova una pietra di granito che indica l’indirizzo della villa. (Foto: ND 2014)
F. Le spiagge pubbliche sono tutte accessibili via terra solo a piedi attraverso stretti sentieri. La foto mostra il sentiero per la Spiaggia del Principe. (Foto: ND 2015)
A. I primi eliporti erano situati su spianate provvisorie. All’estrema sinistra nella foto, il pilota personale dell’Aga Khan. Data della foto sconosciuta. (Archivio Enzo Satta)
A. Nei suoi primi anni l’Aeroporto Alisarda era una pista sterrata risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Foto di Josué Ito, 1966. (Archivio Enzo Satta)
A. Il campo da golf tra Cala di Volpe sopra e il Pevero Golf sotto. A destra della foto, la condotta dell’acqua dalla diga di Liscia lungo la collina, completata nel 1967. Foto probabilmente del 1967. (Archivio Enzo Satta)
1.2. Le infrastrutture
Uno dei motivi principali per la creazione del consorzio fu l’assenza di infrastrutture. I costi di realizzazione di strade, acqua, elettricità e linee telefoniche per servire poche ville erano sproporzionati. L’investimento diventava conveniente solo se permetteva di connettere un’intera catena di insediamenti. I ricavi derivati dalla vendita di terreni e ville avrebbero reso il progetto economicamente sostenibile, e la progettazione delle infrastrutture fu concepita come parte integrante del paesaggio.(13. Lo stesso Aga Khan spiegò la portata del progetto con la mancanza di infrastrutture. Cfr. Bandinu 1996, pp. 24f.)
Costruzione delle prime strade
La parte visivamente più dominante dell’infrastruttura era lo spazio stradale. Questo venne progettato dal Consorzio e protetto, tramite le regole edilizie, dalla volontà di progettazione individuale dei singoli proprietari di case. Il progetto spaziale del tracciato stradale si sviluppò nei primi otto anni. Il piano più antico ritrovato, con strade tracciate, proviene dall’Ufficio Tecnico Bianchi ed è stato guidato da Vietti. (14. Questa conclusione deriva dai documenti dell’epoca esaminati. Vietti è citato come autore della pianificazione generale di Porto Cervo. Cfr. Costa Smeralda – Continuing Services, Memorandum May 1970, punti 4 e 18. Inoltre, già nel 1962 appare in una fotografia in cui spiega la pianificazione prevista per Porto Cervo. Cfr. immagine del documento originale in Monografia 25. Anniversario).
Le strade seguono un percorso curvilineo, adattandosi alla topografia. Si voleva dare l’impressione che ci si muovesse nel cuore di un paesaggio naturale, motivo per cui si evitò del tutto l’uso di muri alti lungo i confini delle proprietà. Intorno ai centri fu permessa solo la costruzione di muri bassi. Nei tratti tra i centri, le strade non hanno delimitazioni costruite né marciapiedi, e la vegetazione arriva direttamente fino all’asfalto. I percorsi pedonali esistono solo su un lato nelle zone residenziali e su entrambi i lati nei punti più centrali di Porto Cervo. Il tracciato stradale influenzava anche la disposizione degli edifici. Le ville si trovano alle estremità della rete organica che si dirama verso la costa. La risorsa naturale più preziosa erano le spiagge di sabbia. Erano tutte accessibili solo tramite sentieri pedonali: le strade terminavano tra i 50 e i 400 metri dalla costa, e un piccolo sentiero attraversava la macchia mediterranea sarda per raggiungere le baie. (15. Oggi l’aspetto delle strade, come del resto l’intera Costa Smeralda, non si presenta più come uno spazio progettato in modo coerente. Ci sono pubblicità, e gli edifici hanno insegne diverse. La mancanza di cura visiva rigorosa risale probabilmente all’uscita di scena dell’Aga Khan nel 1994).
Inoltre, in tutta l’area del Consorzio non erano presenti spazi pubblicitari. Le indicazioni necessarie per hotel, ristoranti e indirizzi vennero progettate appositamente.
Aneddoti e sfide nella costruzione della strada panoramica
Tra il 1961 e il 1963, per visitare le loro proprietà, i membri del Consorzio raggiungevano la Costa Smeralda da Olbia percorrendo strade sterrate a bassa velocità.(16. Per risparmiare ai suoi ospiti i lunghi tempi di viaggio, l’Aga Khan li accoglieva nei primi tre anni con un’imbarcazione a Olbia o li portava in elicottero fino a Cala di Volpe).
Le strade più facilmente percorribili della Sardegna si trovavano nell’entroterra. Per questo motivo, il materiale necessario per i primi cantieri venne trasportato con l’ausilio di asini. Una delle priorità più urgenti del Consorzio fu dunque quella di costruire strade, ampliare i sentieri esistenti, asfaltarli e proteggere i pendii dalle frane. Tutte le reti stradali per i vari insediamenti, le strade costiere e le vie di accesso dovevano essere realizzate ex novo. La pianificazione e l’esecuzione furono affidate al Consorzio, che si occupò anche della maggior parte dei finanziamenti. L’unica eccezione fu la nuova strada panoramica, che collegava la rete stradale esistente in Sardegna con la parte alta della Costa Smeralda e che venne finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno.(17. La strada panoramica collega San Pantaleo, Abbiadori e Porto Cervo). In un paese in cui molte costruzioni vengono realizzate senza autorizzazione e solo successivamente regolarizzate pagando una sanzione, è degno di nota che il Consorzio ottenne tutte le approvazioni seguendo esclusivamente i canali ufficiali.(18. Anche per il suo ruolo di guida religiosa, sempre sotto osservazione, l’Aga Khan non poteva agire senza ottenere preventivamente i necessari permessi).
Sin dall’inizio, si delineò però un conflitto persistente con la politica locale. Mentre a livello nazionale e con il governo della Sardegna esistevano buoni rapporti, a livello locale ogni autorizzazione diventava motivo di negoziati talvolta aspramente combattuti. La strada panoramica, probabilmente ancora oggi la più importante della Costa Smeralda, fu una delle prime cause di questi conflitti politici prolungati.
Nel 1963(19), Paolo Riccardi, l’avvocato locale del Consorzio, fu contattato all’improvviso per accompagnare il ministro della Cassa del Mezzogiorno, Giulio Pastore, e il presidente della stessa, Gabriele Pescatore, in una visita alla Costa Smeralda. Durante il sopralluogo casualmente, l’Aga Khan si trovava sul cantiere di Porto Cervo. Era inginocchiato a terra, intento a osservare un piano insieme agli architetti. Nella breve conversazione, il ministro della Cassa del Mezzogiorno rimase impressionato dalla dedizione e dall’entusiasmo dell’Aga Khan. Riccardi colse l’occasione e chiese il finanziamento per la strada panoramica e un acquedotto per Porto Cervo. Il ministro dette il suo consenso. Tuttavia, questa decisione trovò l’opposizione dell’amministrazione provinciale di Sassari, che preferiva destinare i fondi ad altri progetti per la popolazione locale.
Solo dopo che il ministro Pastore minacciò di bloccare tutti i progetti già approvati dalla Provincia di Sassari in caso di rifiuto, la giunta provinciale cedette. Di fatto, il finanziamento fu approvato contro la volontà della Provincia di Sassari, grazie alla pressione esercitata a livello nazionale e regionale(20). Durante i lavori preparatori per la strada panoramica divenne chiaro quanto strettamente lo sviluppo del progetto fosse legato all’impegno personale dell’Aga Khan.(21)
(19). Non è stato possibile trovare un anno preciso per l’autorizzazione di questi permessi, ma sulla base di tutti gli eventi sembra che il 1963 sia il periodo più probabile.
(20). Per il finanziamento della strada panoramica, cfr. Riccardi 2010, pp. 87-89.
(21). L’Aga Khan desiderava pianificare con precisione la strada e per questo percorse più volte l’intero tracciato previsto. Questo attraversava un sentiero di 8500 metri tra cespugli e rocce. Si incontrava ogni mattina alle 6 con l’intero comitato architettonico all’incrocio di San Pantaleo, e camminavano per sette ore attraverso il terreno, discutendo nel dettaglio il percorso stradale, fino a raggiungere Cala di Volpe nel pomeriggio. Per l’esecuzione dei lavori stradali nei primi anni furono coinvolte imprese sarde. I geometri Gavino Soro, Lelle Rais e Rosas, così come l’impresa di costruzioni Guerri, sono menzionati per nome. L’avvocato Riccardi supervisionò i lavori sul posto, in stretta collaborazione con l’Aga Khan. Per il controllo giornaliero del percorso della strada panoramica, vedi Riccardi 2010, pp. 88f. Per l’esecuzione dei lavori stradali, cfr. Riccardi 2010, pp. 54f.
Porti, eliporti e aeroporto
Anche le infrastrutture marittime e aeree furono create da zero:
- Porti: Il primo porto, Cala di Volpe, fu completato nel 1963, seguito da Porto Cervo nel 1964 e dalla Marina di Porto Cervo nel 1976, dotata di un esclusivo yacht club.
- Eliporti: Inizialmente provvisori, furono poi ampliati con strutture in località come Porto Cervo, Romazzino e altre.
- Aeroporto: La compagnia aerea Alisarda, fondata dal principe Aga Khan, necessitava di una pista di atterraggio. All’inizio si utilizzò una vecchia pista militare nei pressi di Olbia. Dopo lunghe trattative, nel 1974 fu inaugurato l’aeroporto «Olbia-Costa Smeralda».
Le condutture idriche su un’isola con scarsità d’acqua
L’approvvigionamento idrico fu una delle maggiori sfide, poiché la Sardegna soffriva storicamente di carenza d’acqua. Per i primi cantieri, l’acqua veniva trasportata in taniche con l’ausilio di asini. I tentativi di costruire pozzi si rivelarono infruttuosi. La svolta arrivò con il completamento della diga Liscia nel 1962 e il prolungamento delle condutture idriche fino a Porto Cervo nel 1967, grazie all’intervento della Cassa del Mezzogiorno.
L’espansione delle condutture fu tuttavia motivo di conflitti: le autorità locali, in particolare il comune di Arzachena, si opposero all’uso delle risorse idriche da parte del Consorzio. Questo contrasto segnò l’inizio di una serie di tensioni politiche, ma non riuscì a fermare il progetto.
L’impegno personale del principe Aga Khan
Lo sviluppo della Costa Smeralda fu strettamente legato al coinvolgimento personale del principe Aga Khan. La sua dedizione – sia nell’analisi diretta dei progetti che nelle negoziazioni diplomatiche – dimostra quanto il progetto fosse importante per lui. Il suo impegno, combinato con una strategia basata su negoziati e compromessi politici, gettò le basi per il successo della Costa Smeralda come destinazione turistica esclusiva.
L’infrastruttura si integra nel paesaggio
Anche le linee telefoniche e l’elettricità furono portate dall’entroterra alla Costa Smeralda. Come tutti gli interventi, anche questi vennero subordinati al paesaggio circostante. Ciò significava che tutte le linee furono interrate. Gli elementi infrastrutturali visibili in superficie furono integrati nel paesaggio: le strutture come la stazione di servizio o l’edificio tecnico per le linee telefoniche furono progettate nello stile tipico della Costa Smeralda.
L’edificio per le linee telefoniche fu disegnato da Busiri-Vici nel 1963, mentre la stazione di servizio fu realizzata da Raimond Martin.(25. La stazione di servizio progettata da Raimond Martin fu probabilmente completata alla fine del 1968).
I quadri elettrici furono coperti secondo un modello standard con piccoli tetti di tegole, intonacati su tre lati e dotati di coperture in metallo che richiamavano le persiane in legno tradizionali. I tombini delle condutture idriche furono decorati con il logo della Costa Smeralda.(26. Non è chiaro se questi elementi siano stati definiti o se derivassero da un consenso del gruppo iniziale).
Le facciate degli hotel e delle ville rivolte verso la strada furono parzialmente standardizzate. Tutti gli accessi alle case furono delimitati con cancelli di legno di ginepro non lavorato e pavimentati con pietre accuratamente posate. Due “pietre di confine” segnavano l’ingresso al territorio della Costa Smeralda lungo la strada principale. Successivamente, anche gli altri edifici furono contrassegnati in modo simile. Davanti alle ville e agli hotel più grandi furono posti massi di granito invecchiati, sui quali il nome della struttura era inciso con caratteri in stile serif. Gli elementi visibili delle infrastrutture furono così trattati come elementi di architettura tradizionale o caratterizzati da materiali naturali. (27. Non esistono documenti o prove scritte che regolino la progettazione degli accessi con dettagli su cancelli e pietre granitiche. Tuttavia, l’osservazione dei documenti e delle immagini storiche, che mostrano un trattamento uniforme degli accessi, suggerisce una regolamentazione unitaria. Ancora oggi, il regolamento edilizio impone di sottoporre la progettazione degli accessi al comitato architettonico).
La natura veniva individuata come bene centrale già nei primi regolamenti edilizi. L’elemento naturale più importante che gerarchizzava l’ambientazione degli edifici e delle strade erano le coste, con le loro formazioni rocciose, le loro spiagge piatte e sabbiose e il bagliore verde smeraldo dell’acqua tipico del Mediterraneo.
A. Le iscrizioni sono state integrate nell’architettura. Per esempio, nella terrazza esterna «Il Grill» nella Sottopiazza di Porto Cervo. Foto probabilmente risalente agli anni ’70. (Monografia 25º Anniversario)
B. Il cippo posto sulla strada di uscita a nord della Costa Smeralda segnava il punto di partenza per ulteriori indicazioni sugli indirizzi incise su pietre di granito. Ad esempio, all’ingresso di Porto Cervo fu posizionata un’altra pietra di granito. Anche hotel, ristoranti e il campo da golf vennero contrassegnati in questo modo lungo le strade. (Monografia 25º Anniversario)
C. Anche le prime ville furono contrassegnate con pietre di granito. Qui la Villa Guinder Alda. (Foto: ND 2014)
D. Le cabine elettriche in tutta la Costa Smeralda furono trattate secondo un modello uniforme. Foto probabilmente degli anni ’60. (Archivio Enzo Satta)
E. Uno dei primi edifici dedicati alle infrastrutture fu quello per la rete telefonica nei pressi di Porto Cervo. Fu progettato all’inizio degli anni ’60 da Busiri-Vici nello stile della Costa Smeralda. Foto del 1970. (Monografia 25º Anniversario)
F. Le prime tubature dell’acqua riportano il logo della Costa Smeralda e si inseriscono in una pianificazione d’insieme. (Foto: ND 2014)
1.3. La distribuzione degli insediamenti sul territorio
La caratteristica principale degli insediamenti della Costa Smeralda era che i singoli centri fossero piuttosto piccoli e distribuiti a grandi distanze lungo la costa. Gli hotel fungevano da nodi centrali di questi insediamenti, collegati alla rete stradale della Sardegna e dotati di approdi per le imbarcazioni. I quattro hotel principali, Pitrizza, Cervo, Romazzino e Cala di Volpe, furono costruiti già nei primi anni di sviluppo.(29. Successivamente, questa rete doveva essere ampliata lungo la costa fino a un punto nodale a sud, presso Razza di Juncu).
La distribuzione di questi quattro centri appare irregolare. Via terra, la distanza tra loro varia dai tre agli otto chilometri, mentre via mare il distacco è quasi sempre esattamente di sette chilometri. Questo suggerisce che la loro disposizione sia stata pianificata tenendo conto delle distanze nautiche.(30. Non esistono fonti che confermino questa supposizione, ma ci sono alcuni indizi a favore. Ad esempio, l’importanza della vela, un elemento integrale del luogo fin dall’inizio, o le dimensioni ufficiali del territorio fornite dal consorzio. L’unico dato dimensionale fornito riguarda la lunghezza della costa (55 km).
Insieme, gli hotel costituivano una rete che si estendeva su tutto il territorio. Ogni piccolo centro offriva servizi diversi. Porto Cervo, il nodo più grande, disponeva di un vero porto, cui si aggiunsero nel tempo campi da tennis, una scuderia, boutique di lusso, ristoranti e vari servizi. Cala di Volpe aveva un porto più piccolo e, a partire dal 1968, nei pressi fu costruito un campo da golf completato nel 1972. Il Romazzino era concepito come un elegante hotel per famiglie, mentre il Pitrizza era un rifugio esclusivo. Gli ultimi due avevano solo piccoli moli per le imbarcazioni.
La distribuzione degli insediamenti seguiva la linea costiera e le baie preesistenti, integrandosi armoniosamente nel paesaggio naturale. Questa priorità accordata alla natura si rifletteva anche in scala ridotta: dalla posizione degli edifici, attentamente inseriti nella topografia del territorio, ai dettagli architettonici ispirati alla tradizione vernacolare sarda e all’incorporazione di elementi naturali, fino agli arredi che riprendevano le tecniche di tessitura tradizionali dell’isola.
Già nel primo regolamento edilizio, la natura veniva definita come un bene centrale. L’elemento naturale più importante, che determinava la gerarchia nella collocazione degli edifici e delle strade, erano le coste, con le loro formazioni rocciose, le spiagge sabbiose e l’inconfondibile lucentezza smeraldina delle acque del Mediterraneo.
Inoltre, i massi di granito erosi furono riconosciuti come elemento distintivo dell’identità locale. Queste formazioni granitiche, che somigliano a sculture astratte, rappresentano una peculiarità della Sardegna settentrionale. Infine, venne studiata la vegetazione e alcune specie locali, come i cespugli di ginestra e i ginepri, furono integrate nell’aspetto paesaggistico desiderato per la Costa Smeralda.
Per ottenere il permesso di costruire, era obbligatorio dichiarare tutte le formazioni rocciose e le piante esistenti sul terreno. Gli elementi naturali presenti venivano posti sotto tutela. Gli alberi su un terreno edificabile dovevano essere preservati; tuttavia, se per necessità un albero doveva essere abbattuto, il proprietario era obbligato a piantarne due nuovi in sostituzione sul proprio terreno. Le piante autoctone erano privilegiate, mentre era proibita la vegetazione estranea che avrebbe potuto alterare troppo il carattere della costa sarda.
Il paesaggio naturale non influenzò soltanto l’architettura, ma anche l’identità complessiva dei quattro elementi principali. Per gli hotel furono creati simboli che raccontavano questa fusione tra l’artigianato e la natura sarda: l’Hotel Pitrizza ha come emblema un uccello, l’Hotel Cervo un cervo, l’Hotel Romazzino un fiore di rosmarino, e il Cala di Volpe una volpe. Questi simboli, rappresentativi della flora e fauna sarda, sono stati stilizzati ispirandosi ai motivi dei tessuti artigianali.
Per mantenere il controllo sull’aspetto complessivo del paesaggio, il consorzio introdusse lo strumento della delimitazione preliminare. Ogni edificio doveva essere delineato con strutture in legno, come avviene comunemente in Svizzera, prima dell’inizio dei lavori. Questo permetteva di valutare l’impatto visivo sull’ambiente naturale e di apportare eventuali modifiche direttamente sul posto.(33. È plausibile che l’Aga Khan, all’epoca residente a Ginevra e con una seconda casa a Gstaad, abbia svolto questo controllo preventivo dalla Svizzera).
A. I massi di granito furono percepiti come sculture già durante la prima esplorazione dell’area. Negli anni iniziali divennero elementi identificativi del territorio. Qui una foto della baia di Cala di Volpe, con l’hotel sullo sfondo. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
B. I massi di granito ricordano le sculture di Henry Moore, che negli anni ’60 e ’70 raggiunse l’apice della sua notorietà in vita. Qui la sua scultura «Sheep Piece» del 1971 nel giardino della sua ex residenza. (Foto Jonty Wilde)
C. Con l’aiuto di strutture in legno, ogni edificio pianificato veniva inizialmente tracciato. Foto del 1970. (Archivio Enzo Satta)
A-H. Gli elementi principali del paesaggio costiero sono le spiagge, il mare, i massi di granito erosi e alcune piante selezionate della macchia mediterranea sarda. Queste fotografie furono commissionate nel 1966 dal Consorzio Costa Smeralda per scopi pubblicitari. Fotografo: Josué Ito.
I. Anche la prima pista di atterraggio di Alisarda, situata nel mezzo del paesaggio agricolo sardo, fu fotografata nel 1966 da Josué Ito.
(Archivio Enzo Satta)
1.4. PORTO CERVO – L’organizzazione del centro principale
Il principio di organizzazione urbanistica di Porto Cervo fu concepito in modo simile a quello dell’intera Costa Smeralda: i primi elementi furono posizionati in punti nevralgici. Sebbene il loro stile architettonico fosse armonizzato, furono collocati come nuclei indipendenti, senza una pianificazione dettagliata per le aree intermedie. Le costruzioni successive vennero realizzate anni o decenni più tardi. Due fattori hanno influenzato l’organizzazione urbanistica di Porto Cervo.
Il primo fattore è la distribuzione ampia dei primi edifici principali, basata sui mezzi di spostamento degli abitanti della Costa Smeralda: i tragitti venivano percorsi in auto sulla terraferma e in barca via mare. Le distanze tra i vari luoghi non rappresentavano quindi un problema. Oggi, questa dispersione favorisce un’industria di taxi prospera, che serve i visitatori arrivati in yacht. I taxi operano non solo tra i quattro centri principali, ma anche spesso all’interno di Porto Cervo.(34. Secondo Enzo Satta, i taxi sono il mezzo di trasporto più comune per spostarsi nel villaggio ramificato di Porto Cervo).
Il secondo fattore è una pianificazione che segue quasi dogmaticamente la linea costiera esistente. La conservazione della morfologia naturale è notevole, considerando che le baie furono comunque modificate per renderle navigabili. Ad esempio, la piccola insenatura accanto all’Hotel Cervo fu prosciugata e delimitata da muri, così come il porto di Cala di Volpe. Sebbene modificare il profilo costiero non avrebbe comportato un maggiore sforzo, fu adottato un approccio conservativo anche nella costruzione del Pitrizza, dove, nonostante i massicci lavori di livellamento, la topografia originale fu ripristinata.
Porto Cervo si trova in una baia particolarmente ramificata, persino per gli standard sardi. Come per la distribuzione dei centri lungo la costa della Costa Smeralda, anche a Porto Cervo i punti di interesse non sono concentrati in un unico centro, ma disposti lungo tutta la baia ramificata. Questa organizzazione policentrica del centro principale riflette su scala ridotta l’intero progetto della Costa Smeralda.
Nei primi anni, accanto al centro della baia orientale fu costruita la capitaneria di porto, incaricata di controllare le navi in arrivo. Tra la capitaneria e il centro si trovava il primo molo, il “Molo Est”, così chiamato per la sua posizione, dato che era già previsto un porto più grande: l’attuale Porto Cervo Marina. Su una collina sopra il Molo Est venne stabilito il primo eliporto e una strada fu tracciata per collegarlo. Di fronte alla capitaneria si trovava la Maison du Port di Savin Couëlle, sede dello Yacht Club, uno dei fulcri della società velica.(36. Couëlle e Vietti diventarono anche proprietari di case nella Costa Smeralda. Vietti divenne membro dello yacht club, e i ruoli tra committenti e progettisti si mescolarono).
Le zone residenziali furono definite presto e le prime ville sorsero sparse in tutto il territorio del centro principale. Sulla punta della flangia occidentale del centro fu costruito il complesso residenziale “Cerbiatta” di Vietti, composto da otto edifici, principalmente grandi case bifamiliari sulla costa. Alcuni membri fondatori vi stabilirono le loro prime residenze alla Costa Smeralda. Oggi queste case si trovano in una delle zone più centrali, tra il centro e il Porto Cervo Marina, costruito nel 1976.
Ad ovest della Cerbiatta, sul pendio verso Porto Cervo Marina, Busiri-Vici costruì singoli edifici. Per oltre un decennio fu l’unico architetto a costruire su questo versante, con opere pubbliche come la chiesa Stella Maris, l’Hotel Luci di La Muntagna e il porticato della residenza Sa Conca. Sul pendio vi erano anche edifici privati come la centrale telefonica, una delle prime costruzioni, e le case residenziali S’Abbia Ilde e Sas Pedras.
Anche a Porto Cervo, la disposizione degli edifici rispondeva alla topografia e alle viste, con un’organizzazione in cui la natura era il principale interlocutore “urbanistico”. Sul versante meridionale, verso l’interno, si svilupparono le prime ville che, con il tempo, formarono un quartiere residenziale completo.
L’unificazione urbanistica e paesaggistica dei singoli elementi in un unico luogo si rivelò una sfida. La distanza tra i nuclei e la necessità di pianificare gli spazi intermedi richiedevano una strategia unificante. Inoltre, la partecipazione di diversi architetti introdusse discontinuità. Il piano situazionale del 1973, sovrapposto alla mappa topografica del 1962 dello Studio Bianchi, evidenzia leggere discrepanze tra le forme organiche di Vietti e Couëlle e le geometrie di Busiri-Vici, come la disposizione circolare del Casa Studio o la struttura a pettine di Sa Conca.
Nonostante le difficoltà, il comitato di progettazione cercò di creare una coerenza complessiva, collaborando con il consorzio per trattare la costa come un’unità. Tuttavia, la natura complessa del progetto, la libertà organizzativa del consorzio e le ambizioni individuali dei proprietari e progettisti resero sempre più difficile mantenere un’immagine unitaria del tutto.
A. La linea costiera naturale fu rispettata quasi dogmaticamente durante la costruzione della Costa Smeralda. Nel 1964, la sporgenza naturale della baia fu racchiusa in una vasca di cemento, utilizzata come approdo per le barche dell’Hotel Cervo. Foto del 1963.
B. Successivamente, un ponte conduce al Molo Est. Foto del 1963.
C. Così come per Porto Cervo, anche a Pitrizza la topografia naturale esistente fu conservata. Foto del 1964.
A-C (http://www.visitcostasmeralda.it/ita/storia-della-costa-smeralda/gli-anni-sessanta.html [11.3.2015])
D. Anche a Cala di Volpe la baia fu temporaneamente prosciugata e racchiusa con muri. Foto del 1963. (Gerlat 2006, fig. 13)
1. Porto Cervo Marina
La baia diventa un porto a partire dal 1976
7. Villa
Architetto: Sconosciuto
13. Villa
Architetto: Savin Couëlle, probabilmente con Jacques Couëlle
2. Centrale telefonica
Architetto: Busiri-Vici
8. Case residenziali
Architetto: Vietti
14. Eliporto
Provisoria e non pavimentata (posizione presunta)
3. Hotel Luci di la Muntagna
Architetto: Busiri-Vici
9. Centro Porto Cervo – Hotel Porto Cervo
Architetto: Vietti
15. Ristorante Il Pomodoro
Ex mensa per operai
Architetto: Savin Couëlle
4. Chiesa Stella Maris
Architetto: Busiri-Vici
10. Ristorante Il Pescatore
Architetto: Savin Couëlle, probabilmente con Jacques Couëlle
16. Due ville
Architetto: Savin Couëlle, probabilmente con Jacques Couëlle
5. Complesso residenziale
Architetto: Busiri-Vici
11. Yacht Club – Maison du Port
Architetto: Savin Couëlle
17. Villa
Architetto: Presumibilmente Savin Couëlle
6. Palazzina Sa Conca
Architetto: Busiri-Vici
12. Comando del porto
Architetto: Sconosciuto
18. Stazione di servizio (in costruzione)
Architetto: Martin
B e C. Il nightclub di Porto Cervo, probabilmente progettato da Savin Couëlle. L’architettura richiama i set cinematografici successivi del film di James Bond La spia che mi amava o di Star Wars IV. Foto del 1966 di Josué Ito. (Archivio Enzo Satta)
D. Ristorante a Porto Cervo, probabilmente situato nell’Hotel Cervo. Il tema nautico caratterizza l’arredamento degli interni. Foto del 1966 di Josué Ito. (Archivio Enzo Satta)
L’Aga Khan presenta una proposta di sviluppo per una baia della Costa Smeralda, che non fu mai realizzata.
Nell’immagine, a sinistra dietro l’Aga Khan, si trova la Maison du Port di colore rossastro progettata da Savin Couëlle. A destra, il centro di Vietti; a sinistra, dall’altra parte della baia, in basso, le residenze di Vietti e in alto Sa Conca di Busiri-Vici, che in realtà si affaccia già sulla baia successiva.
(Foto di Slim Aarons, circa 1965, erroneamente datata 1960 da Slim Aarons).
A. Parte del piano generale di Porto Cervo, nello stato del 1973 circa. La base è costituita dalla mappatura dettagliata del terreno realizzata dallo Studio Bianchi di Milano nel 1962. A destra del dettaglio del piano si trova il centro, a sinistra Porto Cervo Marina. Nonostante alcune discontinuità nel linguaggio formale, si nota lo sforzo dei tre architetti di perseguire un linguaggio comune. Al centro in basso si trovano Casa Studio, l’Hotel Luci di Muntagna, Sa Conca e la chiesa progettata da Busiri-Vici. Sulla costa a destra e lungo la costa in alto sono situate le ville di Vietti. (Archivio Enzo Satta)
B. Dettaglio del piano del centro di Porto Cervo. In basso a sinistra e sulla sponda opposta si trovano Il Pescatore, realizzato dai Couëlle, e le residenze progettate da Mileto. Anche questo piano risale probabilmente al 1973. (Archivio Enzo Satta)
A. Gli edifici della Marina Grande a Capri non solo sono situati su un ripido pendio, ma formano anche paesaggi topografici. (Cantone/Prozillo 1994, p. 45)
B. Molte caratteristiche di Porto Cervo ricordano anche nella forma e nell’ambientazione la Marina Grande di Capri. Gli edifici a schiera hanno spesso facciate ad arco. La prima fila di case è vicino alla riva. (Petraccone 1913, Fig. 18)
C. Il centro di Porto Cervo di Vietti presenta parallelismi con la Marina Grande di Capri sia nell’architettura che nell’urbanistica. Fotografia probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
D. Archi coperti nella parte medievale di Capri, che ricordano i corridoi del Sottopiazza di Porto Cervo. (Maiuri 1956, p. 89)
E. Porto Cervo, Sottopiazza. (Foto: ND 2015)
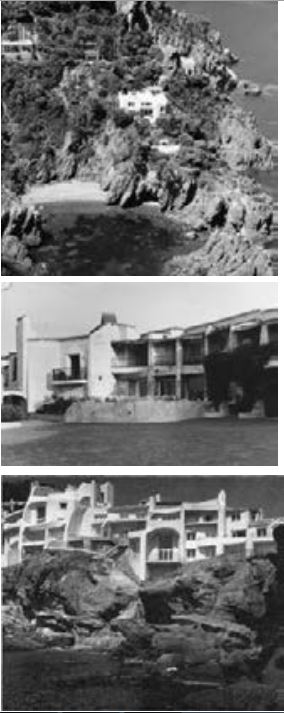
A. Villa Trident di Barry Dierks sulla Côte d’Azur.
(http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_monumental_et_archeologique/insitu/pdf/d8-635.pdf [10.10.2015])
B. Porto Cervo, 1964, progettato da Vietti. Nell’immagine è visibile la parte alberghiera dell’elemento centrale. (Archivio Enzo Satta)
C. Il complesso residenziale La Galère a Théoule, progettato da Jacques Couëlle e costruito tra il 1968 e il 1979. Couëlle ha perseguito il linguaggio delle forme organiche in maniera più intensa durante e dopo il progetto della Costa Smeralda. (Schein 1971, p. 261)
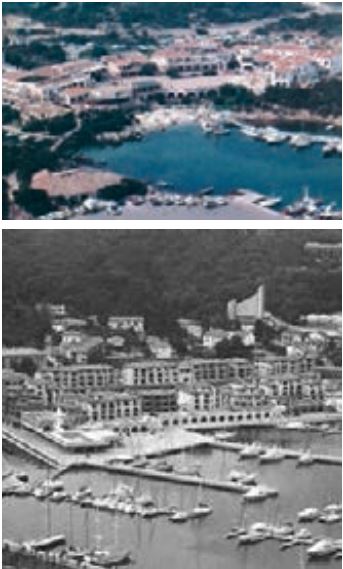
A. Il centro di Porto Cervo di Vietti è stato inaugurato nel 1964. È composto dalla Sottopiazza con un porticato che conduce alla spiaggia e dalla Soprapiazza con annessi hotel, appartamenti e negozi. Foto probabilmente degli anni ’80. (Archivio Enzo Satta)
B. Il porto di San Rocco di Vietti, costruito nel 1998, è costituito dagli stessi blocchi edilizi e si colloca in modo simile vicino al mare. Anche lo schema cromatico si ispira a Porto Cervo. Solo la geometria organica degli anni ’60 è scomparsa nel progetto più recente di Vietti. (Giani 2002)
1.5. Porto Cervo Centro – Modelli per l’urbanistica e l’architettura
Prima di descrivere il fulcro centrale del paese progettato da Vietti, è utile identificare i suoi modelli architettonici di riferimento.
Per quanto riguarda la collocazione del centro direttamente sul mare, vi è una somiglianza generale con alcune località costiere italiane come Positano, Portofino o Capri. Questi luoghi facevano parte della rete informale delle destinazioni turistiche degli anni ’60, descritta nel Capitolo 1. Si tratta di paesi situati su ripidi pendii costieri, che complessivamente formano insiemi architettonici topografici. Un elemento centrale di Portofino si riflette anche nel centro di Porto Cervo: la baia si restringe verso il cuore del paese, dove il fondale marino si trasforma gradualmente nella passeggiata. Tuttavia, le case verticali di Portofino, con le loro strette finestre allungate, hanno probabilmente esercitato un’influenza limitata sul progetto della Costa Smeralda.
In Positano e nell’architetturalmente simile Capri si trovano più affinità. Vietti indicò il porto di Marina Grande a Capri come il modello architettonico del suo progetto. Marina Grande è costruita con una maggiore densità e una geometria più rigida rispetto a Porto Cervo, ma alcuni elementi del vecchio villaggio di pescatori italiano si ritrovano nel progetto della Costa Smeralda. Come a Porto Cervo, gli edifici di Marina Grande si trovano direttamente sul mare, con solo una stretta passeggiata davanti alla prima fila di case. Gli edifici del porto presentano spesso file di archi alla base. Le abitazioni non si trovano solo su un pendio ripido, ma formano anche topografie costruite, un elemento chiave del progetto di Porto Cervo. Scalinate corrono lungo le facciate fino ai piani superiori, e terrazze al secondo piano sono sostenute da arcate al primo piano. Anche la colorazione trova corrispondenze: gli archi presentano spesso un bordo bianco dipinto su una facciata rossa o terrosa. Nella parte alta del paese di Capri, nel quartiere medievale, esistono porticati coperti simili a quelli che Vietti ha utilizzato nella Sottopiazza.
Oltre alle influenze menzionate della tradizione vernacolare sarda e a un repertorio ampliato dell’architettura rurale del Mediterraneo, Capri sembra essere il modello centrale per Porto Cervo. Anche dal punto di vista del linguaggio architettonico, Capri presenta somiglianze con Vietti e Busiri-Vici. Quest’ultimo progettava coerentemente nello stile dell’architettura mediterranea dell’Italia meridionale, a cui appartiene anche l’isola di Capri.
Un ulteriore riferimento plausibile sarebbero gli edifici della Costa Azzurra, dato che questa regione faceva parte della stessa rete turistica. Inoltre, uno degli obiettivi dichiarati del consorzio era quello di “creare una nuova Costa Azzurra”. (43. André Ardoin viveva a Parigi. Lui e l’Aga Khan trascorrevano dichiaratamente le vacanze sulla Costa Azzurra prima di coinvolgere, probabilmente, il francese Jacques Couëlle per il progetto in Italia). Tuttavia, il porto storico di Saint-Tropez, con le sue case affiancate e uniformi che formano una facciata continua, non ha analogie con Porto Cervo. Anche le costruzioni moderne della zona, come il Golf Club di Pierre Chareau o la Villa E1027 di Eileen Gray, rappresentavano piuttosto un’opposizione alla Costa Smeralda. L’architetto probabilmente più influente per l’aristocrazia europea, che si riuniva sulla Costa Azzurra negli anni ’50, era Barry Dierks. Le sue opere, come Villa Trident, tematizzavano l’integrazione nel paesaggio topografico della costa, ma si differenziavano da Porto Cervo per l’uso di forme cubiche e il colore bianco brillante.
Un modello contemporaneo per il progetto del centro di Porto Cervo potrebbe essere stato, quindi, Castelleras-le-Vieux di Jacques Couëlle. Il resort, progettato con un linguaggio scultoreo e organico, si trova su una collina nell’entroterra di Cannes. Data la composizione del consorzio e la somiglianza formale di Castelleras-le-Vieux con tutte le prime costruzioni della Costa Smeralda, è possibile che questo luogo di villeggiatura sia stato una generale, ma non documentata, fonte di riferimento. Couëlle realizzò il piccolo insediamento negli anni ’50 sulla Costa Azzurra; l’architettura sembra essere influenzata principalmente da Gaudì. Couëlle – insieme al suo allievo Antti Lovag, a Pascal Häusermann e ad altri architetti –, continuò a sviluppare questa forma di architettura organica, cioè “naturale” e in armonia con la morfologia umana, anche dopo aver lavorato alla Costa Smeralda, in progetti come Port de la Galère, a sud-est di Cannes, costruito tra il 1968 e il 1979.
Vietti e Busiri-Vici, invece, attenuarono questo elemento organico nei loro progetti successivi. Vietti, ad esempio, nel 1998 progettò Porto San Rocco, un porto turistico che, a parte il linguaggio delle forme organiche, sembra essere una copia in versione geometrica di Porto Cervo: la Sottopiazza con un porticato a livello del mare e la Soprapiazza, fiancheggiata da edifici terrazzati le cui facciate erano caratterizzate da logge semicircolari su più piani. Busiri-Vici, invece, mantenne negli anni successivi la sua organizzazione planimetrica fondamentale, basata su un nucleo geometrico con margini più morbidi.
Oltre all’architettura organica, una componente importante del centro di Porto Cervo è l’uso della topografia integrata negli edifici stessi (si veda su entrambi i temi anche il Capitolo 2). L’idea che gli edifici formino una topografia al loro interno deriva da un lato da riferimenti rurali e dall’altro riflette lo spirito architettonico del tempo. Ad esempio, Giancarlo De Carlo costruì nel 1963 la “Colonia Enel” sulla costa di Riccione. Questo edificio, situato direttamente sul mare al termine di una densa area costiera, facente parte del distretto turistico di Rimini, presenta somiglianze con il centro di Porto Cervo per impostazione e volumetria. La struttura, con una figura articolata in pianta e sezione, crea un cortile terrazzato orientato con due ali rivolte verso il mare. L’edificio stesso, attraverso scale e terrazze, offre un’architettura percepibile topograficamente. Come per Vietti e gli altri due fondatori del comitato architettonico, anche i riferimenti di De Carlo attingono all’architettura vernacolare. Tuttavia, nell’espressione architettonica, i progetti di De Carlo sono più astratti e possono essere attribuiti al Brutalismo. Allo stesso modo, i progetti topograficamente simili di Aldo van Eyck, nel loro linguaggio formale sono stilisticamente agli antipodi rispetto al centro di Porto Cervo realizzato da Vietti.
1.6. Porto Cervo Centro – Il nucleo saliente
Il primo elemento pubblico di Porto Cervo è il centro progettato da Vietti, un complesso architettonico che include un hotel e una piazza pubblica. Questo rappresenta il modello per lo sviluppo successivo del villaggio principale della Costa Smeralda. Gli spazi pubblici successivi si sono ispirati nella disposizione spaziale e nell’espressione architettonica a questa prima realizzazione.(50)
(50. La denominazione degli spazi pubblici a Porto Cervo non è univoca. Oltre alla piazza del primo centro, composta in realtà da due piazze, esiste dal 1976 una piazza nel più recente Porto Cervo Marina. Come “centro” viene talvolta indicata la piazza di Vietti, talvolta quella del Porto Cervo Marina, o uno dei due porti. Per distinguere i due porti, il primo è spesso chiamato Porto Cervo Vecchio, ma anche qui esistono diverse denominazioni. In alcuni documenti ufficiali è chiamato Molo Est ed è parte della Marina complessiva. Il nuovo porto, invece, è a volte chiamato Porto Cervo Marina Nuova. In alcuni documenti, i due poli sono indicati come Porto Cervo Villaggio e Villaggio Marina.
Dopo aver considerato tutte le combinazioni di nomi e sulla base delle prime denominazioni, questa ricerca utilizza le seguenti definizioni per Porto Cervo:
-
La prima realizzazione di Vietti è chiamata Porto Cervo Centro, con la piazza associata suddivisa in Soprapiazza e Sottopiazza.
-
Il primo porto, adiacente al centro di Vietti, è chiamato Molo Est.
-
Il porto successivo è chiamato Porto Cervo Marina, e la piazza principale con gli edifici circostanti è definita Centro Marina.)
La piazza si trova alla fine di una piccola baia naturale e si apre semicircolarmente verso il mare. Sul lato terra è racchiusa da un complesso di edifici a più ali. A est è affiancata dalla testata dell’hotel Cervo, mentre a sud e a ovest da una lunga ala di case a corte allineate, che al piano terra ospitano negozi e ai piani superiori appartamenti. Come negli hotel Romazzino di Busiri-Vici e Cala di Volpe di Couëlle, anche il nucleo principale di Porto Cervo crea un proprio paesaggio topografico. Inoltre, il complesso architettonico ha una pianta simile a una girandola, dove il volume centrale non è una torre ma un cortile che costituisce il fulcro dell’hotel.
Lo spazio pubblico si sviluppa su due livelli. La parte superiore, la Soprapiazza, è situata su un basamento a un piano tra il livello della strada e quello del mare. La piazza, di forma organica, si estende lungo la costa esistente e misura circa 70 metri di lunghezza e 20 di profondità, dalla balaustra al corpo degli edifici. Sul lato nord-est, verso il mare, si trova la terrazza esterna del ristorante Il Grillo, coperta da una pergola. Dalla piazza si sviluppa un paesaggio terrazzato, con livelli che salgono verso la collina attraverso il corpo degli edifici e scendono verso il mare con piccole terrazze e scale che si integrano organicamente con la geometria della piazza.
Sotto il complesso architettonico e la Soprapiazza si trova la Sottopiazza, uno spazio coperto e labirintico. Tre scale collegano i due livelli: una sulla piazza, una nel cortile principale dell’ala commerciale e una sotto l’hotel Cervo. Nei primi anni, gli spazi della Sottopiazza ospitavano negozi per le necessità quotidiane e il pub “Red Lion”. Lo spazio principale della Sottopiazza è un porticato arcuato che si affaccia sulla baia e funge anche da base per la Soprapiazza. Questo porticato curvilineo si apre su una piccola spiaggia, dalla quale parte un pontile a Y in legno.(51. Secondo Enzo Satta tra i negozi figuravano un negozio di alimentari, un negozio di articoli per la casa, dove venivano venduti anche i prodotti Cerasarda, e un negozio di accessori elettronici).
Il centro include più spazi pubblici indipendenti: oltre alla Soprapiazza, la strada commerciale lungo l’ala degli edifici e i cortili interni collegati dai portici rappresentano un secondo nucleo centrale. La Sottopiazza, con i negozi, il caffè e il porticato coperto, costituisce una terza zona pubblica autonoma. Questa disposizione multipolare caratterizza non solo il centro, ma anche l’intera struttura della Costa Smeralda.
Il connubio tra paesaggio e architettura
I corpi che si diramano dal cortile quadrato dell’Hotel Cervo ricordano, nella loro forma planimetrica, delle morene allungate. I piani sono composti da spazi morbidi, simili a lastre rocciose. L’espressione formale architettonica deriva, da un lato, dagli elementi rurali sardi e, dall’altro, nella sua espressione e materializzazione, ricorda le ville di Vietti. Tuttavia, nel centro di Porto Cervo, la realizzazione di un’architettura topografica, che si sviluppa su innumerevoli livelli, è più marcata rispetto alle sue residenze private.
Anche la natura è integrata nel progetto: aiuole dalle forme morbide accompagnano i vari livelli. Quelle più basse si trovano a livello della spiaggia, mentre sulla Soprapiazza incorniciano una terrazza sopraelevata. (52. Le aiuole erano presenti dal 1964, ma inizialmente in parte a livello del suolo). Negli anni ’70, tutte le aiuole furono completate con muretti bassi.Lungo la strada commerciale, invece, sono distribuite in punti strategici, spesso in prossimità delle pareti degli edifici. Numerosi porticati con robuste colonne rinforzate e basi in granito creano una connessione fluida con il paesaggio circostante.
Le travi in legno non levigato sono presenti in tutto il centro: sono utilizzate per i parapetti, per le pergole sulle terrazze e come elementi decorativi sotto i soffitti, contribuendo a creare un’atmosfera calda e naturale. Per integrare ulteriormente gli edifici nel paesaggio sardo, Vietti non si è limitato al bianco delle sue prime ville, ma ha scelto anche tonalità rosa e marroni per alcune facciate. Questa colorazione si ritrova anche nelle costruzioni contemporanee di Sa Conca di Busiri-Vici e Cala di Volpe di Couëlle.
Come per le ville di Vietti, anche nel centro di Porto Cervo la tecnologia è stata il più possibile nascosta. Tutti i cavi sono stati inglobati nelle pareti e spesso sono state create nicchie intonacate per nascondere anche le luci. Le superfici pubblicitarie all’esterno delle vetrine erano vietate. Così, è stato creato un luogo che, per il visitatore, non è facilmente inquadrabile né temporalmente né architettonicamente.
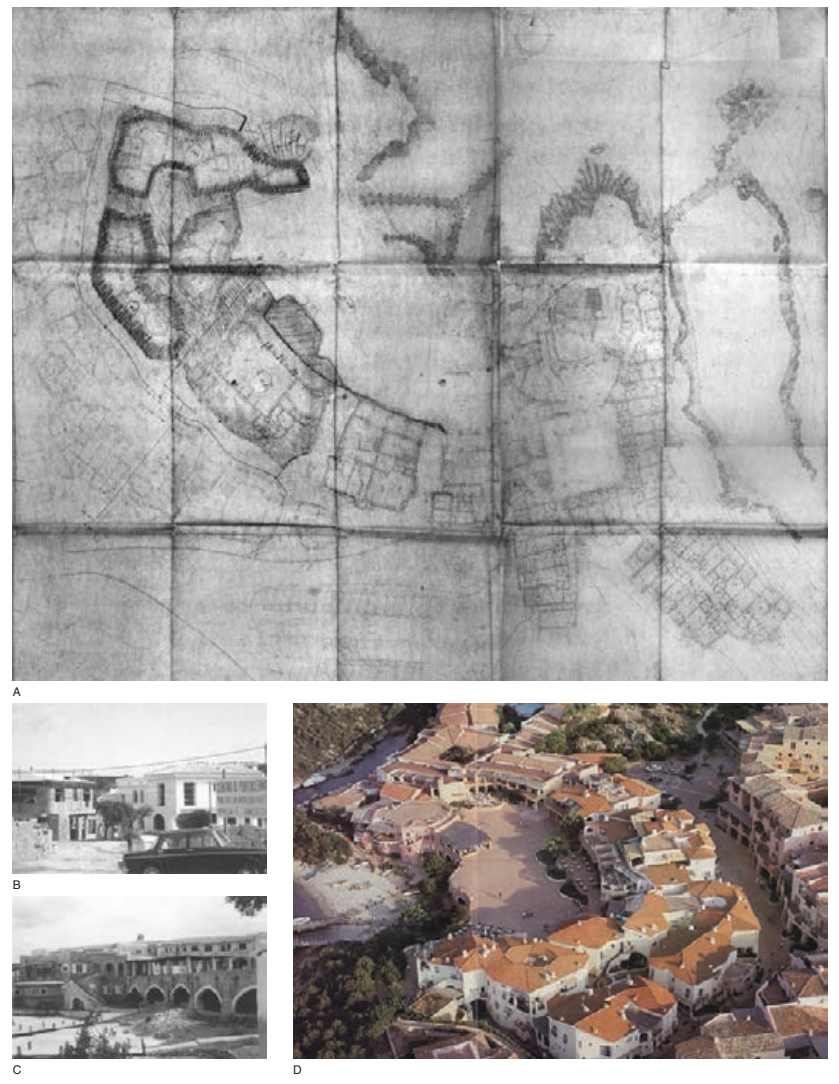
A. Il piano del 1964 del centro di Porto Cervo, con l’Hotel Cervo, le ali adiacenti con negozi e appartamenti, e la Soprapiazza. (Archivio Enzo Satta)
B. Il cantiere del centro di Porto Cervo visto dalla strada interna. Foto probabilmente del 1963. (Gerlat 2006, fig. 20)
C. Il centro visto dal lato costiero durante la fase di completamento, probabilmente nel 1963. (Gerlat 2006, fig. 22)
D. Una vista aerea del centro di Porto Cervo nel 1979. L’Hotel Cervo si trova in alto nell’immagine. La piazza e gli edifici adiacenti seguono la linea costiera preesistente. All’estrema destra dell’immagine si vede la seconda ala, anch’essa progettata da Vietti ma costruita solo nel 1979. (Costa Smeralda Magazine, 1980)
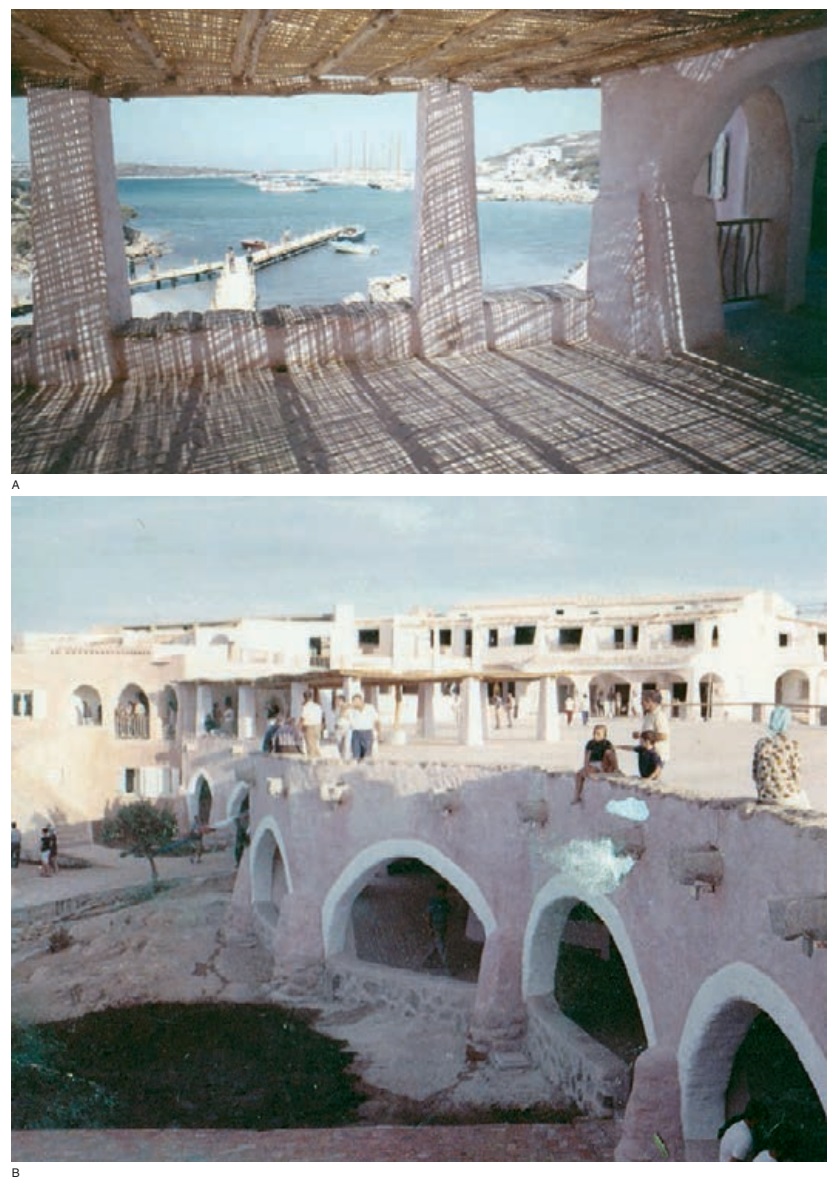
A. La terrazza di Il Grill, coperta da una pergola. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
B. Il centro poco dopo il completamento. L’arcata a volte della Sottopiazza forma la base della Soprapiazza. A sinistra nell’immagine, il promontorio roccioso costiero che ha dato forma alla struttura verso il mare. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
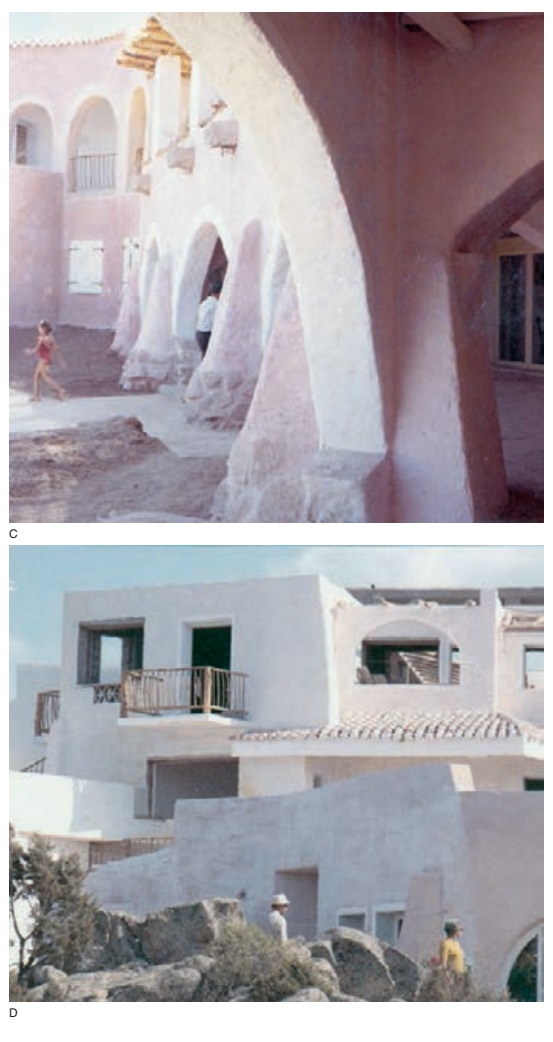
C. Il portico col negozio di Cerasarda, gli accessi alle ulteriori aree della Sottopiazza e il collegamento diretto alla spiaggia costituiva uno spazio pubblico centrale a sé stante. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
D. Il lato nord-est del centro di Porto Cervo. La salita alla Soprapiazza avviene tramite una scala incastonata tra l’architettura e le rocce esistenti. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
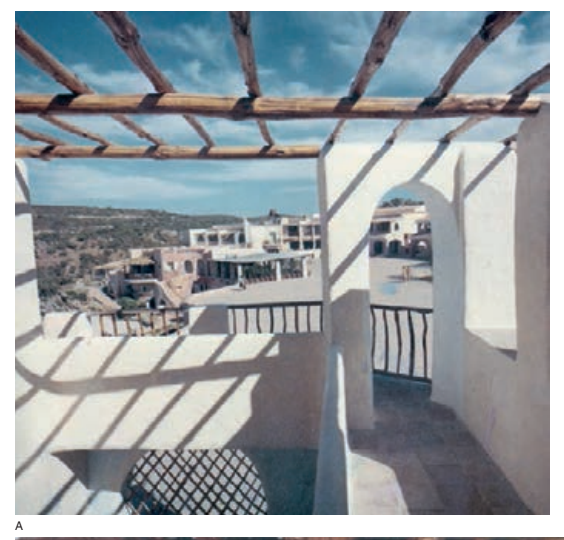

A. Legni non lavorati accompagnano l’architettura di Porto Cervo su tutti i livelli. Foto scattata tra il 1964 e il 1966. (Archivio Enzo Satta)
B. Il cortile dell’Hotel Cervo. Foto scattata tra il 1964 e il 1966. (Archivio Enzo Satta)
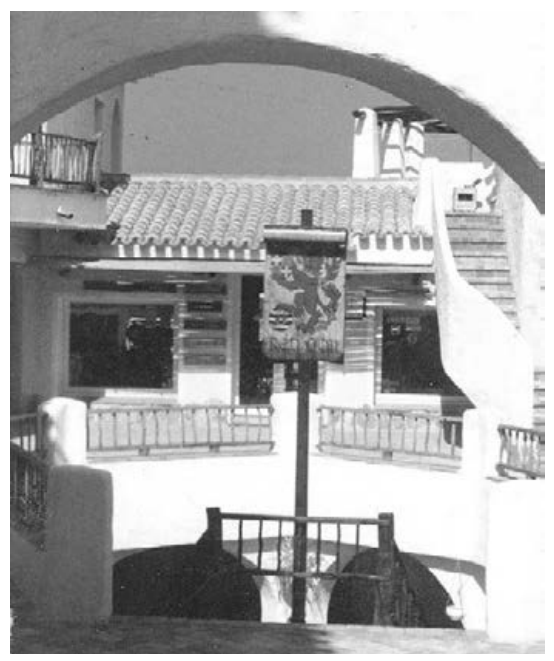
A. Un collegamento tra i due livelli della piazza si trova nel cortile più grande. Nei primi anni, l’insegna del pub Red Lion spuntava dalla Sottopiazza verso l’alto. Foto scattata tra il 1964 e il 1966. (Archivio Enzo Satta)
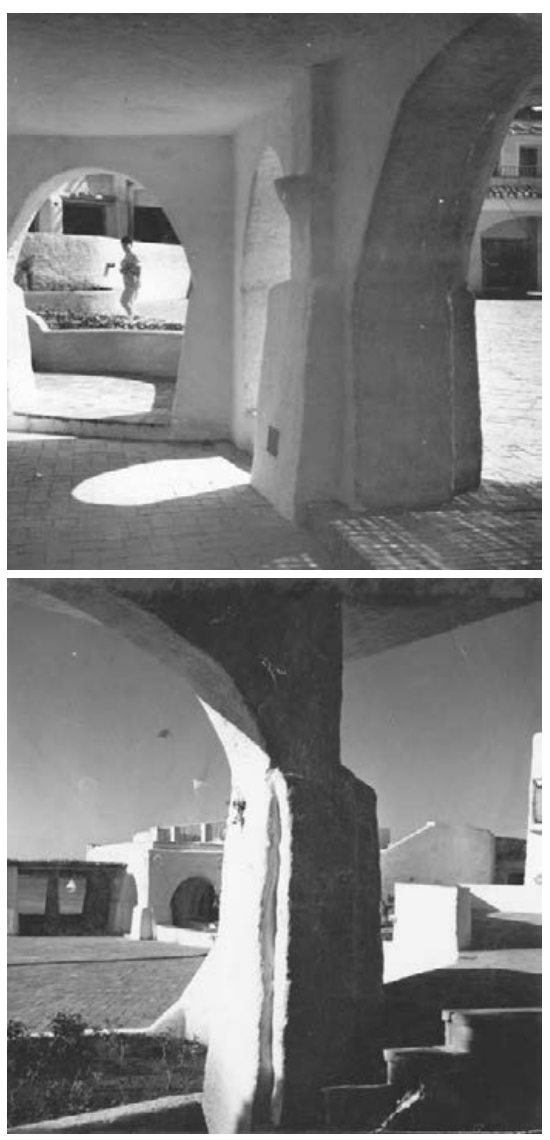
A. La Soprapiazza, che degrada lateralmente verso il basso, con lampade integrate. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
B. Le aiuole sono state integrate nell’architettura e accompagnano i visitatori su tutti i livelli. Qui una vista della Soprapiazza. Foto probabilmente del 1964. (Archivio Enzo Satta)
2. 1969-1983 – IL MASTERPLAN DI SDDA
Come già accennato, dopo i primi anni divenne chiaro che la pianificazione generale della Costa Smeralda necessitava di una revisione. La progettazione stava iniziando a divergere, principalmente a causa della vastità del territorio e del principio di adesione aperta del Consorzio. Inoltre, l’organizzazione urbanistica di base e il coordinamento tra i diversi progettisti furono fattori che resero la situazione più complessa. L’Aga Khan trasse le dovute conclusioni dalle difficoltà emerse nei primi anni e, nel 1967, coinvolse gli urbanisti e paesaggisti della società statunitense SDDA per integrare e armonizzare il progetto della Costa Smeralda al fine di darle una struttura complessiva coerente.
SDDA, allora come oggi, era una società che combinava la pianificazione paesaggistica classica con l’integrazione di aspetti economici e relazioni politiche. (54. SDDA è l’abbreviazione degli architetti paesaggisti Sasaki, Dawson, De May e infine A sta per Associates. Vedi anche il capitolo 1). Con sede principale a Watertown, Massachusetts, SDDA era stata fondata da Hideo Sasaki, professore di architettura del paesaggio ad Harvard dal 1953. Sasaki collaborò con architetti come Josep Lluis Sert, SOM, I.M. Pei e Eero Saarinen. L’Aga Khan conosceva Morgan Wheelock, un collaboratore di SDDA, dai suoi studi a Boston, dove Wheelock era stato coinquilino di suo fratello Amyn Khan. Wheelock fu nominato responsabile del progetto SDDA per la Costa Smeralda e divenne il punto di riferimento per le comunicazioni con l’Aga Khan. (51. Enzo Satta ipotizza che il responsabile del progetto Morgan Wheelock fosse coinvolto come consulente alla Costa Smeralda già dal 1961. Questa supposizione sembra plausibile per via delle connessioni personali, ma non esistono documentazioni a riguardo. In ogni caso, fin dall’inizio l’attenzione era focalizzata sulla pianificazione paesaggistica).
Gli urbanisti di SDDA avevano il compito di sviluppare un Masterplan rivisto, che fosse vincolante per tutti i membri del comitato architettonico. SDDA lavorò alla Costa Smeralda per oltre un decennio, aprendo un ufficio locale per collaborare più efficacemente con il comitato.
Il primo sopralluogo di SDDA alla Costa Smeralda avvenne nel 1967. In quell’occasione, redassero un rapporto preliminare sulle problematiche riscontrate. Utilizzando le mappe topografiche fornite dall’ufficio Bianchi, gli urbanisti analizzarono gli elementi naturali dell’area. Le loro analisi principali si basavano su quattro temi:
- Descrizione generale del territorio e identificazione delle potenzialità per il committente.
- Analisi della morfologia, geologia e topografia con focus sul loro potenziale specifico.
- Studio della qualità visiva e paesaggistica delle diverse aree.
- Inventario della vegetazione e delle risorse idriche, con eventuali proposte di miglioramento. (57. Per un’analisi completa di SDDA, vedi Cappai 2014, pp. 208-229).
Quasi due anni dopo il primo sopralluogo, nel 1969 SDDA presentò un esaustivo rapporto intermedio e un Masterplan (Piano generale) che assemblava le diverse parti del territorio, fino ad allora considerate separatamente, in un insieme coerente. (58. Nel loro rapporto del 1969 emerge che alcuni membri del primo comitato di progettazione si erano consolidati, mentre altri non erano più menzionati. I piani utili per lo sviluppo provenivano da Raimond Martin e Luigi Vietti. Al contrario, i piani di Michele Busiri-Vici erano considerati critici, e Jacques Couëlle era ridotto a una nota marginale: il suo tempo alla Costa Smeralda era già finito e il figlio aveva assunto il suo ruolo).
Anche per la Costa Smeralda i quattro temi sopra citati costituirono la struttura della loro pianificazione, ampliata con considerazioni economiche e urbanistiche. Per questo, diversi esperti furono coinvolti nello sviluppo del piano. (59. SDDA menziona nel suo rapporto il contributo di analisti di mercato, pianificatori regionali, pianificatori territoriali, architetti paesaggisti, architetti e ingegneri).
Dal 1967, SDDA effettuò visite regolari alla Costa Smeralda per valutare le condizioni sul posto. Durante questo periodo avviarono consultazioni preliminari con politici sardi e rappresentanti nazionali della Cassa del Mezzogiorno. Inoltre, elaborarono analisi finanziarie sulle attività turistiche esistenti e previste. Alla fine, svilupparono una strategia di utilizzo del suolo che fosse finanziariamente e organizzativamente realizzabile. (60. Per le analisi finanziarie si collaborò con la società Economics Research Associates di Los Angeles e Washington, D.C. Questa effettuò studi sulle tendenze turistiche e analizzò le strutture di resort comparabili per sviluppare una strategia di marketing per la Costa Smeralda).
I professionisti di SDDA non stravolsero le idee iniziali già elaborate, ma le affinarono e produssero piani più dettagliati, adottando un approccio coerente per tutte le sotto-aree. L’obiettivo era mantenere un linguaggio unificato nella progettazione urbanistica, garantendo coerenza tra paesaggio, infrastrutture, spazi pubblici, percorsi e posizionamento degli edifici nei vari lotti. Questo approccio fornì strumenti di pianificazione più efficaci per soddisfare le priorità dell’Aga Khan.
Furono stabilite regole precise: si decise dove era consentito costruire e si definì che le nuove edificazioni si sarebbero concentrate principalmente attorno ai quattro centri principali, limitando la costruzione nelle aree intermedie. Il Masterplan di SDDA prevedeva sia una guida per lo sviluppo del territorio nei successivi vent’anni, sia una visione per un possibile assetto futuro senza limiti temporali.
Condizione di fondo: efficienza economica
I pianificatori di SDDA stabilirono fin dall’inizio della loro analisi interna due condizioni quadro fondamentali: la necessità di garantire la redditività del progetto e la valorizzazione delle qualità paesaggistiche. Scrissero che il Consorzio dell’Aga Khan richiedeva la strategia di sviluppo più redditizia per il resort. (61. Il rapporto interno in possesso di questa ricerca è indirizzato da Morgan Wheelock all’Aga Khan. Anche nei resoconti di Riccardi, l’Aga Khan emerge come una figura di leadership pressoché solitaria. Tutto indica che guidasse la pianificazione generale e si confrontasse con gli altri membri del consorzio per i contenuti).
Tuttavia, ciò doveva essere ottenuto senza compromettere le qualità del paesaggio. Questo approccio comportava dei compromessi, ma nei casi di dubbio si dava priorità alla conservazione del paesaggio.
Dal punto di vista economico, il progetto era già considerato un successo: le vendite di terreni e ville costruite, così come le prenotazioni degli hotel, avevano raggiunto il massimo livello possibile. (63. Questa è l’affermazione di SDDA nello studio interno Design and Planning Summary, Vol. I, 1969, Introduzione. I media internazionali valutavano diversamente la situazione: nel 1966, il Der Spiegel scrisse che delle 8000 parcelle solo 100 erano state vendute. Tuttavia, probabilmente il consorzio era soddisfatto delle vendite, poiché la pianificazione delle prime due fasi era a lungo termine e copriva i successivi 20 anni. Non è possibile giungere a una conclusione definitiva. Vedi anche: Italia. Crimini. L’invidia dei pastori 1966).
Le dimensioni del progetto possono essere illustrate dal piano per le stanze d’albergo: SDDA propose di ampliare le 355 camere esistenti nel 1968 a oltre 2000 entro il 1975.
Il progetto Costa Smeralda fu concepito per integrarsi con l’economia sarda. Porto Cervo, in particolare, fu pianificato come una parte integrante dell’economia locale. Fin dall’inizio furono fondate diverse imprese che avrebbero operato principalmente per la Costa Smeralda, come la Cerasarda. SDDA analizzò le imprese esistenti, fornendo raccomandazioni per ottimizzazioni e nuove fondazioni.
Probabilmente, prima dell’ingresso degli urbanisti paesaggistici, non era stata condotta un’analisi di mercato completa. Le aziende e le strutture venivano create progressivamente in base alle necessità immediate. Nel 1968, SDDA rilevò che in tutte le aree del progetto esistevano già grandi ville, per un totale di 40 solo nella zona di Porto Cervo. Inoltre, per i turisti orientati a un contesto urbano, furono costruiti i primi appartamenti a Porto Cervo. Gli hotel a cinque stelle esistenti (quattro in totale) erano già operativi. Secondo SDDA, mancavano tuttavia edifici meno esclusivi, come case più piccole e complessi di appartamenti, da costruire rapidamente per garantire la sostenibilità economica del progetto. (66. I documenti interni descritti da SDDA mostrano che erano state pianificate anche case per turisti con redditi più bassi. Questo si rifletteva anche nella comunicazione esterna: nei servizi televisivi dell’epoca, l’Aga Khan menzionava l’intenzione di costruire ville meno costose e lussuose).
Prevedevano una crescita continua del mercato turistico, con una crescente quota destinata al turismo balneare e insulare, come quello della Costa Smeralda. Rispetto ad altri resort mediterranei, la Costa Smeralda aveva il territorio e le strutture necessarie per competere vantaggiosamente a livello internazionale. Ciononostante, SDDA sottolineò che per sfruttare appieno questo potenziale era essenziale estendere la breve stagione turistica di due mesi. Questo portò il Consorzio a organizzare eventi come i rally primaverili e le regate autunnali. (67. L’estensione della stagione turistica era economicamente necessaria per ampliare il bacino di utenza del resort e incrementare le vendite. Cfr. Design and Planning Summary, Vol. I, 1969, p. B-5.)
Entro il 1969, la popolazione della Costa Smeralda era composta principalmente da proprietari di ville e ospiti degli hotel a cinque stelle. SDDA raccomandò di mantenere queste categorie come parte fondamentale del mercato, ma suggerì di rendere la località accessibile anche a visitatori temporanei di fascia economica inferiore. Furono proposti nuovi hotel e ville a prezzi più contenuti, oltre al miglioramento dei collegamenti aerei e marittimi. A lungo termine, si consigliava di rafforzare la promozione esterna, pubblicizzando solo ciò che sarebbe stato realmente disponibile nella stagione in corso o in quella successiva. (69).
(69. Ecco una sintesi di tutte le aziende e società che, secondo le informazioni attuali, sono state fondate per la Costa Smeralda. I numeri e le informazioni riguardano, salvo diversa indicazione, il periodo compreso tra il 1995 e il 1997 e sono tratte dalla seguente brochure: Il Bilancio sociale dell’impresa Costa Smeralda 1997.
Agrisarda: La società è stata costituita con l’obiettivo di preservare l’equilibrio ecologico e proteggere la vegetazione naturale della Costa Smeralda. Su richiesta, si occupava della progettazione e manutenzione dei giardini. Nel 1979, l’azienda è stata incorporata nel Servizio Ambiente Costa Smeralda, che esiste ancora oggi e ha assunto ulteriori compiti come la manutenzione e la gestione delle infrastrutture: condutture, fognature, impianti di depurazione, illuminazione, parcheggi, spiagge e pulizia delle strade. Successivamente, ha assunto anche le funzioni dei vigili del fuoco. Nel 1995, il Servizio Ambiente Costa Smeralda aveva un fatturato di 5 miliardi di lire e 79 dipendenti.
Alimentaria Sarda: L’azienda si occupava della produzione e vendita di prodotti alimentari sardi. I supermercati contribuivano a introdurre i prodotti sardi nel circuito della Costa Smeralda. I negozi di alimentari esistono ancora oggi e hanno sede a Olbia. Nel 1978 c’erano tre supermercati di Alimentaria Sarda, situati a Porto Cervo, Porto Cervo Marina e Abbiadori. Nel 1990, i supermercati erano sei.
Alisarda: Alisarda è stata la prima compagnia aerea nazionale finanziata esclusivamente da privati. La sede principale era presso l’aeroporto «Olbia-Costa Smeralda». Fondata nel 1963, insieme ai primi edifici della Costa Smeralda, aveva trasformato una vecchia pista di ghiaia vicino a Olbia, utilizzata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alisarda divenne la più importante compagnia aerea privata in Italia e un datore di lavoro rilevante in Sardegna. Oggi si chiama «Meridiana SPA». Nel 1995, la flotta ha trasportato 2.500.000 passeggeri, di cui 1.250.000 da e verso la Sardegna. I ricavi del 1995 ammontavano a 512 miliardi di lire, con 1.450 dipendenti, di cui 1.060 in Sardegna.
Biancasarda: Questa azienda forniva e lavava biancheria. Fondata dall’Aga Khan insieme a due imprenditori francesi, non serviva solo gli hotel della Costa Smeralda, ma anche l’intera Gallura, prevedendo una crescita costante del settore turistico. Tuttavia, a causa di rapporti commerciali non ideali tra i soci, l’Aga Khan vendette l’azienda a imprenditori di Olbia.
Cantieri Costa Smeralda: L’azienda si occupava della manutenzione, riparazione e ristrutturazione del porto. Nel 1995, i ricavi erano di 9 miliardi di lire, con 80 dipendenti.
Cerasarda SPA: Fondata per fornire piastrelle di ceramica per la costruzione e l’arredamento della Costa Smeralda, l’azienda ha colmato una lacuna nell’artigianato sardo. La manifattura fu costruita alla periferia di Olbia. Nel 1995, i ricavi erano di 5,7 miliardi di lire, con 52 dipendenti.
Costa Smeralda Hotels: Fondata nel 1964 con 25 dipendenti, gestiva strutture alberghiere di lusso come il Cala di Volpe, il Romazzino, il Pitrizza e il Cervo. Nel 1995, CIGA Hotels Italia SPA (successore di Costa Smeralda Hotels) registrava ricavi di 62,5 miliardi di lire e impiegava 849 persone.
Geasar SPA: Questa società gestiva l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda e i relativi servizi. Nel 1995, aveva ricavi di 6,5 miliardi di lire e 42 dipendenti.
Grasseto: Sebbene non fosse direttamente fondata dal Consorzio, fu fondamentale per il progetto. Grasseto, azienda di costruzioni romana, costruì edifici con subappaltatori sardi.
Immobiliare Costa Smeralda: Gestiva le vendite immobiliari del Consorzio, occupandosi anche di locazioni e rivendite.
Consorzio Costa Smeralda: Fondato nel 1962, coordinava lo sviluppo armonioso della zona. Nel 1997 contava 3.200 membri.
Marinasarda: Gestiva il porto turistico di Porto Cervo, con ricavi di 10 miliardi di lire e 81 dipendenti nel 1995.
Pevero Golf Club: Gestiva il famoso campo da golf progettato da Robert Trent Jones. Nel 1995, i ricavi erano di 3,1 miliardi di lire, con 38 dipendenti.
STEGCS: Responsabile della progettazione e realizzazione delle infrastrutture tecniche, come camminamenti e moli.
Servizio Antincendio: Inizialmente un servizio antincendio privato, in seguito integrato nel Servizio Protezione Ambiente Costa Smeralda SRL.
Servizi Idrici Costa Smeralda: Gestiva un acquedotto di 72 km che forniva annualmente 1.700.000 m³ d’acqua.
Servizi Medici Costa Smeralda: Centro medico inaugurato nel 1980, finanziato da eventi di beneficenza, con un fatturato di 480 milioni di lire nel 1995.
Servizi Vigilanza Costa Smeralda: Garantiva la sicurezza dell’area e dei singoli edifici. Nel 1995, aveva ricavi di 2,9 miliardi di lire, con 62 dipendenti.
Yacht Club Costa Smeralda: Promuoveva la vela e organizzava eventi come il Sardinia Cup. Nel 1997 contava 7 dipendenti.
A. Il centro di produzione Cerasarda nasce alla periferia di Olbia, dove esiste ancora oggi. Ecco una foto del 1963, quando le prime ceramiche dipinte a mano furono create dalle mani dei neo-qualificati sardi. (Gerlat 2006, fig. 30)
B – D. Esempi di prodotti Cerasarda presso la sede commerciale di Porto Cervo. Il piccolo negozio era situato nel porticato del Sottopiazza. Foto del 1966, fotografo Josué Ito. (Archivio Enzo Satta)
2.1. Piani per fasi
Il Masterplan del 1969 di SDDA prevedeva tre fasi di sviluppo. La prima fase copriva cinque anni, la seconda quindici anni, seguita da una terza fase finale senza limiti temporali definiti.
Nuove Aree
I piani fase si basavano su una nuova articolazione di aree creata da SDDA nel 1968, in risposta alle normative introdotte dalla Sardegna per limitare la densità edificatoria. SDDA adattò i propri piani a queste linee guida, sfruttandole come uno strumento vincolante anche all’interno del Consorzio. Il concept principale rimase quello di un resort costituito da diversi “villaggi”, organizzati intorno ai centri di Pitrizza, Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe.
La nuova predisposizione delle zone seguiva la topografia collinare del territorio, abbandonando le suddivisioni lineari utilizzate dai pastori locali, pur integrando in alcuni casi brevi tratti dei vecchi muretti a secco. SDDA pianificò aree di maggiore densità edilizia lungo la costa, rispettando comunque la densità massima consentita dalle normative, pur senza mai prevedere di sfruttarla completamente. Lungo la costa, la raccomandazione di non edificare nella zona costiera con la massima densità in nessun caso e in nessun momento è sottolineata due volte.
SDDA presentò due mappe per illustrare la densità effettiva desiderata: una con la densità ufficialmente permessa, già ridotta dalle normative del 1968, e una seconda con la densità mirata, che la Costa Smeralda avrebbe raggiunto al completamento delle tre fasi di pianificazione. Questa densità corrispondeva anche al masterplan previsto per la terza fase.
Prima Fase 1968-1973
Nella prima fase di sviluppo iniziò una gestione concreta delle costruzioni e furono pianificate le infrastrutture e i collegamenti. In un primo momento si trattò di riorganizzare il quadro frammentario della distribuzione edilizia esistente. Si decise di densificare i centri intorno a Porto Cervo, Romazzino e Cala di Volpe e di sviluppare l’area ancora non edificata di Pevero Golf. I quattro centri indipendenti dovevano essere messi in relazione tra loro. Dal piano quinquennale emergeva l’immagine finale desiderata: le costruzioni si sarebbero integrate in un insediamento quasi continuo, organizzato organicamente attorno ai centri, con un diradamento tra di essi.
La prima fase includeva anche modifiche generali ai volumi edilizi previsti: lungo la costa l’altezza delle costruzioni doveva essere ridotta per migliorare la vista sul mare, mentre nei centri, come il porto di Porto Cervo, erano previste costruzioni più alte con appartamenti di proprietà. Porto Cervo veniva definito come il cuore della Costa Smeralda, il principale insediamento di una catena poco densa. Qui si prevedeva la costruzione di negozi, un cinema, nightclub, campi da tennis, piscine e edifici di servizio, oltre ad ulteriori edifici per le vacanze.
Agli altri centri venivano attribuite caratteristiche specifiche per conferirgli una propria identità. Cala di Volpe avrebbe avuto una vocazione sportiva, con il vicino campo da golf integrato da campi da tennis e altre strutture sportive. Pevero Golf era concepito come località per la breve stagione estiva, focalizzata sui suoi lidi. Pitrizza doveva essere un luogo di ritiro, destinato soprattutto alle coppie. A Liscia di Ruja, nella seconda fase, si prevedeva un altro grande centro con negozi, simile a quello di Porto Cervo. Le abitazioni per i dipendenti non dovevano essere costruite come “ghetti” concentrati, ma distribuite tra ville e appartamenti, per integrarle negli insediamenti.
Oltre al quadro generale della pianificazione, SDDA fornì raccomandazioni per misure da attuare immediatamente. Queste includevano principalmente modifiche alle infrastrutture, come il posizionamento meno visibile dei parcheggi, interventi urgenti di manutenzione e la pianificazione tempestiva di tutte le attività necessarie per una vita funzionale.
Seconda Fase 1973-1988
Nella seconda fase, della durata di quindici anni, si puntava a completare ulteriormente l’immagine del progetto. Essa includeva la pianificazione generale dell’uso del territorio, il miglioramento dei collegamenti e l’espansione delle aree ricreative. Presso Cala di Volpe si progettava un piccolo villaggio simile a Porto Cervo. A sud di esso si prevedeva lo sviluppo di Razza di Juncu.
Nei punti in cui le strade si intersecavano con le nuove aree edificate, si stabilì una fascia di rispetto di circa 100 metri. Solo nei centri la strada avrebbe attraversato aree più densamente edificate, per creare un’esperienza di guida simile a quella di una strada di campagna che attraversa vari villaggi. Inoltre, le strade vennero progettate in modo tale che, una volta lasciati i piccoli centri, si potesse vedere principalmente natura “intatta”.
Terza Fase dal 1988
Nella terza fase, a partire dal 1988, l’obiettivo era definire il quadro complessivo, stabilire un massimo per le edificazioni e fornire linee guida per il controllo a lungo termine del territorio. Questa fase non aveva un termine temporale definito, ma prevedeva uno sviluppo graduale della Costa Smeralda fino a farla diventare un luogo redditizio e vivace in Sardegna.
L’area avrebbe dovuto essere frequentata non solo per un mese all’anno, ma per un periodo più lungo, dalla primavera all’autunno, per oltre sei mesi. Gli insediamenti meno grandi si sarebbero disposti nel piano finale lungo la strada verso la costa, come piccole perle infilate su un filo. L’intero insediamento avrebbe così formato un insieme organico, in cui le aree costruite e non costruite sarebbero state collegate attraverso la rete stradale.
A. Rappresentazione della densità di popolazione interna auspicata. Un punto rosso rappresenta 25 abitanti. (Design and Planning Summary, Vol. II, 1969, p. 40)
B. Rappresentazione della densità di popolazione massima ufficialmente consentita nel 1968. Un punto rosso rappresenta 25 abitanti. (Design and Planning Summary, Vol. II, 1969, p. 39)
C. Proposta della SDDA per la zonizzazione, tenendo conto delle nuove normative del 1968 sulle volumetrie massime consentite. (De ign and Planning Summary, Vol. II, 1969, p. 38)
A. Nella prima fase di sviluppo, dal 1969 al 1973, si prevedeva di iniziare a mettere in relazione i vari centri. Inoltre, Porto Cervo doveva essere sviluppato come centro principale funzionante. (Design and Planning Summary, Vol. II, 1969, p. 31)
B. Durante la prima fase di pianificazione fu costruito, ad esempio, il grande porto di Porto Cervo Marina. Nella foto, l’inaugurazione del porto nel 1976. L’Aga Khan è seduto in prima fila al centro, con alla sua sinistra l’allora moglie. (Archivio Enzo Satta)
C. Il nuovo porto di Porto Cervo Marina appena costruito. Sullo sfondo si trova il pendio edificato da Busiri-Vici. Maggiori dettagli sull’architettura di Busiri-Vici nel Capitolo 2. Foto probabilmente del 1976. (Archivio Enzo Satta)
A. La seconda fase, a partire dal 1973, prevedeva la realizzazione di villaggi presso Pevero Golf, Cala di Volpe e Razza di Juncu. Fino ad oggi, è stato realizzato solo il piccolo centro presso Pevero Golf. (Design and Planning Summary, Vol. II, 1969, p. 32)
B. Nella terza fase, a partire dal 1988, la Costa Smeralda doveva diventare un insieme organico, con aree a diversa densità edilizia e zone non edificate. (Design and Planning Summary, Vol. II, 1969, p. 33)
2.2. Strumenti di Pianificazione – Progettazione del Paesaggio
Nel rapporto intermedio del 1969, SDDA analizzò la natura esistente, le infrastrutture già costruite e la distribuzione degli insediamenti avviati. Sulla base di questa analisi, elaborarono l’immagine complessiva del Piano Fase 3 come obiettivo finale. Per raggiungere tale obiettivo, crearono strumenti di pianificazione per i tre elementi principali del territorio: il paesaggio, le infrastrutture e l’urbanistica, sviluppandoli su diversi livelli di scala e fornendo linee guida per l’attuazione.
La gestione del paesaggio non si limitava alla subordinazione delle costruzioni e delle infrastrutture alla natura, ma includeva anche la progettazione della natura stessa. Oltre alle norme edilizie per gli edifici, furono stabilite regole interne per la pianificazione paesaggistica. Queste comprendevano norme sia per grandi progetti, come la posa di condutture sotterranee, sia per piccoli interventi, fino alla selezione di piante specifiche. SDDA stabilì le prime regole provvisorie(72), le professionalizzò e sviluppò linee guida per la realizzazione e la manutenzione del paesaggio(73).
Il paesaggio esistente doveva essere curato e protetto. Elementi di valore come formazioni rocciose e gruppi di piante vennero preservati, deviando le strade per non danneggiarli e mantenendoli anche nei terreni privati.
(72. Probabilmente, le prime regole paesaggistiche furono formulate in modo piuttosto generale per la conservazione della natura esistente. Questo è un dedotto dai documenti disponibili, poiché il primo regolamento edilizio non è presente in questa ricerca.
(73. Le regole contenute nel regolamento edilizio del 1991 relative al paesaggio derivano chiaramente dalle proposte che SDDA inviò al consorzio nel 1969. Ad esempio, i tipi di rimboschimento e le liste delle piante sono sviluppi delle loro prime proposte. Maggiori dettagli sui tipi di rimboschimento e le liste delle piante sono riportati più avanti in questo paragrafo).
SDDA sviluppò strumenti di pianificazione per la cura del paesaggio su diverse scale.
Pianificazione su scala territoriale
In una scala più ampia, il paesaggio dell’area fu concepito come un’entità unica. Vennero definite zone che dovevano rimanere inedificate e servire come spazi naturali ricreativi, principalmente nelle aree interne e in alcune zone costiere rocciose senza accesso diretto al mare. Circa un terzo di queste aree ricreative era originariamente destinato alla caccia. SDDA prevedeva anche percorsi per cavalli attraverso le aree interne, ma né la caccia né l’equitazione si svilupparono, lasciando queste aree inutilizzate.
Inoltre, fu realizzata una mappa per il rimboschimento a scala dell’intero territorio, con priorità alle zone costiere abitate e lungo le strade, piuttosto che alle aree naturali interne.(74).
(74. Per il rimboschimento, SDDA non collaborò con specialisti degli Stati Uniti, ma con i seguenti uffici e organizzazioni locali: Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (Regione Sardegna e Comune di Sassari), Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Agraria, Ente Trasformazione Fondaria Agraria Sarda, Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (sede centrale a Roma), Flora Sarda (Porto Cervo), Grandi Vivai (un negozio di piante ad Arzachena).
Le strade necessitavano interventi per due motivi:
- Il terreno tagliato per la costruzione delle strade causava smottamenti durante la stagione delle piogge, risolvibili con nuove piantumazioni.
- Gli spazi stradali erano parte integrante del paesaggio visivo, considerati come importanti spazi pubblici del territorio. Il concetto progettuale dei paesaggi stradali era ispirato ai giardini paesaggistici inglesi, dove vaste aree servivano a creare un’immagine ideale del paesaggio.
Le aree intorno alle strade furono rimboschite seguendo linee guida precise, lasciando ampi spazi aperti per rendere visibile la “natura libera”. Per il mantenimento delle aree di rimboschimento mappate, furono sviluppati dettagli esemplificativi per la stabilizzazione dei pendii e la piantumazione di aree spoglie.
Introduzione di nuove piante
Oltre a mantenere e curare la natura esistente, vennero introdotte nuove specie vegetali. Il clima arido, i venti forti e le caratteristiche del suolo avevano creato un paesaggio brullo. SDDA redasse un elenco di piante resistenti e adatte a crescere nel difficile territorio, valorizzandone anche l’aspetto estetico. Queste piante, non originarie della Sardegna, furono selezionate con una strategia variabile per non alterare completamente l’aspetto vegetale e ottenere l’approvazione del Ministero per la Tutela Ambientale italiano.
Tipi di rimboschimento
Rimboschimento Tipo I
Nelle aree più estese della Costa Smeralda, lungo le strade e in altre zone di transizione, si prevedeva l’introduzione di piante autoctone integrate con una singola specie mediterranea non autoctona. Ciò garantiva il mantenimento del carattere principale della vegetazione sarda, mentre la pianta aggiuntiva, più robusta e facile da coltivare, riempiva gli spazi tra gli arbusti autoctoni.
Rimboschimento Tipo II
Nelle quattro aree principali – Porto Cervo, Pevero Golf, Romazzino e Cala di Volpe – si pianificò l’integrazione della vegetazione autoctona con più piante mediterranee a fioritura estiva, creando un ambiente più rigoglioso, floreale e colorato all’ingresso dei centri. Le specie introdotte, come oleandri e magnolie, furono selezionate per mantenere l’armonia con la vegetazione sarda. Le palme, invece, furono vietate (e lo sono tuttora in teoria).
Flora della Costa Smeralda
La combinazione di piante autoctone con specie mediterranee introdotte ha portato alla creazione di una flora specifica della Costa Smeralda. Tra le piante locali elencate da SDDA vi erano:
- Corbezzolo occidentale
- Carrubo
- Ginepro
- Quercia spinosa
- Sughera
- Olivo(76)
- Tamerice
- Rosmarino selvatico
SDDA raccomandò anche l’introduzione di piante fino ad allora assenti in Sardegna, tra cui:
- Eucalipto (solo temporaneamente incluso nella lista) (77)
- Agave
- Acacia (anche questa rimossa successivamente dalla lista)
- Ficus benjamin
- Ibisco
- Oleandro
- Magnolia (aggiunta successivamente alla lista originale)
(76. Nella prima lista di SDDA del 1969, l’ulivo non era presente. Tuttavia, era già stato menzionato nei piani di SDDA del 1969 come una delle piante locali più importanti.
(77. L’eucalipto fu elencato, in collaborazione con le autorità locali, come una pianta adatta al luogo. Probabilmente perché negli anni ’30 era stato piantato nelle zone paludose della Sardegna per assorbire grandi quantità di acqua. Tuttavia, l’eucalipto si rivelò problematico nelle terre aride del nord Sardegna: le sue radici forti danneggiano il suolo roccioso. Fu rimosso dalla lista in breve tempo e successivamente vietato nel regolamento edilizio).
Sul Monte Zoppu, il consorzio creò una densa vegetazione grazie a un primo intervento di rimboschimento, utilizzando la flora caratteristica della Costa Smeralda. In pianura si trovavano fiori selvatici, mentre su un versante della topografia collinare vennero piantate le iconiche querce da sughero autoctone. L’altro lato era costeggiato da una sottile fascia di eucalipti, mentre alle loro spalle furono piantate nuovamente querce da sughero mescolate con pini, più facili da coltivare. Più in alto, la strada attraversava un uliveto. Ai margini del Monte Zoppu fu lasciata intatta la fauna naturale sarda, composta da cespugli di ginestra e ginepro.
Paesaggistica intorno al campo da golf
Un esempio rappresentativo della pianificazione paesaggistica di SDDA è l’area intorno al campo da golf. Qui, l’integrazione tra natura, paesaggio progettato e costruzioni fu realizzata seguendo le idee dei pianificatori. Il campo si trova nella valle tra Cala di Volpe e Pevero Golf ed è stato progettato da Robert Trent Jones Senior. Con le sue 18 buche, i campi si estendono organicamente lungo le colline, circondati da una distribuzione sparsa di ville lungo strade laterali ramificate.(81)
(81). Il complesso attirò attenzione mondiale negli anni ’70, poiché era considerato un esempio perfetto di integrazione nella natura, senza elementi artificiali evidenti. Contemporaneamente, la serie di golf fu ritenuta di qualità particolarmente alta. A Razza di Juncu era prevista una ulteriore area golfistica. Robert Trent Jones Senior progettò campi da golf in tutto il mondo, la maggior parte negli Stati Uniti con un focus a New York. Nei resort citati nel capitolo 1.3.4, progettò campi da golf a Sugarbush (1961), in Florida (1962) e nelle Bermuda (1970).
In generale, le componenti della natura esistente vennero intrecciate con gli elementi costruttivi aggiunti. Le strade seguivano le linee di livello naturali. Gli edifici, spesso costruiti con granito locale, si adattavano alla topografia e venivano integrati con le formazioni rocciose esistenti. Anche le piscine furono progettate in modo da fondersi con il terreno, somigliando alla costa naturale. Questo intreccio fu ulteriormente enfatizzato utilizzando elementi naturali locali. Nei giardini privati, la vegetazione sarda veniva valorizzata, trasformando, ad esempio, un cespuglio di ginestra isolato in una scultura. Il rosmarino selvatico veniva raccolto in rigogliosi cespugli, come fossero piccole isole floreali nel giardino. I massi di granito, scolpiti dal tempo, segnavano incroci stradali, ingressi agli edifici o dettagli delle ville.(82)
(82. Le rocce venivano utilizzate in Costa Smeralda per accentuare situazioni particolari. Oggi il loro utilizzo è diffuso in tutta la Sardegna (ne parleremo più approfonditamente nel capitolo 4).
A. La SDDA elaborò una mappa delle aree ricreative naturali della Costa Smeralda, che dovevano rimanere non edificate. (Sintesi di progettazione e pianificazione, Vol. I, 1969, pag. 36).
A. SDDA elaborò un esempio di come doveva essere realizzato il rimboschimento. (Sintesi di progettazione e pianificazione, Vol. II, 1969, in Appendice Rimboschimento).
A. La maggior parte della superficie fu oggetto di rimboschimento di tipo I, invece nei quattro centri di Porto Cervo, Pevero Golf, Romazzino e Cala di Volpe fu previsto un rimboschimento di tipo II con diverse piante non locali. (Sintesi progettazione e pianificazione, vol. II 1969, in appendice Rimboschimento)
B. Il Tipo di rimboschimento I, una combinazione di piante autoctone con una pianta non locale, è stato applicato lungo tutte le strade. Il Tipo di rimboschimento II, una combinazione di piante autoctone con diverse piante non locali, è stato utilizzato invece nei centri. (Design and Planning Summary, Vol. II, 1969, nell’Appendice “Rimboschimento”)
C. Il piano di rimboschimento (dettaglio) del Monte Zoppu, dove il concetto di piantumazione SDDA è stato inizialmente applicato su larga scala. (Servizi continuativi 1970)
A. Integrazione tra paesaggio e aree costruite: il campo da golf tra Cala di Volpe e Pevero Golf. (Archivio Enzo Satta)
B. Il campo da golf in uso. Foto degli anni ’70. (Archivio Enzo Satta)
C. La club-house del golf club. Architetto Bonicatti. Foto degli anni ’70. (Archivio Enzo Satta)
2.3. Strumenti di pianificazione – Viabilità e localizzazione degli edifici
Nel 1969, SDDA elaborò un piano della rete stradale per l’intera Costa Smeralda. Le strade erano organizzate gerarchicamente: da arterie principali più ampie si diramavano strade secondarie più strette, fino a raggiungere le strade residenziali, spesso organizzate in anelli o cul-de-sac per servire le singole ville. Questa struttura ramificata garantiva sicurezza e filtrava il traffico senza bisogno di barriere, impedendo ai visitatori inesperti di inoltrarsi casualmente nelle strade laterali.
Qualora qualcuno imboccasse una strada residenziale, si trovava a percorrere un tratto delimitato da alte mura di granito, integrate da una vegetazione rigogliosa e grandi portoni in legno, che definivano l’aspetto delle aree abitative della Costa Smeralda. Lungo queste strade erano previsti marciapiedi unilaterali ma non parcheggi pubblici. Gli accessi privati consentivano solo l’entrata e l’uscita dei residenti, impedendo ai visitatori senza una destinazione specifica di fermarsi o sostare.
Strade panoramiche
Le nuove strade seguivano l’andamento sinuoso e collinare del territorio, simile a quello delle vecchie strade sarde, mantenendo visuali aperte verso paesaggi spettacolari. Questo approccio stradale divenne un programma distintivo della Costa Smeralda, come dimostra il nome “strada panoramica”. Qui, guidare non era solo un mezzo per spostarsi, ma parte integrante dell’esperienza di soggiorno.
SDDA pianificò ogni tipo di strada con dettagli esecutivi per garantire uniformità nei lavori. Anche la vista dal percorso stradale verso il mare fu attentamente progettata. Per preservare le migliori visuali, alcuni tratti vennero dichiarati zone interdette alle costruzioni. Un esempio è un tratto di oltre 60 metri vicino a Cala di Volpe, che offre ancora oggi una vista ampia sulla baia.
Parcheggi e percorsi pedonali
Per preservare la natura come protagonista principale e trasformare la viabilità in un elemento scenografico, furono sviluppati strumenti aggiuntivi oltre alla progettazione delle strade curve. SDDA utilizzò la soluzione delle questioni più urgenti per creare dettagli modello adattabili alle varie situazioni.
I parcheggi furono collocati dietro muretti a mezza altezza, in modo che le auto non fossero visibili dalla strada. Per mitigare l’impressione potenzialmente respingente delle mura, furono introdotte ulteriori piantumazioni. Si evitò rigorosamente l’uso di muri alti che avrebbero potuto chiudere il paesaggio e creare “canyon stradali”. Per ombreggiare le auto, vennero installate tettoie con copertura in paglia, conferendo ai parcheggi un legame con gli elementi vernacolari della tradizione culturale sarda. Due dettagli modello sviluppati da SDDA divennero prototipi per la futura pianificazione di tutti i parcheggi situati direttamente lungo le strade.
Anche per i percorsi pedonali furono sviluppati dettagli modello adattati a diverse situazioni. L’obiettivo era duplice: da un lato consolidare situazioni potenzialmente instabili lungo i pendii, dall’altro creare un’immagine unitaria del paesaggio. Oltre alle istruzioni pratiche, SDDA fornì idee per nascondere elementi visivamente disturbanti, come ad esempio schermare i confini con la vegetazione (vedi Capitolo 2.6.1).
Illuminazione stradale
In seguito alle ripetute raccomandazioni di SDDA nel Masterplan del 1969, all’inizio degli anni Settanta fu progettato un lampione stradale. L’illuminazione uniforme fu installata nei centri e nei quartieri residenziali, mentre i tratti di collegamento tra di essi rimasero privi di illuminazione. Questo concetto contribuì a creare, durante la notte, l’immagine caratteristica delle strade della Costa Smeralda.
Disposizione degli edifici
Le ville, gli hotel e anche le case di appartamenti si trovavano alla fine delle strade ramificate, progettate in modo organico. Come descritto, la topografia del terreno veniva valorizzata attraverso l’accesso carrabile e il percorso verso l’edificio, offrendo in alcuni punti vedute aperte sul paesaggio. Di conseguenza, gli edifici non si trovano ai margini delle proprietà, ma sempre circondati da ampi giardini. Questa tipologia derivata dalla villa fu adattata anche in aree con maggiore densità edilizia, come Porto Cervo, sebbene in forma modificata.
La supremazia del paesaggio determina la pianificazione urbanistica a ogni livello. Anche la zonizzazione delle aree viene classificata gerarchicamente in base alla qualità delle rispettive vedute panoramiche. In un primo passo, SDDA analizzò cinque regioni da sviluppare nella Costa Smeralda(83). Le aree furono valutate in base alla qualità dei panorami disponibili: nei punti con viste particolarmente belle venivano costruite grandi ville; nelle aree con vista limitata, ville più piccole o edifici per il personale. Le zone senza una bella vista rimasero inedificate.
(83). Le cinque regioni erano: Liscia di Vacca, Porto Cervo, Pevero Golf, Romazzino e Cala di Volpe. Liscia di Vacca includeva il centro Pitrizza. Pevero Golf, situato in una grande baia, fu sviluppato solo negli anni ’70 seguendo le proposte di SDDA come una località balneare priva di ulteriori funzioni.
A. Il piano Hierarchy of Roads del 10 agosto 1970 mostra la rete stradale come un sistema di arterie progettato organicamente. La versione del piano stradale della SDDA del 1968 era già stata rivista. Sono differenziate varie dimensioni, progetti con cordoli e senza, nonché strade illuminate (segnate con linee laterali blu) e non illuminate. Lungo i segmenti stradali compresi tra due linee, si prevedeva la costruzione di canali per l’installazione successiva di cavi elettrici. (Continuing Services, 1970)
B. La SDDA pianificò zone libere lungo le strade per mantenere parziali scorci sul mare, come in questo caso a Cala di Volpe. (Continuing Services, 1970)
C. SDDA produsse una guida per la progettazione di tutte le strade. Qui di seguito sono mostrate: Le dimensioni delle strade principali, secondarie e di accesso. SDDA produsse un piano separato con informazioni più dettagliate per ogni tipo di strada. (Servizi continui 1970)
A. I parcheggi furono progettati in modo tale da evitare la creazione di pareti di cemento lungo le strade. Qui la soluzione proposta per un parcheggio presso un edificio residenziale a Porto Cervo. (Continuing Services, 1970)
B. Furono elaborati anche dettagli modello per il tracciato e la costruzione dei percorsi pedonali. (Continuing Services, 1970)
C. Lungo le strade, negli anni ’70, venne installata un’illuminazione uniforme. Nella foto, la strada che costeggia il campo da golf vicino a Cala di Volpe. L’illuminazione stradale è rimasta invariata fino a oggi. (Archivio Enzo Satta)
B. La SDDA pianificò zone libere lungo le strade per mantenere parziali scorci sul mare, come in questo caso a Cala di Volpe. (Continuing Services, 1970)
B. La SDDA pianificò zone libere lungo le strade per mantenere parziali scorci sul mare, come in questo caso a Cala di Volpe. (Continuing Services, 1970)
2.4. Strumenti di pianificazione – Urbanistica – Esempio di Porto Cervo
Basandosi sulla valutazione delle vedute effettuata da SDDA, furono create le zone e successivamente suddivise in lotti. Per guidare lo sviluppo in modo controllato, SDDA stabilì gerarchie per la prima fase. Vennero redatti piani di fasi per i singoli centri, che definivano il programma di costruzione per i successivi cinque anni. A Porto Cervo, queste aree includevano le zone vicine al centro, dove si prevedeva la costruzione di edifici pluripiano per abitazioni e servizi. Successivamente, si pianificarono i quartieri di ville sulle colline e a nord di Porto Cervo, oltre alla Marina a ovest.
La viabilità per veicoli e pedoni fu progettata in dettaglio per il centro. Si cercò di separare il più possibile i due percorsi. Dalla strada principale di accesso partivano solo vicoli ciechi verso il centro: uno verso il molo est, un altro verso il complesso residenziale Cerbiatta nella piccola insenatura e un terzo verso il complesso residenziale pianificato lungo la costa sotto la chiesa Stella Maris. Altrimenti, lungo la strada di accesso erano previsti parcheggi nascosti da fasce verdi. I pedoni potevano muoversi liberamente attraverso diversi percorsi nel centro e, percorrendo a piedi dal molo est alla chiesa Stella Maris, dovevano attraversare una sola strada.
SDDA avanzò proposte per lo sviluppo e l’uso delle aree intorno al centro. La costruzione tra gli edifici già esistenti rispettava l’aspetto sia dal mare che dalla terra, prevedendo lunghi edifici organici intervallati da aree verdi su entrambi i lati. I suggerimenti di SDDA colmavano anche lacune funzionali: si stabilì che gli usi più frequentati si sarebbero trovati lungo la baia. Qui si proponevano un hotel non troppo esclusivo, diversi condomini, un ristorante, un nightclub e un club sportivo. SDDA mantenne la struttura multipolare di Porto Cervo, progettando ulteriori centri rispetto al primo nucleo creato da Vietti.
Un secondo centro era previsto attorno alla chiesa Stella Maris. La piazza della chiesa doveva essere delimitata da un condominio di fronte alla chiesa e da un ristorante sulla collina. Due luoghi semi-pubblici erano destinati al tempo libero: un beach club sulla costa tra Sa Conca e il centro di Porto Cervo e un nightclub all’estremità nord del molo est. Inoltre, nella successiva insenatura era previsto un altro “villaggio” multipolare simile a quello del centro di Porto Cervo per la Marina.
Come elemento unificante tra le diverse funzioni, SDDA utilizzò un unico tipo di edificazione. I vuoti a Porto Cervo dovevano essere riempiti con lunghi condomini ramificati, formalmente ispirati al centro di Porto Cervo e al tipo di corte utilizzato da Vietti.
Le proposte di SDDA erano concepite come suggerimenti urbanistici. La progettazione e la realizzazione dovevano essere affidate a diversi architetti scelti dal consorzio. Per le regole architettoniche, SDDA fece due raccomandazioni nel rapporto del 1969: allentare le norme edilizie e semplificare il processo di approvazione. Le norme iniziali erano evidentemente più rigide e il processo di autorizzazione dipendeva dall’opinione personale dei tre principali architetti. Queste raccomandazioni furono probabilmente adottate, con il risultato che le regole furono meno rigide e indipendenti dalle singole personalità, una modifica comprensibile da un punto di vista imprenditoriale, ma che portò a un’immagine architettonica meno omogenea di quella inizialmente prevista(85).
(85. Come già menzionato nel Capitolo 1, il primo regolamento edilizio oggetto di questa ricerca non è disponibile. È invece presente quello del 1991, in cui almeno il processo di approvazione risulta semplificato. È quindi possibile che le norme architettoniche nel primo regolamento edilizio fossero formulate in modo più dettagliato).
Le costruzioni descritte avrebbero dovuto essere completate entro il 1973, ma la prima fase durò fino al 1976 circa. Gran parte della proposta fu realizzata, ma gli edifici furono progettati da diversi architetti e differivano da quelli pianificati. Sul lato est fu costruito, in una forma modificata, il condominio previsto vicino alla costa e il nightclub vicino alla capitaneria(86. La palazzina è stata progettata dall’architetto Mileto. Si veda anche la sezione Porto Cervo centro – l’organizzazione del capoluogo). Invece dell’hotel a nord-est, fu costruito un altro complesso residenziale(87. Non è stato possibile risalire all’architetto). Il club sportivo di Mileto fu realizzato più grande del previsto, con sette campi da tennis disposti lungo la topografia e un’arena per cavalli con scuderia progettata da Savin Couëlle.
Nel 1976 furono inaugurati il porto e i cantieri di Porto Cervo Marina, e nel 1977 aprì il nuovo yacht club. Quest’ultimo, progettato dagli architetti romani Paolo Motta, Andrea Silipo e Paolo Meluzzi, si ispirava all’opera di Louis I. Kahn, introducendo un nuovo linguaggio architettonico nella Costa Smeralda. Il centro commerciale della Marina fu costruito negli anni Ottanta.(89. Si fa riferimento a Porto Cervo Centro, con una piazza del villaggio suggerita. Il volume principale forma un semicerchio verso il mare, con una piazza inferiore (Sottopiazza) e superiore (Soprapiazza). Anche il centro commerciale, come il Yacht Club, ha una geometria più rigida, rappresentando una nuova direzione architettonica del consorzio).
Mentre Porto Cervo si sviluppò seguendo il piano di SDDA, lo sviluppo di altre aree subì ritardi a causa di influenze politiche(90. Per Porto Cervo fu ottenuta un’autorizzazione separata che includeva anche Porto Cervo Marina). Le approvazioni per gli edifici lungo i campi da golf tra Cala di Volpe e Pevero Golf furono ottenute in ritardo, così come le espansioni a Pevero Golf e Romazzino. SDDA pianificò due ulteriori centri a Cala di Volpe e Razza di Juncu, progettati come piccoli “villaggi” simili a Porto Cervo, ma che non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione.
A. La sequenza della pianificazione di Porto Cervo nella prima fase 1968-1973. (Sintesi di progettazione e pianificazione, Vol. I, 1969, p. 5).
1. Complesso residenziale Dolce Sposa
In costruzione Arch.: Vietti
2. Nuove ville
Insediamento secondo i primi piani regolatori, architetto: Diverse
3 Yacht club
Inaugurato nel 1977, architetti: Paolo Motta, Andrea Silipo e Paolo Meluzzi
4. Porto Cervo Marina
Inaugurato nel 1976
5. S’Abbia Ilde e Sas Pedras
Architetto: Busiri-Vici
6. Nuove ville
Realizzate secondo i primi piani regolatori, architetto: Vari
7. Complesso residenziale
Architetto: Sconosciuto
8. Nuove ville
Architetto: Sconosciuto
9. Ampliamento dell’Hotel Cervo
Architetto: Vietti
10. Circolo sportivo
Architetto: Mileto
11. Edifici residenziali
Architetto: Mileto
12. Edifici residenziali
Arch.: Sconosciuto
Porto Cervo nel 1977: le proposte dell’SDDA furono attuate in forma modificata. I nuovi edifici dal 1969 in poi sono indicati in rosso (base: http://www.sardegnageoportale.it/ webgis2/sardegnafotoaeree/ [14 novembre 2014], a cura di ND)
3. 1983-1998 – FINO ALL’ULTIMO MASTERPLAN SOTTO LA GUIDA DELL’AGA KHAN
Già prima che SDDA elaborasse il primo masterplan, l’iniziale atteggiamento positivo verso il progetto in Sardegna cominciò a mutare. Dal 1968 iniziarono le battaglie politiche per le autorizzazioni del masterplan. La regione Sardegna reagì all’aumento del valore della costa e alla crescente attività edilizia causata dalla Costa Smeralda riducendo la densità edificabile consentita. Gli interventi del Consorzio avevano avviato uno sviluppo economico e demografico sull’isola. In particolare, nel nord della Sardegna il turismo si affermò come un nuovo settore economico, mentre si organizzavano opposizioni contro la costruzione sulla costa e contro i “proprietari stranieri”. L’associazione “Italia Nostra” divenne un avversario politico decennale del Consorzio(92). “Italia Nostra” considerava il progetto del Consorzio come una distruzione di una costa incontaminata, che era un bene comune della popolazione(93). Tuttavia, il Consorzio, probabilmente mosso soprattutto da motivazioni economiche, si vedeva anche come custode di questa costa.
(92. “Italia Nostra” fu fondata nel 1955 con l’obiettivo di conservare il centro barocco di Roma. Successivamente, l’associazione ampliò le sue attività alla protezione dei beni culturali italiani e del paesaggio. Nel 1972, aprì una sezione a Sassari dedicata alla protezione delle coste. Cfr. www.italianostra.org (3.11.2015).
(93. Per le controversie tra il consorzio e “Italia Nostra”, vedi: Riccardi 2010, pp. 189-192. “Italia Nostra” continua a combattere con successo contro lo sviluppo della Costa Smeralda. Ciò ha portato a mantenere uno dei pochi tratti di costa incontaminata in Sardegna, nel sud della Costa Smeralda. Maggiori informazioni sulla costa sarda sono nel capitolo 4. Per le attività attuali di “Italia Nostra”, vedi: http://www.italianostra.org/?p=27538 (3.11.2015).
Con una consapevole sottoutilizzazione delle possibilità edificatorie, voleva evitare quegli errori che erano stati commessi fino ad allora nel Mediterraneo. Dopo un cambio politico, il Comune di Arzachena, nel cui territorio si trovava gran parte della Costa Smeralda, divenne un ulteriore avversario politico. Il sindaco degli anni ’70, Tino Demuro, negoziò con il Consorzio i volumi edificabili ancora da realizzare, ma il Consorzio cercò di negoziare in modo troppo esigente; a posteriori, ciò si rivelò un errore.(94. Secondo Enzo Satta, il consorzio chiedeva 2.600.000 metri cubi. Tino Demuro, a nome del comune di Arzachena, voleva approvare 2.200.000 metri cubi. Dopo oltre un decennio di stallo, a causa di cambiamenti politici a livello regionale, negli anni ’90 il consorzio dovette negoziare con la regione Sardegna una volumetria massima di 1.800.000 metri cubi). A livello nazionale, invece, i buoni rapporti con i membri della Democrazia Cristiana e con il governo della regione autonoma Sardegna rimasero a lungo solidi.(95. Per una descrizione approfondita delle battaglie politiche, vedi Riccardi 2010, pp. 155-192).
Come descritto sopra, già nella seconda fase del masterplan di SDDA, dal 1973, si sarebbe dovuta sviluppare la vasta area a sud di Cala di Volpe. Subito sotto l’hotel Cala di Volpe doveva sorgere, sul modello di Porto Cervo, un villaggio. Più a sud, a Razza di Juncu, erano previsti due ulteriori centri e un hotel sul modello architettonico del Pitrizza. La maggior parte del territorio era di proprietà dell’Aga Khan.(96. Lo sviluppo di quest’area avrebbe portato sia a enormi guadagni economici sia a rendere la Costa Smeralda un luogo di riferimento sulla mappa).
Tuttavia, le resistenze ormai organizzate portarono al ripetuto fallimento dell’approvazione del masterplan. L’Aga Khan si confrontò per oltre un decennio con i disordini politici. Negoziò compromessi, commissionò studi indipendenti per dimostrare che la Costa Smeralda era importante per lo sviluppo economico della Sardegna e fece sviluppare ai suoi collaboratori strumenti di progettazione avanzati.
Con Intergraph verso il «masterplan ideale»
Il culmine di questi sforzi fu l’impiego dei primi computer per l’elaborazione di un piano che tenesse conto di tutti i fattori. Tramite il computer, si sarebbe dovuta calcolare una soluzione ideale. Il progetto, dal lato del Consorzio, fu guidato da Enzo Satta e sviluppato in collaborazione con SDDA. Satta lavorava dal 1973 come architetto per il Consorzio. Grazie alla Fondazione Aga Khan, poté proseguire la sua formazione alla Harvard Graduate School of Urban Design nel 1979. Tornato in Sardegna, nel 1985 introdusse la nuova tecnologia Intergraph, allora sul mercato libero. Il software, originariamente sviluppato dalla NASA per l’allunaggio, era in grado di triangolare i terreni e permetteva così le prime rappresentazioni topografiche complesse. Inoltre, il programma consentiva di classificare le aree in base a diverse caratteristiche.
Satta inserì nel programma varie valutazioni del territorio secondo le direttive di SDDA. I criteri includevano, ad esempio, la direzione del vento, la qualità della vista, la pendenza e le caratteristiche paesaggistiche. Con fotografie aeree, vennero localizzate tutte le formazioni rocciose, la densità della vegetazione e le aree geologicamente instabili. Ad ogni attributo fu assegnata una rilevanza: un paesaggio particolare non doveva essere distrutto, mentre una vista ampia sul mare era adatta a un’area edificabile. Il programma fornì poi una proposta su dove collocare le costruzioni. Per esempio, intorno a una formazione rocciosa non si poteva costruire un quartiere di ville, perché avrebbe richiesto troppe strade e non sarebbe stato possibile preservare la roccia. Tuttavia, si poteva pianificare un hotel con una strada di accesso attorno alla roccia. Nel 1986, Satta presentò al Consorzio il masterplan rielaborato.
Negli anni ’90, sulla base di questo piano, il masterplan fu più volte rivisto per ottenere l’approvazione per le aree meridionali di Cala Liscia Ruja e Razza di Juncu. L’area fu divisa in quattro settori: i settori 1-3 ricadevano nel comune di Arzachena, mentre il settore 4, il più a sud, era nel comune di Olbia(97. I comuni erano rilevanti per l’approvazione dei siti: Per l’approvazione del masterplan, il consorzio doveva trovare un accordo sia con la Regione Sardegna che con il rispettivo Comune). Il settore 1 comprendeva le aree intorno a Pitrizza e Porto Cervo, quasi completamente sviluppate; solo nel sud di Porto Cervo restava una zona di ville da approvare. Il settore 2 comprendeva la penisola su cui si trova Romazzino, dove erano previsti due campi da golf e zone residenziali costituite da ville. Il settore 3 iniziava a nord con Cala di Volpe e il “villaggio” ancora in fase di progettazione. Si estendeva lungo la spiaggia di Liscia Ruja, dove era previsto un altro campo da golf che si affacciava su una penisola rocciosa.(98. Jack Nicklaus aveva elaborato i progetti per il campo da golf previsto). Il settore 3 terminava a metà della baia di Razza di Juncu, dove era previsto il terzo “villaggio” dopo Porto Cervo e Cala di Volpe. Nei due centri progettati nell’area 3, come a Porto Cervo si prevedeva principalmente la costruzione di edifici residenziali multipiano e servizi, mentre lungo i pendii erano pianificati soprattutto quartieri di ville. Il settore 4 iniziava a metà della baia di Razza di Juncu e si estendeva, con un’interruzione, per circa due chilometri e mezzo verso sud, rappresentando una continuazione nella distribuzione dell’uso del territorio rispetto al settore 3 (99. Il “divario” si riferisce al luogo di Portisco, che non faceva parte del consorzio. Il resort fu fondato alla fine degli anni ’70. A causa della differente architettura, l’Aga Khan spostò il “confine” della strada di ingresso sulla costa verso nord). In tutte le aree, circa un settimo degli edifici previsti era destinato ad alberghi e un decimo a servizi, mentre il resto era costituito da seconde case sotto forma di ville e condomini.(100. Il masterplan degli anni ’90 prevedeva la costruzione di 2.555.000 metri cubi di edifici. Di questi, 233.440 metri cubi erano destinati a servizi, 352.380 metri cubi per hotel, 446.000 per appartamenti e 1.523.180 metri cubi per ville. Nel corso degli anni ’90, la regione Sardegna cambiò la sua posizione sulla volumetria massima. Nella negoziazione finale si trattò un volume di 1.800.000 metri cubi. Il piano più recente, che è in possesso di questa ricerca, risale al 1996 e corrisponde a quello del 1994).
Rispetto ai primi piani regolatori, ci fu un cambiamento significativo nella posizione delle costruzioni. All’inizio del progetto, la legge sarda permetteva di costruire fino a ridosso del mare. Tuttavia, il consorzio seguiva fin dall’inizio – con poche eccezioni – un’espansione leggermente arretrata, per lasciare le spiagge accessibili al pubblico. Dal 1985, però, una legge vietò di costruire a meno di 300 metri dalla costa. Di conseguenza, le aree destinate alle ville furono posizionate in gruppi organici sui pendii più alti. Solo i nuovi centri presso Cala di Volpe e Razza di Juncu avrebbero potuto estendersi fino al mare, seguendo l’esempio di Porto Cervo. Questi centri avrebbero ospitato, oltre alle abitazioni e ai servizi già menzionati, negozi e altre infrastrutture nautiche.
Dopo lunghe trattative, nel 1998 fallì l’ultimo tentativo di ottenere l’approvazione per le aree meridionali sotto la guida dell’Aga Khan. I dissidi principali riguardavano la percentuale di hotel pianificati. Il Consorzio, per ragioni economiche e per la caratteristica del luogo, preferiva le ville, sostenendo che queste si integrassero meglio nel paesaggio(101. Si potrebbe anche argomentare al contrario, che gli hotel si integrano meglio nel territorio, poiché richiedono meno superficie stradale e permettono di evitare un’eccessiva frammentazione del paesaggio). I politici locali, invece, volevano più grandi hotel, che avrebbero creato più posti di lavoro.(102. Le motivazioni politiche per insistere sugli hotel erano molteplici. Come argomenti vennero citati la protezione del paesaggio e la maggiore creazione di posti di lavoro. I rappresentanti della Costa Smeralda sospettano che dietro queste motivazioni vi fossero tentativi di acquisire consensi da parte dei leader sindacali o altre strategie di potere. Cfr. Riccardi 2010, pp. 179-210).
In seguito, il consorzio cercò di dimostrare che le ville private avrebbero creato almeno lo stesso numero di posti di lavoro per i sardi. Inoltre, commissionò studi per valutare l’impatto della Costa Smeralda sulla crescita economica della Sardegna settentrionale. Nel 1998, il comune, la regione e il consorzio si incontrarono per approvare definitivamente una versione ridotta del piano, già negoziata, che prevedeva 1.800.000 metri cubi di costruzioni. Tuttavia, la regione e il consorzio non riuscirono a trovare un accordo sulla quota di hotel prevista(104). Di conseguenza, l’Aga Khan cedette tutte le sue partecipazioni a Sheraton(105). Mantenne soltanto la sua villa a Porto Cervo, il Yacht Club nella Marina di Porto Cervo e la compagnia aerea Alisarda, poi diventata Meridiana.
(104. Secondo Enzo Satta, la posizione della regione era la seguente: dei 1.800.000 metri cubi sui quali il comune, la regione e il consorzio si erano ormai accordati, il consorzio voleva destinare un quarto a hotel. La regione, tuttavia, richiedeva che metà di questo volume fosse destinato agli hotel. A seguito di ciò, l’Aga Khan abbandonò il progetto. Con il senno di poi, si può constatare che durante questo processo il tempo è stato sfavorevole per il consorzio. Oltre alle leggi che diventavano sempre più rigide, anche i politici divennero progressivamente più severi. Un cedimento precoce sarebbe stata probabilmente la soluzione più saggia per il consorzio. Nel 1983, infatti, il consorzio avrebbe potuto ottenere l’approvazione per 2.200.000 metri cubi, con una percentuale di hotel molto inferiore.
(105. Nel 1997, Sheraton fu acquisito da Starwood e nel 2003 Starwood vendette le sue quote della Costa Smeralda a Colony Capital (di proprietà di Tom Barrack). Dal 2012, la maggior parte delle quote della Costa Smeralda è in mano al Qatar).
A. Grazie alla Fondazione Aga Khan, l’architetto Enzo Satta può seguire un corso di perfezionamento in urbanistica ad Harvard. (Sacripanti 1980)
B. Satta al lavoro con il software Intergraph. (Sistemi grafici integrati 1987)
C-G. Esempi dal programma – Il programma Intergraph era già in uso nel 1987. Le immagini mostrano lo schermo del schermo del computer fotografato:
C. Aree con le migliori viste
D. Paesaggi di particolare pregio
E. Rocce
F. Stabilità geologica
G. Proposte di sviluppo basate sull’interpolazione di tutti i fattori (Sistemi grafici integrati 1987)
L’aspetto attuale di Porto Cervo
Dal 1983 a oggi, Porto Cervo è stato oggetto di un continuo sviluppo, pur mantenendo le caratteristiche originarie che ne definiscono l’identità. È il centro principale di una rete che include diversi nuclei. A ovest si trova Porto Cervo Marina, ormai completata, con un proprio “centro cittadino”, il business center Marina. La disposizione ad anello degli edifici crea una piazza che si affaccia sul mare, accompagnata da una strada commerciale ritmata da portici e cortili. Le banchine del porto, particolarmente frequentate durante i mesi estivi, rappresentano uno spazio pubblico vivace.
Sul lato opposto della baia si trovano la chiesa Stella Maris e l’hotel Luci di la Muntagna. Il piazzale antistante la chiesa non è stato mai chiuso da ulteriori edificazioni. La chiesa, collocata alla fine di una strada senza uscita e circondata da spazi verdi, costituisce un punto focale in senso culturale e umano.
Nella baia meridionale si trova il centro progettato da Vietti, con l’ala nord-ovest costruita intorno al 1980. Lungo la costa orientale si estende il primo porto, il Molo Est, uno spazio pubblico con ristoranti e un caffè. Dietro agli edifici residenziali sul Molo Est, costruiti da Mileto negli anni Settanta, si trova un nuovo centro: la Promenade du Port, progettata da Satta e inaugurata nel 2003. Questo complesso, con cortili e piazze su diversi livelli, fonde elementi architettonici di Couëlle, Busiri-Vici e Vietti.
Attorno a questi spazi pubblici ci sono strutture semi-pubbliche come il centro medico, il circolo nautico, il centro sportivo, gli hotel e i ristoranti. Lungo la costa si trovano perlopiù edifici residenziali, come quello progettato da Spoerry negli anni Ottanta tra Marina e “Busiri-Vici’s Hang”.
Le ville sono distribuite lungo le colline della baia ramificata. Tutti gli edifici sono circondati da ampie aree verdi, con l’unica eccezione di Sa Conca, che si affaccia direttamente sulla strada. Persino il centro progettato da Vietti è circondato da una cintura verde. L’abbondanza di vegetazione dà a Porto Cervo un aspetto più simile a un quartiere residenziale o suburbano piuttosto che a un centro urbano. Gli unici elementi che evocano un’atmosfera cittadina sono le banchine in cemento, affollate di yacht disposti quasi tecnicamente in fila.
In termini architettonici, si osserva una graduale diminuzione della qualità dopo le prime realizzazioni. Tuttavia, grazie alle norme edilizie e alla pianificazione paesaggistica, Porto Cervo ha sviluppato una propria e unica identità architettonica.
L’ultimo piano generale del 1994, prima della partenza dell’Aga Khan, sviluppato sulla base del software Intergraph. (Archivio Enzo Satta)
Porto Cervo nel 2015 (Calendario del Consorzio Costa Smeralda)
4. Inquadramento storico-architettonico e storico-culturale
La progettazione delle strade alla Costa Smeralda presenta analogie con i “Parkways” degli Stati Uniti, strade che collegano centri urbani, parchi e sobborghi. Questo concetto, ideato da Frederick Law Olmsted insieme a Calvert Vaux, prevedeva percorsi separati per carrozze, cavalieri, ciclisti e pedoni, con elementi paesaggistici che enfatizzavano la natura. Il primo esempio di parkway è l’Eastern Parkway a Brooklyn, realizzato da Olmsted e Vaux nel 1866. In questo progetto, fasce verdi laterali separano i percorsi pedonali dal traffico delle carrozze.
Olmsted piantumò le fasce verdi tra le diverse vie di traffico con alberi e progettò zone paesaggistiche lineari, libere da segnaletica urbana come pubblicità, con l’obiettivo di creare un’esperienza di guida piacevole e rilassante. Tra le sue opere più celebri figurano il Central Park di New York, il Prospect Park a Brooklyn e il sistema di parchi di Boston, città dove studiarono l’Aga Khan, suo fratello Amyn Khan e Morgan Wheelock, futuro direttore del progetto SDDA.
Questa separazione del traffico combinata con la messa in scena del paesaggio presenta forti parallelismi con la Costa Smeralda. Le aree verdi progettate da Olmsted, come la pianificazione del paesaggio alla Costa Smeralda, erano caratterizzate da un’attenta orchestrazione della natura. I percorsi curvilinei, fiancheggiati da alberi e arbusti, erano progettati per offrire scorci mirati sulla vastità del paesaggio. Come alla Costa Smeralda, dove il traffico automobilistico fu separato dai percorsi pedonali, già nel 1866 Olmsted aveva progettato percorsi distinti per carrozze e pedoni, disposti in modo che i visitatori del parco fossero circondati esclusivamente dalla natura.(106. Per la progettazione dei parchi da parte di Olmsted, cfr. Fein 1981, pp. 63-88 e 129-164, e Beveridge/Rocheleau 1998, pp. 46-114. Per le Parkway progettate da Olmsted, vedi Fein 1981, pp. 126f. e 158-164. Per l’importanza di Olmsted nella progettazione dei parchi negli Stati Uniti e delle Parkway, cfr. Magnago Lampugnani 2011, Vol. I, pp. 43-48 e Magnago Lampugnani 2011, Vol. II, pp. 530).
Le somiglianze progettuali diventano ancora più evidenti confrontando la Costa Smeralda con i primi parkways concepiti specificamente per il traffico automobilistico.
Il progetto pionieristico per questo tipo di strada fu il Bronx River Parkway, una evoluzione del parkway di Olmsted. Realizzato entro il 1925 secondo i piani dell’ingegnere Leslie G. Holleran e del paesaggista Gilmore D. Clarke, anticipò sotto molti aspetti la progettazione paesaggistica della Costa Smeralda. L’obiettivo principale era creare un parco lungo la strada che offrisse un’esperienza visiva immersa nella natura sia agli automobilisti che ai pedoni. Gli alberi esistenti dovevano essere protetti e, attraverso interventi di cura, crescere più rigogliosi. I boschi furono arricchiti con alberi e arbusti strategicamente collocati per orientare la vista del viaggiatore. Si privilegiò l’uso di piante autoctone, integrandole però con oasi di alberi e arbusti non locali. Automobilisti e pedoni venivano condotti lungo percorsi intimi, che si aprivano su ampie vedute panoramiche, creando un alternarsi armonioso tra spazi raccolti e vasti orizzonti naturali.
Le case lungo il parkway non disponevano più di accessi individuali direttamente collegati alla strada principale. Al contrario, venivano servite da una strada secondaria posta sul retro, con collegamenti al parkway solo in punti specifici. Le colline esistenti non dovevano essere attraversate dalle strade; il parkway doveva invece aggirarle con curve dolci, integrandosi armoniosamente nella topografia del territorio.
Le pubblicità lungo il percorso erano evitate, e le case dovevano rimanere invisibili dalla strada principale. I diversi percorsi erano progettati su livelli differenti, garantendo una separazione visiva tra di essi, in modo che sia i pedoni sia gli automobilisti fossero immersi esclusivamente nella natura.
Il Bronx River Parkway fu concepito come un progetto integrato: non solo il tracciato e la progettazione paesaggistica, ma anche gli elementi costruiti e le infrastrutture tecniche furono accuratamente pianificati nella sua evoluzione. Ogni dettaglio della strada rispondeva all’idea di creare un’immagine rustica. I lampioni e i parapetti dei ponti erano realizzati in tronchi d’albero scortecciati, mentre i muri di sostegno e i ponti erano costruiti con pietre grossolanamente squadrate.
Negli anni ’30, le stazioni di servizio lungo il Bronx River Parkway furono progettate da Penrose V. Stout ispirandosi all’architettura rurale. Furono dotate di tetti a due spioventi e grandi camini sovradimensionati. La configurazione topografica delle strade e la progettazione paesaggistica integrata del Bronx River Parkway presentano notevoli somiglianze con il design del paesaggio e delle strade della Costa Smeralda. Inoltre, l’impostazione edilizia del comitato architettonico, caratterizzata da ampi spazi verdi circostanti, richiama l’approccio progettuale dei parkways.
Un’altra possibile fonte di ispirazione per la configurazione delle strade e la disposizione degli edifici potrebbe essere stato il porto di Capri, la Marina Grande, citato più volte come modello. La Marina Grande è costituita da una fila di case addossate lungo il mare, attraversata da una strada sinuosa che si arrampica sul pendio. Lungo questa strada, leggermente arretrate, si trovano case circondate da giardini. La struttura spaziale della natura, delle strade e delle abitazioni, così come l’immagine formale della distribuzione degli insediamenti, mostrano molteplici somiglianze con la Costa Smeralda.
A differenza di altri luoghi costieri comparabili nel Mediterraneo, come Positano e Portofino, la Costa Smeralda presenta un’organizzazione spaziale unica. A Positano, per esempio, gli edifici sono disposti linearmente lungo le curve di livello del pendio, mentre a Portofino, dietro il porto densamente edificato, si trovano solo poche abitazioni isolate nell’entroterra.
Nonostante le somiglianze urbanistiche con Capri, è dubbio che il consorzio si sia ispirato direttamente alla Marina Grande. È possibile che le somiglianze formali siano emerse casualmente, guidate da motivazioni differenti.
L’analogia tipologica della Costa Smeralda con i quartieri di ville, esposta nel Capitolo 1, si manifesta anche dal punto di vista formale. Un esempio è Cologny, un sobborgo di Ginevra, che presenta similitudini con la Costa Smeralda nella sua configurazione urbana. Il tratto di costa sul Lago di Ginevra è attraversato da strade sinuose lungo le quali sorgono grandi ville circondate da ampi giardini. Tuttavia, è improbabile che gli architetti del consorzio abbiano preso come riferimento diretti quartieri di ville anonimi.
Piuttosto, la somiglianza formale con i quartieri di ville europei sembra derivare dal tipo di edificio prevalentemente costruito alla Costa Smeralda: la villa per le vacanze con grande giardino. Questo tipo di costruzione, combinato con strade curvilinee, ha prodotto un’immagine simile a quella del quartiere residenziale di Cologny in Svizzera o di Hollywood negli Stati Uniti.
L’ingresso dei paesaggisti di SDDA nel 1967 nella progettazione della Costa Smeralda suggerisce che le ispirazioni per la pianificazione del paesaggio, incluse le strade e l’urbanistica, possano essere ricondotte ai parkways. Oltre alle somiglianze concettuali con i parkways, vi sono anche indizi biografici che collegano la progettazione del paesaggio agli Stati Uniti.
L’Aga Khan trascorse gli anni universitari a Boston insieme al fratello Amyn Khan, che lì studiava architettura del paesaggio. Un ex compagno di studi e coinquilino di Amyn Khan, Morgan Wheelock, divenne nel 1967 il responsabile del progetto SDDA alla Costa Smeralda. Questo dettaglio sottolinea l’importante ruolo di Amyn Khan nelle decisioni progettuali dell’Aga Khan.
Sebbene Amyn Khan non abbia avuto una presenza pubblica rilevante negli anni ’60 e ’70, si può presumere che sia stato coinvolto fin dall’inizio nel progetto, il cui concetto centrale era basato su una pianificazione paesaggistica accurata.
Inquadramento storico-semantico
Il metodo di pianificazione adottato per lo sviluppo della Costa Smeralda è diventato un modello per successivi progetti turistici. L’idea di sviluppare economicamente una regione incontaminata attraverso un progetto turistico di ampio respiro fu ripetutamente applicata dall’Aga Khan. Egli comprese presto che il turismo poteva essere un mezzo per portare prosperità in aree sottosviluppate, prive di risorse ma dotate di bellezze naturali straordinarie.
Già nel 1965, l’Aga Khan raccontava che diversi leader politici in Africa e nel Medio Oriente gli avevano chiesto di replicare il modello di sviluppo della Costa Smeralda nei loro territori. Nel 1989, dichiarò che il suo Aga Khan Development Network aveva effettivamente applicato questa esperienza e metodologia per progetti turistici in Kenya e Pakistan.
Negli anni ’70, il network, basandosi su questo concetto, costruì i primi hotel sotto il marchio Serena Hotels. Oggi, in Kenya, il network gestisce un hotel a Mombasa, uno a Nairobi e sei safari lodges distribuiti in tutto il paese.
Strumenti simili a quelli impiegati in Costa Smeralda per lo sviluppo su larga scala di una regione sottosviluppata furono utilizzati alla fine degli anni Ottanta dall’imprenditore Samih Sawiris a El Gouna, in Egitto. Situata sul Mar Rosso, a circa venti chilometri da un aeroporto internazionale, la piccola città sottosviluppata di El Gouna è stata trasformata da Sawiris e dalla sua azienda Orascom in una destinazione turistica di lusso. Inizialmente, Sawiris acquistò una vasta area, che fu progressivamente ampliata per mantenere il luogo sempre attuale e in evoluzione. Nel corso del tempo, il progetto si arricchì con la costruzione di hotel, scuole di immersione, un campo da golf, due porti turistici, un maneggio, una chiesa, una moschea, un ospedale e diverse strutture commerciali. Come per la Costa Smeralda, anche a El Gouna venne sviluppata un’architettura ibrida unica. Qui lo stile si ispirava alla tradizione nubiana, combinata con elementi di architettura contemporanea e comfort moderni.
Nel 2009, un progetto simile fu avviato da Sawiris ad Andermatt, in Svizzera. Questa località ospitava dal 1895 una base militare, progressivamente smantellata a partire dagli anni Novanta. L’esistenza di infrastrutture come un aeroporto militare, insieme al declino demografico del villaggio, offriva le condizioni ideali per avviare un progetto turistico di grande scala. Come in Costa Smeralda, Andermatt – adiacente a un’area naturale – fu prescelta come una destinazione di lusso. Gli hotel a quattro e cinque stelle furono progettati in uno stile architettonico che integrava elementi dei tradizionali chalet locali. Per prolungare la stagione turistica fu incluso un campo da golf. Nel 2012, i nuovi edifici furono presentati – così come avvenne in Costa Smeralda – con grandi modelli nel centro del nuovo resort di lusso, un’operazione pensata per comunicare il progetto al pubblico e attrarre acquirenti. E come per la Costa Smeralda ed El Gouna, anche ad Andermatt il progetto è stato concepito per un continuo sviluppo nel tempo.
Sawiris non fece riferimento esplicito alla Costa Smeralda nella presentazione dei suoi progetti. Tuttavia, anche se non ne fosse stato a conoscenza, la Costa Smeralda rimane un’impresa pionieristica nella pianificazione e progettazione concettuale di una specifica località turistica. Essa ha rappresentato un prototipo per successivi progetti turistici di simili dimensioni, sia in Europa che, come spiegato, in Africa.