IL NATALE IN GALLURA E IN SARDEGNA
di Andrea Pirodda
1894 / 1915
♦ in «RIVISTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI ITALIANE»,
anno I – 1893-94, fascicolo II – gennaio 1894, pp. 139-145
♦ nel libro: BOZZETTI E SFUMATURE, Palermo, Ed. Remo Sandron, 1915 ⇒
Andrea Pirodda, Aggius 1868 – Cagliari 1924, da giovane fu in relazione di grande amicizia, o meglio di “amorosi sensi”, con Grazia Deledda.
Fu con lei, e insieme con Giuseppe Calvia di Mores e Francesco De Rosa di Olbia, uno dei principali corrispondenti sardi delle prime e prestigiose riviste folcloriche italiane come «Rivista di tradizioni popolari» diretta da Raffaele De Gubernatis, e «Archivio delle tradizioni popolari» fondata e diretta da Giuseppe Pitré.
Conseguito il diploma magistrale, si dedicò all’insegnamento in diversi centri dell’isola finendo per stabilirsi a Buggerru, dove fu testimone e narratore dei sanguinosi tumulti del settembre 1904.
S’interessò e scrisse anche di problemi di organizzazione scolastica.
AVVERTENZA. Il titolo di questa pagina Il Natale in Gallura e in Sardegna è una scelta di Gallura Tour.
Si tratta infatti di un testo che fu pubblicato dapprima col titolo Il Natale in Gallura (cfr. sopra) nel gennaio 1894 e poi, 21 anni dopo – rivisto e integrato con alcune note del Natale in altri luoghi dell’Isola – col titolo Il Natale in Sardegna per il libro BOZZETTI E SFUMATURE. Al di là del titolo, come si potrà constatare, il saggio è incentrato sulle tradizioni della Gallura, e principalmente di Aggius.
Il testo che si pubblica è quello del libro, più curato nella forma.
Invece, non vengono riportate le foto ad esso allegate poiché nulla hanno a vedere col contenuto del saggio. A corredo si è scelto di proporre immagini delle Chiese dei paesi citati nell’articolo.
IL NATALE IN GALLURA E IN SARDEGNA
I giorni di festa vanno man mano scomparendo dal nostro calendario per diventare giorni come gli altri, nè più nè meno; soltanto il Natale, la festa non solo della religione cristiana, ma anche della famiglia, dell’intimità, dell’home, che ha un misto di sacro e di profano, di gaudio religioso e di godimento spirituale e materiale, di poesia ascetica e di poesia mondana, di fiabe, di racconti e di reminiscenze, non morrà mai. Non morrà, perchè ha fondamento essenziale nella vita, di cui è un aspetto, di cui è la poesia, e però fa parte del sentimento di tutti i popoli, a cominciare dal primigenio fango animato e finire ai giorni nostri.
Passano i secoli, come passan gli anni; e il venticinque dicembre riunisce tutti, illumina e rallegra tutto.
Non esiste cuore, per quanto scettico sia, che non abbia un palpito più accelerato in questa geniale e serena solennità, gioconda e simbolica, della cui tradizione originale, a voler ritrovare la storia vera, dovremmo frugare in mezzo a tutte le leggende della vecchia umanità, risalendo agli antichi costumi dei popoli nordici, da cui venne quello dell’albero del Natale ne’ lieti paesi de’ quali, scrive il Bencivenni, la fantasia vagheggia panorami sempre verdi, cieli sereni, marine tranquille; risalendo agli Egiziani, che festeggiavano la nascita di Cro; e più avanti ancora, ai nostri primogenitori Ariani, che festeggiavano il nascimento di Agni, là, sul leggendario altipiano del Pamir, tripudiando intorno alla gaja fiammella, che si sprigionava da due legni confricati e che veniva alimentata coll’juma.
Il Natale è una specie d’eco, che ridesta ogni anno nel sentimento i caratteri di tutti i luoghi e di tutti i tempi. La festa dei popoli primitivi, passando a traverso le credenze degli altri popoli, comprese le ultime religiose moderne, coll’andar dei secoli, si è avvolta nella superstizione che è sentimento religioso in regresso ed ha subito molte trasformazioni, rispondenti all’indole particolare di ciascuna popolazione.
Il Natale, ora, ha lasciato molta di quella poesia ideale d’un tempo, che è ancora si viva nei paesi ridenti del Nord. Vi hanno città, in Italia, in cui la festa è un misto di spirituale e di materiale; ve ne sono di quelle in cui essa è tutta materiale, o finisce almeno per esser tale.
La festa scende dallo spirito e si concreta diventando così festa dello stomaco. A Napoli, per esempio, si pensa l’intero anno a questo giorno, e molti fanno a spizzico un deposito nelle mani d’un civaiuolo, perchè alla notte di ceppo mandi loro a casa una cesta piena d’ogni ben di Dio. E chi è, a Milano, a Torino, a Roma, il quale per povero che sia non cerchi d’offrire almeno un umile cartoccio di cioccolatini?
Anche in Sardegna molto si pensa al gran pranzo della notte di ceppo; ma in questa terra, ove le tradizioni sono ancora così vive, gli usi di festeggiare il Natale, pur serbando ovunque un’impronta comune caratteristica, variano di paese in paese, quasi di villaggio in villaggio, miscuglio di reminiscenze un po’ latine, un po’ spagnuole, come in quasi tutte le usanze sarde, ma aventi un profumo agreste e patriarcale.
A Nuoro e nei villaggi vicini, cioè nel cuore della Sardegna, è ignoto quasi del tutto l’albero di Natale, come i bimbi ignorano il passaggio della Befana tra il vento della tenebrosa notte.
La vera festa di Natale si svolge di notte, al ritorno dalla messa, intorno ai crepitanti focolari: l’indomani tutto ripiomba nella solita esistenza, e nulla distingue questa dalle altre feste dell’anno, tranne i regali che si scambiano le famiglie amiche. Popolo per lo più dedicato alla pastorizia, il Nuorese usa quasi sempre regalare carne: l’agnello a Pasqua, il porchetto a Natale.
Non c’è fidanzato che si rispetti, il quale non invii alla sua dama il bel porchetto rosso riempito di fragrante mortella: di notte, dopo essere stati assieme alla messa, dopo aver deposto sulla rorida palma della fanciulla anche una bella moneta d’oro, il fidanzato presiede la cena, della quale forma ornamento il suo grazioso dono. E forse mai la fidanzata saprà che il bel porchetto era frutto d’una piccola rapina! Non sempre, intendiamoci.
Nelle famiglie modeste e pie, s’usa per cena, quando questa avvenga prima della mezzanotte, il tradizionale piatto di maccheroni conditi con salsa di noci. Brutta salsa e brutto piatto, che tuttavia, come tutte le antichità, è l’entusiasmo di certe famiglie patriarcali.
Dopo cena lunghi canti estemporanei: gli arguti versi guizzano come le fiamme dei focolari di pietra scavati nel centro delle cucine: mentre i bambini sognano i loro bei presepi di sughero, di musco e di corbezzolo con le figurine di carta, e le donne addormentano i bimbi con la ninna nanna d’occasione.
Su Ninnicheddu
Non portat manteddu,
Né mancu corittu;
In tempus de frittu
Non narat titia;
Dormi, vida e coro,
E reposa anninia (1)
(1) Il Bambinello – Non ha pannicelli, – E neppure farsetto; – In tempo di freddo – Non dice: ho freddo; – Dormi vita e cuore, – E riposa ninna, nanna.
Si crede a Nuoro che agl’individui nati nella notte di Natale non si scomponga mai lo scheletro.
Strane usanze funebri vanno, in alcuni luoghi del Nuorese e del resto dell’Isola, unite alle gaie usanze di questa notte, che è simbolo di nuova vita. I morti non si dimenticano: anche per loro s’imbandiscono le mense, e mentre la casa è deserta e i vivi pregano nella gran Messa, essi ritornano nell’antica dimora e si assidono silenziosi attorno ai focolari e alle tavole che i vivi preparano pietosamente.
In Gallura, contrariamente all’usanza di quasi tutti gli altri paesi della Sardegna, si mangia subito dopo suonato il segno dell’avemaria, non appena il prete ha benedette una ad una le case dei divoti, con l’aspersorio, che bagna ogni poco nell’ anfora di creta, tenuta dal sacrista che l’accompagna. Questi tiene pure sull’omero un paio di bisacce fantasiosamente arabescate, entro cui si mette l’anfelta: pane speciale di farina bianca, variamente disegnato, del peso d’un chilogramma, che si suol regalare al prete in ricompensa della benedizione da lui data. Si sa: gratuitamente non si danno neanche bastonate, dicono in Gallura!
È notevole, a proposito, questo fatto. Mentre il prete, con la stola che gli pende dal collo e che fa baciare a tutte le persone della famiglia, va di casa in casa, una turba, sempre crescente, di giovinetti lo segue, gridando: Li cozzuli farini!- che vuol dire: i pani di farina. Ed essi tutti cercano di rubacchiar delle legna, quando non vengano loro date spontaneamente, nelle case, per portarle poi dal prete che, finito il giro, regala a ciascuno un tozzo di pane più o meno grosso, a seconda della quantità della legna da lui procuratagli.
Ciò avviene specialmente ad Aggius, dove le tradizioni delle costumanze natalizie hanno una tonalità più spiccata che altrove.
Dopo l’avemaria, dunque, la famiglia, la quale volendo conservare la pancia per la gran cena, non fa che una piccola colazione durante il giorno, ritorna a casa con la letizia nell’anima e l’avidità nel corpo. Trova la mensa piena d’ogni ben di Dio e si dispone a godere, prima di tutto, la festa materiale.
I buoni Galluresi non amano andare alla Messa se non hanno lo stomaco ben pieno. Non si può aver diritto d’invocare da Dio la gloria del Cielo, se non dopo essersi procacciata un po’ d’allegrezza e di felicità in terra. E la felicità non può mancare in quella sera, dopo aver mangiato i classici saporitissimi chjusoni, specie singolare di gnocchi, somiglianti, benchè assai più grossi, ai mallureddus del Campidano. Ad essi fan seguito, senza posa, varie e diverse pietanze – secondo l’agiatezza delle famiglie – nonchè mostaccioli, uve, fichi secchi, niuleddi, cucciuleddi, cato, pan di sapa e molte altre specialità di dolci confezionati in casa, che non sono punto inferiori, per gusto e profumo, considerati nella loro varietà, all’aranciata di Nuoro, ai torroni di Cremona, alle focaccine di Vicenza, alle mortadelle di Bologna, al capitone di Napoli, al panettone di Milano – gloria immortale del cuoco geniale di Ludovico il Moro, come dice Vittorio Giglio – al panforte di Siena, ai biscotti di Novara, agli amaretti d’Oristano, alle stiacciate di Livorno, ai castagnacci di Pistoia, ai pabassinos del Campidano e via via. E tutto ciò che appare in tavola deve esser finito ad ogni costo, giacchè quella notte si deve mangiare…
Ad Aggius e a Bortigiadas le mamme sogliono ammonire i figlioletti che nulla dei cibi preparati deve restare sulla mensa, perchè allora guai! una brutta strega Palpaccia metterebbe loro, mentre sono a letto a dormire, una grossa e dura pietra nello spazio del ventre rimasto vuoto. Così, con questo timore, gli assalti a tutti i cibi sono formidabili, e il benessere del corpo, dopo che si è pensato al Deus venter, appare, vedendo il fondo all’ultimo bicchiere di vino eletto, lo spumante moscato di Tempio, ove stanno i lucidi sogni e le gaie fantasie.
Allora, seduta intorno al focolare, rallegrato dal Ceppo che sprizza barbagli d’oro e dà il nome alla solennità, la famigliuola si abbandona alle soavi tenerezze, ai lieti entusiasmi…
Le vecchie narrano le fole più geniali ai vispi folletti dei nipotini, e questi in fine si appisolano mollemente, seduti per terra, accanto a un alare o abbracciati alle ginocchia delle nonne. Le quali, a questo punto, cessano le care narrazioni per posare le labbra sulle pure fronti di quelle piccole anime, cui vigilano il sonno, seguendone il lene respiro o le grida mandate in un eccesso d’infantile sonnambulismo. Qualcuno, infatti, nel sonno, sogna Palpaeccia, la strega descrittagli a tavola dalla mamma, una vecchia brutta, sformata, col naso adunco, il mento aguzzo, l’occhio in fossato, dallo sguardo sinistramente scintillante, che porta una pietra nera come l’ebano tra le mani e gliela vuole ficcare nella pancia… il bambino grida, manda suoni inarticolati che gli strozzano la gola, schermendosi colle piccole braccia protese, e finisce per svegliarsi, spaurito, con gli occhi stralunati, guardandosi attorno, sotto l’incubo penoso prodotto dalla sognata stregaccia…
Brutte conseguenze, per i bambini, prodotte dalla troppa tenerezza delle mamme ignoranti!
Le case delle belle ragazze però sono dei centri, ove si radunano a veglia i giovanotti d’ambo i sessi del vicinato, e chi chiacchiera del più e del meno, chi passa in rassegna la cronaca nera, chi si diverte a fare…. un mondo di giuochi, basati quasi tutti su credenze superstiziose, i quali hanno per iscopo di palesare, secondo la loro credenza, due innamorati o due che diventeranno tali.
Fra i tanti ne accennerò alcuni. Dui omini o dui femini c’à in un puzzu, è uno dei giuochi più in voga. Il giovine cala in un pozzo, idealmente, due altri giovani, presenti o no, che siano ben conosciuti dalla ragazza, la quale estrae il preferito. Quanto ha fatto il giovine, viene poi ripetuto dalla donna che alla sua volta manda nel pozzo due ragazze.
A Luras è in voga particolarmente questo. I giovanotti d’ambo i sessi, radunati come ad Aggius, fanno delle ajuoline fra la brace ardente del focolare e vi mettono due foglie d’ulivo: una segnata rappresenta l’uomo, l’altra la donna, che vengono indicati da chi presiede al giuoco. Naturalmente le foglioline verdi, oppresse dal vivo calore che penetra nei loro tessuti pieni d’umore, crepitano. Se poi, nello scattare che fanno, si toccano o si sovrappongono, significa (il popolino ci crede fermamente) che il matrimonio, massime nell’ultimo caso, si debba effettuare fra i due rappresentati dalle foglie. Avviene, difatti, che alcune coppie, spinte forse alla simpatia reciproca da queste pure combinazioni, finiscano, per effetto di suggestione, per amarsi e sdrucciolare davvero…. verso il matrimonio.
Lu jocu di li sii si fa in parecchi paesi della Gallura. Esso consiste in questo: uno traccia tanti solchi, sulla cenere del focolare, quanti sono i compagni, facendo in cuor suo corrispondere ad ognun d’essi una ragazza. Ogni compagno sceglie, a turno, il solco che vuole, dopo di che si svela il nome della ragazza che la sorte gli ha assegnato e se ne trae il presagio del matrimonio.
Si usa pure di mettere tre fave entro un bussolotto: una con la buccia, una senza e la terza semisbucciata. Di tre giovanotti, ognuno sceglie la sua. La prima è pronostico di moglie vestita (ricca), la seconda di moglie nuda (povera), la terza di moglie non ricca nè povera.
In alcuni paesi si usa pure mettere due granelli d’orzo a galleggiare entro una catinella piena d’acqua. Un chicco rivestito delle glumelle, con la resta rivolta all’insù, rappresenta la ragazza; l’altro l’amante. Entrambi vengono gettati nell’acqua, uno dopo l’altro, imprimendo a questa, con l’indice, una corrente a vortice, che trascina i chicchi; se l’ultimo raggiunge il primo, i due giovani si sposeranno.
Si fanno altri svariati passatempi e tutti hanno per fine, eterno perno, l’amore, per ammazzare le ore che li separano dalla messa, mentre la fiamma scoppietta allegramente e le scintille, sprigionate dal grosso ceppo, destinato ad ardere tutta la notte, e che i fanciulli ancora desti stuzzicano, per arrostirvi sotto castagne o ceci, si inseguono numerose sotto la gran cappa di granito, tappezzata nell’interno di fuliggine. Non è rara la casa, però, in cui si trova qualche dormiglione che a questi sollazzi preferisce schiacciare un sonnellino sur un pancone fra le ondate delle risa argentine delle belle galluresi, che sonoramente gli servono di nenia.
Verso le dieci suona il primo tocco della campana, in un modo affatto speciale; e allora in alcuni luoghi si recitano i così detti minais; due filastrocche di parole e frasi, qualche volta in rima fra loro, senz’alcun nesso logico, tolte per lo più dall’evangelo di Cristo e dai riti cristiani.
Uno di essi, il primo, detto ad Aggius e a Bortigiadas Li dodici apostuli, si crede sia stato recitato per la prima volta da Cristo, sotto spoglie di mendicante, in casa di una ragazza, mentre ella attendeva, con gl’invitati, lo sposo. Il quale era il diavolo travestito e sconosciuto da tutti, che aveva saputo conquistare il cuore della giovane e, fingendo di condurla a nozze, l’avrebbe portata all’inferno, se Cristo non l’avesse salvata recitando il minsis che ebbe la virtù di pietrificare Satana e il suo seguito. Una leggenda simile esiste nel Bolognese e in qualche altro paese del continente, ma riferentesi a San Martino anzichè a Cristo.
Il secondo minsis, composto di nove versi, è tratto da cose non religiose e nell’assieme insignificanti; e si crede detto da S. Martino, in occasione pure di nozze, per scacciare il diavolo.
Questo è meno noto del primo, il quale è saputo da tutte le vecchie che, come ho detto sopra, al primo rintocco di campana lo recitano, convinte che abbia maggior potenza di tutte le altre orazioni.
Oltre che nella sera del Natale, questo minzis viene recitato durante l’anno in occasione di pericoli e di temporali, per scongiurarli. Parecchi affermano che chi lo recita salvi la propria casa e sette altre delle più vicine. Taluni lo recitano tutti i giorni, prima di levarsi. Se lo dicon bene saranno esenti, nella giornata, da ogni pericolo: se fanno anche un solo sbaglio non mettono piede fuori della porta perchè sono certi d’incorrere in qualche disgrazia.
In diversi paesi si crede che nella notte di Natale soltanto si possano insegnare o imparare con efficacia certe parole segrete atte a guarire, quando vengono recitate, il mal di ventre, il dolor di testa, ecc. Vi sono pure delle parole che incantano ossia fermano gli incendi, le quali vengono insegnate nei giorni che corrono dal Natale al capo d’anno; non in altro tempo, perchè si crede che si perderebbe la virtù di esse per parte di chi l’insegnasse e di chi l’apprendesse.
A Santa Teresa e alla Maddalena, paesi marittimi, pur si crede che solo in questa notte possano apprendersi efficacemente le parole forti per iscongiurare le trombe marine, tal quale come si crede in Palermo e in altri paesi della riviera sicula; come pure il responsorio di Sant’Antonio in dialetto, che fa ritrovare le cose perdute.
Verso le undici, lo scampanio lieto del terzo rintocco (il secondo suona mezz’ora prima) invita i fedeli e… i non fedeli; e tutti accorrono alla gran messa notturna che ha la virtù di compensare tutte quelle che ognuno ha perduto durante l’anno!
La chiesa, nell’ombra, è solenne, mentre l’altar maggiore, con tutte le candele accese, spicca nello splendore, che gli arredi sacri dorati riflettono, abbarbagliando la vista della folla che si riversa dentro come una fiumana.
Si cominciano gli officii divini, e intanto il popolino aggese che s’è portata nelle saccocce una buona provvista di mandorle, di noci, di nocciole, di mele, di castagne, di fichi secchi, nonchè di zucche ben piene, cerca riempire il vuoto dello stomaco che s’è effettuato con la prima digestione. Dappertutto, ove è una lastra di pietra, e persino sui mattoni, si sente il rumore prodotto dallo schiacciamento delle noci e delle mandorle.
Quando un prete va per la prima volta in un paese, si arrabatta per far cessare lo scandalo, ma è come pestar l’acqua in un mortaio: tutti restan sordi ai suoi avvertimenti, se pur non lo pigliano in giro, ed egli finisce per lasciar correre… le vecchie consuetudini, come han fatto i suoi predecessori.
Ma già è mezzanotte. La messa incomincia, e, alla prima nota del Gloria in excelsis, parte della folla picchia coi piedi o con ciottoli sui banchi, sui confessionali, sui genuflessorii, sulle predelle degli altari minori, nascosti nella penombra.
Dei banchi anzi, in un paese vicino a Tempio, qualcuno viene rovesciato ed io stesso vidi, una volta, andare per terra quanta gente vi stava seduta. Altri si divertono a lanciare in aria dei cerini accesi. Altri ancora si danno delle spinte, giuocano a scappellotti o a pugni e le donne, che stanno inginocchiate o accoccolate sui mattoni, si urtano l’una contro l’altra[1].
Insomma, della casa di Dio si fa in quella sera, per antica costumanza, una casa del diavolo.
E dopo la messa dei vivi, dice il popolino aggese, incomincia quella dei morti. Guai ad alcuno che rimanga in chiesa, mentre essa viene officiata da trapassati! Ond’è che ognuno cerca con cura tutti i suoi, e i ragazzi, all’uscita, si attaccano alle sottane delle mamme o al giubbone dei babbi. E se una vecchierella si è, per caso, addormentata in un angolo, è carità lo svegliarla.
In Aggius, si narra appunto che un pover’uomo, essendosi addormentato sur un banco, rimase in chiesa, e quando si destò, la vide piena di morti. Sull’altare uno di essi officiava, offerendo a Dio, invece di calice, una catena di nudi teschi. Intanto, il vivo, non sapeva che pesci pigliare. Un suo compare, già morto da alcuni anni, gli si avvicina e gli dice che, se vuole salvarsi, quello è il momento opportuno. Colui non se lo fa dire due volte: balza in piedi e se la dà a gambe. Mentre apre la porta di chiesa, alcuni morti, che alzano la testa, lo scorgono, e gridano: Al vivo! al vivo! Tutti allora lo inseguono, e sul piazzale lo afferrano pel giubbone d’orbace. Egli, lesto, se ne sveste, lo lascia nelle loro mani e fugge sano e salvo sino a casa. La mattina di poi, quando ne va in cerca, lo ritrova sul piazzale della chiesa, completamente ridotto in lana.
Altri fatti si narrano pure, l’uno più strano dell’altro, per convalidare tali credenze.
Del resto, che i morti durante li missi di dinotti, sorgano nelle altre chiese, mentre si funziona alla principale, dalle arche, e facciano attorno attorno la loro ridda, è credenza comune in Sardegna.
A Tempio v’è chi afferma d’averli visti all’antica chiesa del Carmine.
A Nuchis molti sostengono di aver sentito il vento prodotto dal loro passaggio, scendendo dalla chiesa di S. Cosimo e Damiano, nelle vie, alle due dopo la mezzanotte.
A Bortigiadas, dicono d’aver sentito il lezzo che esala dai funebri lenzuoli nei quali si avvolgono.
È pure credenza comune che verso le tre del mattino passi per le vie, in processione, la regula [reula], a Tempio detta trajgoggju: una confraternita di morti, che spesso prendono la forma di cani o di altre bestie, tutti d’un colore e della stessa grandezza; oppure escano li fuglietti: gli spiriti folletti. In Tempio veramente si crede o si credeva, prima che la civiltà avesse, come ha in gran parte, snebbiato la mente del popolo dalle superstizioni, che lu trajgoggju esca nella mezzanotte del primo di agosto, correndo e trascinando dietro di sè delle pelli senza conciare o altro che produca del rumore secco.
A queste credenze danno origini o pascolo, talvolta, certe allucinazioni che paiono fatti veri o certe combinazioni.
Così, si racconta che, appena finita la messa, anzi verso le due del mattino, un anno fu vista alla porta della chiesa di Luras, da diversi giovinotti, che andavano in giro facendo delle serenate, una donna grassa, alta, nera, la quale impauri e fece fuggire i serenatanti, con gesti e mosse da fantasma.
Non fuggirono però tre barracelli, capitati dopo, i quali misero lei in fuga, inseguendola; ma quando il più svelto dei tre le fu alle spalle, ebbe paura anche lui temendo che la negra figura di donna fosse una morta, tanto più vedendola saltare il muro del cimitero con un’agilità da cerbiatta e andar dentro in un baleno. Un ultimo slancio di coraggio vinse però anche i barracelli ad entrarvi e ad inseguirla ed afferrarla… cioè no, non ad afferrarla, perchè ad un certo punto ella si ferma e spiana loro in faccia una rivoltella… Era una viva e di che genere!
Un altro fatto vien pure narrato ad Aggius, e cioè che un pastore arrivasse in paese, per la via del cimitero, verso la mezzanotte. Una cinquantina di metri prima che giungesse al camposanto, vide un bambino che piangeva dirottamente, dicendo che i compagni l’avevano abbandonato. Egli allora lo fece montare sulla groppa del suo cavallo. Arrivato alla porta del cimitero, la bestia, che già camminava affannosamente, si fermò ed egli si accorse, coll’animo smarrito, che quel bambino aveva le gambe lunghe sino al punto in cui l’aveva raccolto: ció significava, anzi spiegava che costui fosse il diavolo. Fece allora la croce ed uno speciale scongiuro e lo fe’ sparire.
La fantasia del volgo colorisce stranamente queste leggende, e alcune circostanze fanno scorrere entro le fibre il terrore.
In Alghero, durante la messa, un frate sale sul pulpito e predica in puro dialetto catalano, agitando nella mano una spada lucente, simbolo della giustizia divina, che tutti aspetta nel giorno terribile del giudizio universale. La predica stessa è chiamata dagli Algheresi Su giurissi, il giudizio, e in quel bel linguaggio catalano, inteso da pochi, v’è alcunchè di misterioso, come se le parole dovessero assumere un significato, alla mente sola degli eletti. Del resto quella spada rappresenta una memoria storica. Fu regalata al capitolo della diocesi dal Re Carlo V, come a indicare che la chiesa è la sola e vera ministra di giustizia sulla terra.
A Bonorva e nei vicini paesi, come in tutti gli altri paesi dell’Isola, veramente sono, con qualche variante, gli stessi usi e costumi, con questo che ora, specie nella gioventù, è scemata l’antica fede degli avi sulla così detta Missa de puddu.
A Terranova, per esempio, non c’è di rimarchevole quasi nulla, se si eccettuano le schidionate di carne arrosto che qualche comitiva di buontemponi suol fare dopo la messa.
Un anno a Bonorva non si curarono neanche di celebrare la gran messa ed è nota la strofa:
Bonorva in su peccadu ses ancora
Senza ti cherrer mai riduire,
Tottu su mundu lu devit ischire
Qui has perdidu sa missa de s’aurora.
Alle donne poi che, fra un’Ave-Maria e l’altra, s’appisolano, quelle che stanno alle spalle cuciono la gonna attaccandogliela a quelle delle vicine, con quanta ilarità quando esse si svegliano è da immaginarsi.
[1] Nella Barbagia di Seulo e specialmente a Seui, se si eccettuano gl’infermi e i vecchi impotenti a muoversi, nessuno va a letto la notte di Natale, perché dopo aver divorato castagne, noci e nocciole, aver giocato col girlo e bevuto fin troppo di quell’eccellente vino, tutti vogliono assistere alla gran messa, nella chiesa principale. E ei vanno, infatti; ma fino al momento dell’elevazione, mentre fuori della sagra si sparano razzi, mortaletti e bombe, dentro si lanciano l’un l’altro le frutta secche, di cui han piene le saccoccie, fra grandi risate e schiamazzi.
Il gran giorno spunta finalmente, e i figliocci e i nipoti vi si presentano a chiedervi la strenna del Santo Natale, mentre vi fanno un lieto augurio. Voi rispondete all’augurio dando loro una moneta di mezza lira o d’una lira o di cinque lire. E tutta qui finisce la gioia dei ragazzi, che maggiormente si esplica nella gran cena, gioia che s’accomuna negli adulti, in un contento pio e tranquillo, mentre si espande nelle allegre libazioni del pasto, fra le copiose vivande e i dolciumi di cui fumano e odorano le capaci mense.
Ad Aggius è antica consuetudine cantare, alla messa dell’aurora, il seguente inno intitolato: L’anninna di lu Puppu bellu (la ninna nanna del Bambino bello) che credesi tramandato da Maria Vergine, la quale si vuole lo cantasse ninnando il piccolo Redentore:
O Deu, ninnu meu,
Beddu piu di l’oru.
Supra la dura padda
Vidisi ch’era natu,
E mi parisi un celi
Di stelli curunatu,
Da soli accumpagnatu
Supra un mannu decoru.
O Deu, ninnu, ecc.
La mamma illu mirallu
Amurosa dizia:
Vita di la me ita,
Drommi la me’ alligria;
Funtana sempri ‘ia
D’abbundanti tesoru.
O Deu, ninnu, есс.
Caglia, ninnu, caglia,
Chi tempu ‘enara,
Candu illa dura cruzi
Ciudatu hai a ista;
E tandu hai a prua
Un crudeli disdoru.
O Deu, ninnu meu,
Beddu più di l’oru. (1)
(1) O Dio, pargolo mio – Bello più de l’oro – Sopra la dura paglia – Vidi ch’era nato – E mi parve un cielo – Di stelle coronato – Da soli accompagnato – Con un gran decoro – La madre nel mirarlo Amorosa dicea: Vita de la mia vita – Dormi, la mia allegrezza; – Fontana sempre viva – D’abbondante tesoro. – Taci, bimbo, taci, – Che tempo verrà, – Quando sulla dura croce Inchiodato starai – E allora proverai – Crudel martirio.
La forma di quest’inno e la metrica si scostano dalle poesie dialettali d’oggi, tanto che solo riscontransi nelle laudi religiose antiche del primo quattrocento.
Prima di finire giova accennare alle Carènnuli di Natali. come vengono dette in alcuni paesi della provincia di Siracusa le calende di Natale, ossia i dodici giorni che ne precedono la notte. In Gallura si chiamano Conti romani, ma cominciano dal primo giorno dell’anno. Come in quei luoghi, il nostro popolo crede di indovinare il tempo di ciascun mese dell’anno raffigurando in ogni calenda un mese: nella prima il gennaio, nella seconda il febbraio e così via.
Dalle condizioni climateriche d’ogni giorno delle calende il popolo trae presagio per il tempo che farà in ognuno dei corrispondenti mesi dell’anno.
Questa credenza si approssima a quella dei Siracusani e a quella dei contadini danesi.
Fra gli usi e i costumi di questa festa, fra le strane leggende e le superstizioni del popolo, l’esultanza aleggia in tutti i cuori, le vecchie amicizie si riaffermano, i nuovi vincoli si stringono, qualche volta, anche nel Nuorese, anche nella Gallura dove gli odi come gli amori sono più tenaci, vibrano le corde del sentimento e la pace fiorisce in tutti gli animi.
FONTI DELLE ILLUSTRAZIONI
https://beweb.chiesacattolica.it/
https://chiesedisardegna.weebly.com/nuoro-parrocchie.html
Cattedrale di Tempio – di Vittorio Ruggero
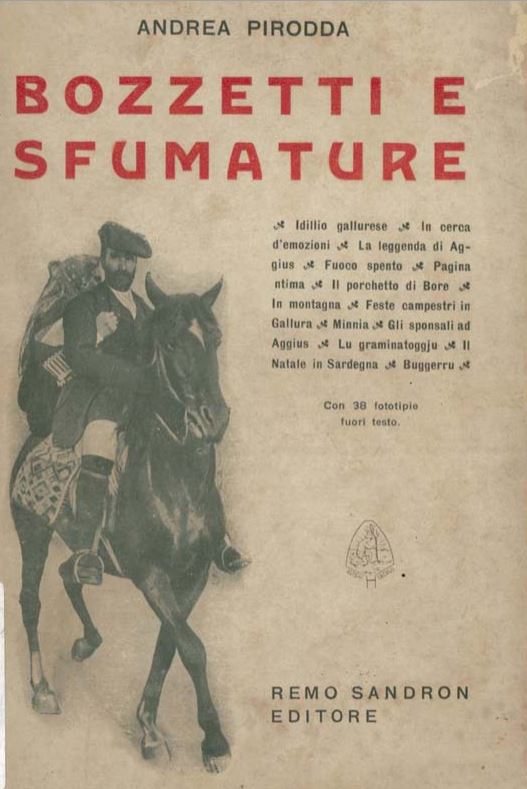
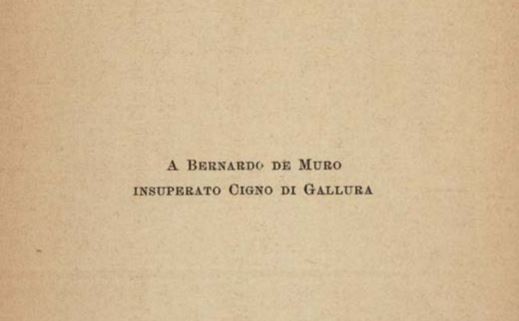
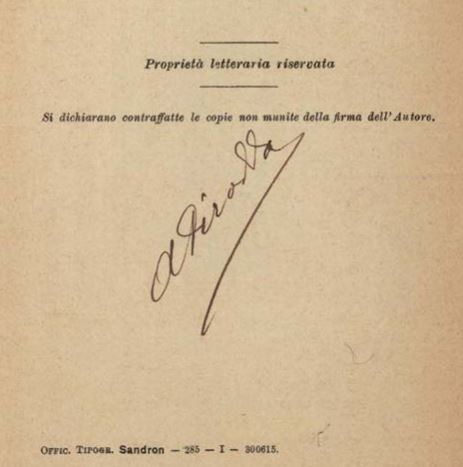
SUL NATALE IN GALLURA SI VEDA ANCHE:
© Tutti i diritti riservati












